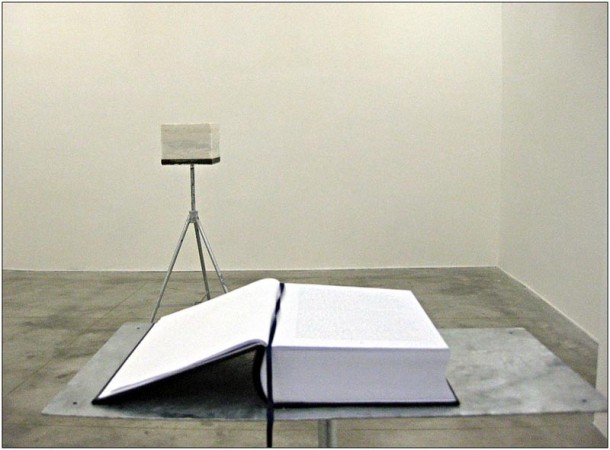
Francesco Arena, Riduzione di mare
Riprendo dopo vari mesi la riflessione avviata con il post inaugurale di questa rubrica. Qui a Zibaldoni si sapeva che in seguito mi sarei ritirato nel silenzio, e ho trovato comprensione per la mia impasse. Un collaboratore della rivista, in particolare, si è mostrato particolarmente caloroso, raccomandandomi di non mollare, letteralmente di «tener testa agli spettri del presente», ché lui avrebbe atteso fiducioso il mio prossimo «trapasso». Chissà cosa voleva dire.
In effetti dopo quel breve periodo di scrittura, in cui oltre al post inaugurale sono nate due recensioni per un quotidiano, sono rimasto fermo per un po’. Ogni tanto tornavo a rileggere quell’ultima mia traccia on line, cercando fra le righe qualche risposta alle mie stesse domande, ma invece accadeva un’altra cosa: faticavo sempre di più a riconoscermi nel mio smarrimento. Voglio dire che il presente lavora, ci plasma con un’abilità e una rapidità sorprendenti. Così anche le incertezze del momento, che pure – come ho notato da poco – proseguivano nel solco di quelle che avevo già espresso in un altro testo per Zibaldoni quindici mesi fa, sbiadivano sotto la pressione dei fatti.
Primo fatto
Una delle due recensioni di cui ho accennato mi era stata commissionata, ma dopo che l’avevo scritta – non senza difficoltà, poiché si trattava di un brutto libro, la lettura più penosa che mi fosse capitata da molto tempo – la redazione l’ha respinta, con molte e imbarazzate scuse, in quanto troppo critica, non sufficientemente diplomatica. Già, perché il libro in questione è firmato da un Vip molto influente, tanto che io stesso, durante la lettura e nella fase preparatoria dell’articolo, ero rimasto sbalordito dalla maldestra neutralità o dalla scandalosa approvazione che emergevano invariabilmente dalle recensioni che apparivano via via sulle maggiori testate. Possibile che nessuno avesse il coraggio di dire ciò che andava detto, e cioè che si trattava di un cattivo libro, scritto male, noioso, perfino nocivo? E se anche il quotidiano per il quale avevo redatto la mia recensione, che si era sempre vantato della propria libertà e indipendenza – effettive, poiché fino a quel momento avevo sempre potuto scrivere ciò che volevo –, se anche quel quotidiano era arrivato al punto da respingere un articolo per non contrariare un potente, che ci scrivevo a fare?
Nel frattempo, tuttavia, avevo iniziato a leggere un altro libro, un saggio di critica letteraria molto bello e competente, sicché ho deciso di congedarmi dalla pubblicistica, almeno questo, con una recensione positiva, la seconda delle due che ho menzionato. Il quotidiano ha pubblicato subito quest’altro articolo, più in fretta del solito, quasi a compensazione dell’incidente di prima, ma da allora non ho più scritto altro. Epilogo: la recensione al libraccio del Vip è stata poi ospitata da un noto sito di letteratura e cultura, che l’ha accolta con gratitudine, e io mi sono sgravato non senza sollievo da un ambito, quello della pubblicistica letteraria su carta, di fronte alla cui crescente irrilevanza per le sorti della letteratura le mie ansie da estinzione impallidiscono.
Secondo fatto
L’editore con il quale un anno e mezzo fa avevo firmato un contratto per pubblicare un’opera narrativa, a un certo punto mi ha chiesto di rimettervi mano. Si trattava di renderla in qualche modo più godibile, meno di nicchia, di rivedere i personaggi conferendo loro una rotondità più tradizionale, di reimpostare la storia in modo da creare una trama più solida. All’inizio ero perplesso: sto per prostituirmi? Per tradire le mie intenzioni estetiche in nome di una vendibilità commerciale che finirà per ritorcermisi contro? Mi sbagliavo. È stato un lavoro arricchente, più divertente di quanto sperassi e davvero utile. Soprattutto mi ha riportato, per qualche settimana, alla scrittura. Lavorare per un fine – tentare di migliorare un testo in vista della pubblicazione – non dissolveva i miei dubbi, ma mi permetteva di metterli da parte per un po’, insomma: di fregarmene.
Ecco un modo per superare la paralisi: agire, buttarsi, fiduciosi che in qualche maniera le proprie questioni irrisolte contribuiranno a orientare, a forgiare in positivo il lavoro di scrittura. Se siamo figli del nostro tempo, per quanto in esso ci sentiamo stranieri, i nostri sforzi serberanno comunque le tracce del nostro bisogno di ospitalità: tanto vale non lasciarli intentati. Se a guidarci è sempre innanzitutto la fedeltà a noi stessi, ogni compromesso apparente si rivelerà un arricchimento sostanziale. Così pensavo di fronte alla nuova versione del mio romanzetto. Ero decisamente più soddisfatto di prima e riconoscente all’editore per avermi indotto a lavorarci. Di conseguenza ero anche convinto che stavolta il testo sarebbe finalmente andato in stampa.
Mi sbagliavo. La lingua, lo stile e certe soluzioni formali erano ancora «troppo esigenti ed elevati rispetto alla storia che raccontavo». In altre parole il problema era che, anziché raccontare “facilmente” una storia, insistevo nel farne letteratura, ossia roba per pochi, inaccessibile a molti. E questo in un momento in cui le vendite, i lettori, la collana, la narrativa italiana ecc. ecc. Così, di comune accordo, abbiamo deciso che il libro non uscirà – perché io stesso preferisco non pubblicare con un editore che non crede nel mio lavoro. Epilogo: da quel giorno mi sento un po’ meno scrittore per gli altri e un po’ più amante qualunque della letteratura, il che, quando non è doloroso, è liberatorio – e la libertà, a conti fatti, è la cosa a cui tengo di più.
Digressione
Ricordo le prime volte che ebbi a che fare con internet, nella seconda metà degli anni novanta. Ricordo più di ogni altra cosa l’impressione della velocità di lettura alla quale, per una causa tecnica che ancora oggi non so spiegarmi, mi sentivo costretto da quelle prime, rudimentali pagine scorrevoli sullo schermo. Era una velocità disumana, alla quale non ero abituato e nella quale mi sentivo trascinato controvoglia. Oggi, quindici anni dopo, non mi accorgo più di nulla. Sono un lettore velocissimo e superficiale, immagazzino pochissimo di ciò che leggo, ma leggo molto e in modo molto caotico, soprattutto nei periodi in cui l’attualità s’impone su qualsiasi altra forma verbale appena meno informativa. Da questo punto di vista, periodi come quello seguito alle ultime elezioni sono autentiche guerre imperialistiche scatenate contro ciò che resta della nostra facoltà contemplativa. Una simile mobilitazione dei sensi, quando coinvolge anche istanze profonde come quelle morali o politiche, sancisce la morte del raccoglimento, della concentrazione.
Distrazione
Quando Benjamin parlava di «percezione distratta», cogliendo qualcosa di positivo nel fatto che fosse la massa ad accogliere l’opera d’arte nei propri ritmi e flussi, anziché l’opera a far sì che l’individuo contemplante sprofondasse in essa, non si riferiva all’arte verbale, ma ad arti “osservabili” come il cinema, la fotografia o l’architettura. Chissà, forse preannunciava anche le centinaia di visitatori che ogni giorno al MoMa di New York si assembrano senza sosta davanti all’Urlo di Munch, intenti a fotografare l’opera celebre con la microcamera senza flash dei loro smarthphone per poi allontanarsi imperturbati dopo il click simulato dai loro feticci, completamente ignari della Madonna puttana e della Ragazza malata del medesimo artista che, dietro la stessa parete assediata dai loro obiettivi, irradiano forza, pena e angoscia verso i pochi solitari che hanno la scellerata bontà di far loro visita.
In ogni caso, l’arte verbale non tollera una simile fruizione distratta se non al prezzo di trasformarsi in informazione, cioè di smettere di essere arte. Del resto è quello che sta succedendo: affinché un testo letterario – racconto, romanzo, saggio, perfino poesia – sia letto da più di una manciata di appassionati e specialisti, la sua lingua dev’essere il più referenziale e anonima possibile, ossia deve abdicare alla forma, allo stile, all’espressione, per andare incontro al palato ormai diseducato al gusto di quello che Saul Bellow, lui sì riferendosi anche alla letteratura, in un bel saggio scritto oltre mezzo secolo dopo Benjamin chiama «pubblico distratto»: distratto appunto dall’industria dell’informazione responsabile «del nostro particolare pseudosapere, dello spessore della nostra ignoranza». E la pena per chi non rispetta questo parametro di referenzialità, per chi non scende a patti con questa ignoranza non è più, come ancora qualche decennio fa, l’insuccesso presso quello stesso pubblico – insuccesso che al limite poteva venir compensato dalla considerazione dei pochi con i quali si condividevano la passione e il codice –, ma direttamente la non-pubblicazione: la pubblica inesistenza.
Davvero: conosco scrittori di valore che faticano a trovare editori per le loro nuove opere non solo perché non sono Vip o almeno autori sufficientemente popolari da garantire comunque un minimo di vendite; non solo perché non sono più giovani in un mercato editoriale che fa della giovinezza, come del bell’aspetto, un fattore di miglior vendibilità; ma anche proprio a causa delle ambizioni estetiche dei loro scritti. E non si tratta soltanto di dis-prezzo in senso etimologico, ossia di una valutazione negativa del loro potenziale commerciale, ma anche semplicemente di incompetenza, dell’incapacità culturale di gustare le loro opere. Per questo mi dico: forse non è più lì, nell’editoria tradizionale alle prese ormai unicamente con la propria sopravvivenza economica, che l’arte verbale può cercare e trovare un futuro. E neppure nelle forme che con quell’editoria tradizionale sono nate e si sono sviluppate. Oggi solo i rari esemplari di una specie in via d’estinzione arrivano a leggere per intero Alla ricerca del tempo perduto, Giuseppe e i suoi fratelli o Guerra e pace, o anche solo il Don Chisciotte, Gargantua e Pantagruele, il Tristram Shandy, L’uomo senza qualità o Horcynus Orca. E il solo modo per leggerli ancora, che è anche la sola forma di distrazione concessa alla fruizione letteraria, è mutatis mutandis quello che Gianni Celati suggerisce per la sua recente traduzione dell’Ulisse: «non avere fretta e… non è importante capire tutto: è più importante sentire una tonalità musicale o canterina, che diventa più riconoscibile quando ci sembra di piombare in un flusso disordinato di parole». Vale a dire, in concreto, che oggi più che mai, sovrastimolati come siamo e sempre in deficit di tempo e concentrazione, dobbiamo accontentarci di una lettura spezzata, amatoriale e vagamente inebetita, sospesa fra senso e suono, una lettura che rischia ogni volta di farci perdere il filo e non ci permette di approfondire ogni aspetto, quindi ci condanna a non percepire mai l’opera nella sua totalità.
* * *
Ho sottoposto il testo qui sopra, prima di tentarne una conclusione, al collaboratore di Zibaldoni che qualche mese fa mi aveva manifestato con particolare calore la sua solidarietà. L’ha letto e, invece di dirmi se vi ha scorto gli indizi di un mio «trapasso», si è preso la libertà di propormela lui, una conclusione – a patto di rimanere anonimo. La riporto volentieri, se non altro per debito umano, benché mi sembri fraintendere un poco il mio discorso e mi appaia viziata da un certo filosofismo:
Se vogliamo serbare all’arte verbale una pretesa di totalità afferrabile anche da chi ne fruisce attraverso un atto di lettura, dobbiamo accettare che essa muti e si presentifichi a contatto con i ritmi e i flussi della digitalizzazione. Alle condizioni odierne, infatti, non può esistere totalità se non in una sineddoche radicale, in una forma in cui la parte alluda al tutto nello stesso istante in cui sembra rinunciarvi, e in cui tale rinuncia si palesi innanzitutto come revoca apparente del proprio anelito a valere e durare. Insomma: lavorare per mezz’ora a un tweet di 140 caratteri prima di inviarlo nel mondo virtuale può essere forse ridicolo, velleitario, perle ai porci; ma di certo non è insensato, se è l’inizio inconsapevole di una palingenesi poetica.

 An awesome place I’ve slept - Stefano Zangrando
An awesome place I’ve slept - Stefano Zangrando Picaro qua, picaro là - Claudio Morandini
Picaro qua, picaro là - Claudio Morandini Il delta - Kurt Lanthaler
Il delta - Kurt Lanthaler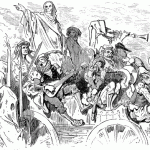 Don Chisciotte disoccupato - Stefano Zangrando
Don Chisciotte disoccupato - Stefano Zangrando Eudemonia lagarina.
Eudemonia lagarina.  La necessità cieca della tragedia
La necessità cieca della tragedia Immàginati un canto
Immàginati un canto





















