
Fotografia di Francesca Andreini
Ero a Baltimora coi miei figli e il loro padre, suo fratello, la moglie e la loro bambina. Una giornata di sole e di freddo, tutta tersa e piena di luce, di vento e di voci portate.
Baltimora è vicina a Washington, è piccola e sta sul mare. È una delle città più antiche, una di quelle dove si è fatta la storia e dove le famiglie vanno in pellegrinaggio a imparare i Fatti.
Che qui devono essere stati parecchio importanti, viene subito da pensare, se sul pennone più alto che si sia mai visto, là perso nel cielo oggi azzurro e sventolante sul vento oggi vigoroso, troneggia una bandiera enorme grande come una nuvola, come un’idea, come la storia stessa.
Bisogna salire sul colle fortificato, dove i mattoni rossi corrono ancora intatti e compatti su e giù per i ramparti e celano ancora le celle dove venivano rinchiusi i prigionieri e contengono ancora, i mattoni, le stanze degli ufficiali, coi manichini vestiti da ufficiali, e gli stanzoni dei soldati, con le brande dei soldati, e le santabarbare, le feritoie, i cannoni.
Un posto esteso, curato e soleggiato, dove i bambini scorrazzano e si divertono a provare tutte le stanze e i loro ricordi. Dove gli adulti affannano su e giù per le scale e prendono foto, sorridendo tutto il tempo.
E dove finalmente ci si mette in contatto con il ranger di turno che ci spiega a che ora potremo cominciare il giro guidato per ascoltare la spiegazione dei Fatti.
Altre due foto, due colpi di vento e ci siamo anche noi, nella truppa all’ascolto del ranger. Arriviamo con qualche secondo di ritardo e li troviamo già lì, gli ascoltatori e il ranger spiegatore, tutti raccolti alla base della bandiera grande come un’idea mai vista prima. E quel che vediamo, anche, è davvero inedito perché il ranger e i visitatori stanno tutti in un rettangolo esteso, e reggono in mano, ciascuno con entrambe le mani e lo sguardo attento, una bandiera esatta esatta come quella che sta sul pennone sopra di loro. Noi restiamo fuori da questo rettangolo ordinato, quattro angoli retti di attenzione compatta. Siamo stranieri, in fondo, ed è evidente che questi non stanno tenendo in mano solo la replica della prima, famosa bandiera, ma anche tutti i fatti, i fischi di cannone, le grida e le conquiste, i viaggi, le tende, i binari e i setacci che sono venuti dopo, e che a vederli lì, immobili e concentrati, sembra qualcuno li abbia cuciti insieme alla trama della stoffa, tutti i Fatti dell’America, e che questo rettangolo di visitatori lo stia leggendo sui singoli fili come un disegno.
Allora noi continuiamo a tenerci in disparte e a fare foto, sorridendo. E data la distanza e il vento e l’accento locale del ranger che non abbiamo capito quale sia ma in parte ci sfugge, noi con un occhio ai bambini che scorrazzano e uno alla tessitura della storia sentiamo raccontare di come quella fortezza sia così tanto importante, a livello simbolico, perché lo era stata a livello strategico, nel passato. Su un fiume importante, a picco sul mare e ben protetta, gli inglesi si erano ripresi quasi tutta la ex colonia, in un certo momento, ed erano arrivati fino a Washington, l’avevano occupata. Ma Baltimora no, era l’ultima fortezza americana a resistere e se cadeva lei tutto era perduto.
La flotta inglese era lì, nella baia, e li minacciava. Loro erano lì, nella fortezza, e non potevano minacciarli perché i loro cannoni avevano una gittata più corta. Le navi inglesi erano tantissime, i soldati americani pochi. La cittadella alle loro spalle piena di cittadini inermi e trepidanti.
Gli ascoltatori e il ranger si mettono a piegare la bandiera e la ripongono, noi continuiamo a cercar di sentire le spiegazioni un po’ mangiate dal vento e dal dover stare dietro ai pargoli, che non saltino giù, per gioco, a sfracellarsi su una roccia.
Comunque la battaglia inizia e gli inglesi sparano dalle navi e colpiscono le rocce e i ramparti, i cannoni americani sparano e alzano grandi sbuffi d’acqua in mezzo al mare.
La cosa va avanti per tutta la notte e al mattino dopo, dal gran bombardamento che c’è stato, c’è una tale nuvola di polvere che non si vede nulla, e nemmeno la gente che si è arrampicata sui tetti delle case per capire come andava la battaglia ci ha capito niente, perché per via della nebbia non si vede se la fortezza, l’ultima baluardo americano, è ancora lì a dire che c’è in piedi ancora qualcosa di americano.
Comunque poi, fra il vento, l’accento, i piccoli e la voglia di un panino ci perdiamo davvero troppe cose e decidiamo di rimandare il resto delle spiegazioni a dopo, quando si proietta un filmato, una ricostruzione in costume sui Fatti di Baltimora.
Intanto un nuovo gruppo si raccoglie ai piedi della bandiera, una scolaresca si dispone vicino ai cannoni ad ascoltare un altro ranger e il loro maestro. E in quel momento ci arriva la consapevolezza che ci sono così tante persone e molte anche così giovani, e del fatto che con tutta quella gente potrebbe anche esserci una discreta caciara, e di come invece ci sia un certo silenzio: a parte il vigore nel tono dei ranger e il ronzio delle gite (che sempre ne producono, anche fra i visitatori più silenziosi) il posto è calmo e la gente si muove rispettosa e concentrata, come se si muovesse fra in con e su per i famosi Fatti e dovesse stare attenta a non inciamparci e a non mancargli di rispetto.
Anche noi, placate le varie esigenze, ci avviciniamo alla saletta delle proiezioni in attento silenzio. Il filmato è già partito, e quando ci sediamo le navi inglesi stanno già cannoneggiando, e la fortezza americana sta già saltando in aria qua e là ma non si capisce molto perché subito si alza un gran polverone e le facce della gente sui tetti, rigate di pioggia battente che loro ignorano perché vogliono vedere se la loro fortezza regge, sono stravolte dall’ansia e dalla frustrazione, perché nemmeno dal paese si capisce se gli inglesi ce l’hanno fatta, o se in America c’è ancora qualcosa di americano.
Dopo la notte, passata fra i rombi e le esplosioni, si smette di sparare, perché ora davvero di colpi ne sono stati messi a segno tanti, e se quelli stanno ancora in piedi allora vuol dire che alla flotta di sua Maestà non gli resta che levare le ancore. Sicché dalle navi, anche, a questo punto, tutti si mettono a naso in su e ad aguzzare la vista.
E fra le facce ansiose sulle navi la faccia più ansiosa di tutte è quella di un giovanissimo americano, un avvocato di Boston che su una delle navi inglesi è salito per una missione diplomatica, e poi gli è toccato restare lì, fra i nemici, a, guardare il bombardamento e a chiedersi se la fortezza ce l’avrebbe fatta.
Sta lì, guarda, ma la nebbia è così fitta che non riesce a capire se qualcosa sia rimasto in piedi, del suo amato paese. E poi, ecco, il vento si alza, la nebbia si dirada e sul pennone altissimo ancora sventola la bandiera, la sua, quella degli Stati Uniti. Il cuore del giovane riprende a battere, la sua gioia è una piena che tracima subito in versi e nella poesia che lui compone subito, descrivendo la battaglia, e la nebbia, e la bandiera salva insieme a tutta la nazione.
Poi dopo qualche anno quella poesia la metteranno in musica e così avranno creato l’inno americano.
Che viene suonato e cantato, a chiusura del filmato, mentre gli spettatori si mettono in piedi e con la mano sul cuore e noi in piedi soltanto. Le note proseguono e sullo schermo sta la gloriosa bandiera lacera e polverosa ma issata sull’altissimo pennone, finché finisce la musica, finiscono le parole, finisce il filmato, e mentre siamo ancora in piedi, un po’ con la mano sul cuore un po’ no, si solleva una parete intera della saletta delle proiezioni, e proprio lì dove stava la bandiera del film adesso sventola contro il cielo azzurro e sopra il vento vigoroso, la bandiera grande e nuova, issata sull’immenso pennone, della fortezza.
E lì restiamo, davanti alla bandiera vera, per qualche minuto, intontiti dalla visione e l’ascolto dei Fatti, perché dopo che ci avevano fatto quella compagnia misteriosa e silenziosa un po’ tutto il giorno poi, a vederseli sparare così, tutti luminosi e rumorosi nello schermo era stato un po’ scioccante, stordente e toccante al tempo stesso. E allora mentre sciamiamo via insieme agli altri spettatori e ci sentiamo ancora coperti dalle emozioni che il filmato ci aveva messo tanta foga a gettarci addosso, e mio figlio piccolo ha l’occhio fiero dei grandi Fatti violenti appena visti, c’è qualcosa che mi colpisce e in parte mi inquieta. Perché quello a cui abbiamo partecipato è un evento davvero ben preparato, curatissimo nei dettagli, in cui pareva che ci dovevano vendere per forza qualcosa e convincere con tutti i mezzi leciti. Insomma, un piccolo capolavoro di marketing da cui non si può sfuggire, o lo compri o lo rifiuti sdegnato, ma sicuramente non lo puoi ignorare. E quella volta, la prima che ho capito le parole dell’inno americano, ho capito anche questo, che in America il discorso dell’amore di patria funziona proprio così, lo devi abbracciare, onorare, sentire con tutte le fibre del corpo. Oppure altrettanto violentemente rifiutare, gettandoti ai margini del viver civile e dell’ordine costituito.
Non mi ricordo la prima volta che ho imparato le parole dell’inno nazionale italiano. Ero bambina, nei primi anni delle elementari, e la maestra ci faceva cantare Fratelli d’Italia fra tante altre canzoni, senza calore particolare e senza una spiega. Che magari, invece, non avrebbe fatto poi male. Macché, niente: al corso di musica si imparavano gli inni nazionali, le canzoni della resistenza e le filastrocche sul carnevale allo stesso modo, senza capirci nulla.
E magari questo non era bene. Una piccola inquadratina all’Elmo di Scipio o ai partigiani che portavano via qualcuno si sarebbe anche potuta dare, penso. Però dopo tutte le energie e le bravure spese dai ranger e dagli esperti di marketing nel convincerci a sentire la gloria di quello americano ho ripensato con tenerezza al nostro, di inni. Che a nessuno mai, a parte un benigno Benigni, una sera, gliene è mai importato un fico secco di esaltarlo e di assurgerlo più di tanto a simbolo e stimolo di incondizionato amor patrio.

 Il mercato di Awa - Francesca Andreini
Il mercato di Awa - Francesca Andreini Gino/ 28 - Francesca Andreini
Gino/ 28 - Francesca Andreini La prima volta che ho partecipato a una riunione di contea - Francesca Andreini
La prima volta che ho partecipato a una riunione di contea - Francesca Andreini Es-Sham
Es-Sham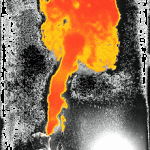 Gino/ 21
Gino/ 21 Gino /30
Gino /30 Gino/ 27
Gino/ 27






















Grazie. Bellissimo racconto.