
Ever let Fancy roam,
Lascia sempre vagar la Fantasia,
Pleasure never is at home.
Il Piacere non ha casa in cui stare.
At a touch sweet Pleasure melteth
A un dolce tocco il Piacer si dissolve
Like to bubbles when rain pelteth
Qual bolla d’aria nella pioggia battente.
Then let wìnged Fancy wander
Lascia dunque che vada l’alata fantasia
Through the thought still spred beyonder her.
Attraverso pensieri lanciati oltre i suoi limiti
Open wide the mind’s cage door
Spalanca la gabbia della mente
She’ll dart forth and cloudwart soar…
Ed essa saetterà planando fino alle nuvole.
John Keats, Fancy [Fantasia,1820]
Massimo Rizzante
“Sembrerebbe che i narratori moderni non capiscano più cosa significhi raccontare l’altro mondo, quasi che fossero permanentemente ospedalizzati in questo mondo e nella cosiddetta ‘realtà’, di cui il loro linguaggio deve essere al servizio. Perciò quasi tutti i romanzi in circolazione debbono mettere avanti un progetto di dire qualcosa di drammatico su questo mondo, sulla ‘realtà’, per poter essere presi seriamente”. Quando ho cominciato a leggere il tuo ultimo libro, Fata morgana (2005), sorta di resoconto etnografico su una popolazione mai esistita, mi è subito venuto in mente Gulliver, e tutta una tradizione narrativa semiseria di viaggi fantastici e luoghi introvabili che probabilmente risale agli inverosimili racconti di Luciano di Samosata. Poi ho scovato nei miei appunti la citazione sugli scrittori ospedalizzati nella realtà. È stralciata dalla tua Prefazione a La miseria in bocca di Flann O’Brien, libro uscito nel 1987. Anche la vena satirica di O’Brien è profondamente fantastica: O’Brien non si fa nessuno scrupolo, alla stregua di Swift, di trasformare l’ospedale della realtà in un asilo per pazzi. Lilliput, l’al di là sottomarino delle antiche fiabe gaeliche, la tua valle dei Gamuna sono luoghi inverosimili, eppure ci raccontano qualcosa di vero. La conoscenza fantastica ieri come oggi non è mai stata presa sul serio dagli uomini, malati e ospedalizzati nella conoscenza cosiddetta razionale. È da qui che dobbiamo partire?
Gianni Celati
Negli ultimi tempi mi è capitato di vedere alcuni film che sono considerati di fantasia, come Il signore degli anelli e Harry Potter. In modo inconfondibilmente anglosassone, la fantasia qui è data come un regno del mostruoso, anche dello sporco e del polveroso. Il pragmatico mondo anglosassone vede la fantasia come una zona torbida della psiche da dominare con la razionalità. Questo compito ora è affidato all’onnipotenza della tecnologia, con i suoi effetti elettronici che possono dominare la psiche di tutti. La separazione tra fantasia e realtà è ricondotta a quella tra mondo soggettivo e mondo oggettivo; e questa separazione sottolinea che le fantasie “non sono vere” perché esulano dalle “verità scientifiche”. Bisogna ripartire di qui, mettendo in dubbio che esista questa separazione netta tra il mondo immaginato o fantasticato e quello che viene dato ufficialmente come mondo reale quotidiano. Noi ci serviamo della fantasia tutti i momenti per interpretare le cose, cercando di capire quello che è fuori dalla nostra portata. E tutto il nostro sistema emotivo dipende da come immaginiamo ciò che sta sotto i nostri occhi. Quando abbiamo paura, quando siamo a disagio, quando siamo in pericolo, quando facciamo progetti, entra in gioco l’atto di fantasticare. Quando siamo innamorati non facciamo che ripassarci nella testa il film delle fantasie sull’altro. L’atto di fantasticare è così comune che lo diamo per scontato. Però se si inceppa, c’è un campanello d’allarme che è la noia, come l’altra faccia degli slanci di fantasticazione.
Massimo Rizzante
Che cosa si deve fare per liberarsi da un’idea di fantasia intesa come irrealtà, a cui credo faccia da pendant un’idea di realtà concepita secondo i canoni intimidatori della vulgata scientifica?
Gianni Celati
Di solito questo compito è affidato alle attività cosiddette estetiche, come un ghetto per gente in cerca del bello. Io però non credo all’estetica, non credo a una scienza del bello. La parola “estetica” viene dal greco aisthesis, che indica la sensibilità, la sensazione. In Aristotele quella parola riguarda il fatto che attraverso i sensi noi siamo affetti da quello che ci sta attorno, e di qui si formano le immagini della mente, che lui chiama phantasía. Le immagini che portiamo nella mente, dice Aristotele, sono una combinazione di ciò che percepiamo o abbiamo percepito attraverso i sensi e ciò che opiniamo con l’intelletto. In un trattato sulla memoria dice che sono oggetti di memoria quelli che cadono sotto l’immaginazione, dunque immaginazione e memoria non sono mai separabili. Ricordare vuol sempre dire anche immaginare la cosa ricordata, dunque in qualche modo re-inventarla fantasticamente. È anche l’idea di Giambattista Vico, il quale diceva che “la memoria è l’istesso della fantasia”; e diceva che la parola “memorabile” vuol dire “una cosa da potersi immaginare”. Vico sostiene che un buon lavoro del pensiero sia quello immaginativo, per ripercorrere i processi che hanno dato origine a certe forme fantastiche, secondo stadi della vita sociale. E la scienza che si occupa di queste cose, la chiama “sapienza poetica”, che vuol dire scienza delle forme fantastiche con cui gli uomini si intendono nella vita comune. Perché gli uomini si intendono sempre attraverso quello che possono immaginare, e vanno sempre in cerca di altri con cui condividere le loro proiezioni immaginative. E se non riescono più a farlo diventano orribilmente avviliti e odiano la vita. Gaston Bachelard l’ha detto: “L’immaginazione aumenta il valore della realtà”.
Massimo Rizzante
Potresti portare un esempio concreto di questo uso della fantasia che da Aristotele a Vico è così intimamente legato alla memoria?
Gianni Celati
Ho in mente la facciata dell’Albergo Accademia, qui a Trento, dove sono alloggiato. Ho in mente la curva in una strada che ho dovuto fare per arrivarci. Tutte queste cose le “porto nella mia mente”, sono immagini con cui mi oriento in modo pratico nella vita quotidiana. In un testo bellissimo, il De anima – insieme all’altro suo testo che si intitola Della memoria e della reminiscenza – Aristotele cerca di spiegarsi come succede che noi portiamo in mente le immagini, e fa l’esempio della tavoletta che conserva le tracce dei segni depositati nella cera. Aristotele chiama in due modi le immagini della mente: uno è phantasma e l’altro è phantasía – dal verbo phaínomai, “mostrare”, “far vedere” – dunque ciò che si mostra in noi come figura, figurazione. Anche in italiano il fantasticare, le fantasticazioni indicano un figurarsi le cose che è indistinguibile dal pensare, un pensare-immaginare. Per indicare l’assorbimento nel pensare-immaginare, la parola francese rêverie è quella più usabile, anche per come l’ha usata Gaston Bachelard in alcuni libri fondamentali su certi tipi di rêveries. Una delle cose che mi colpiscono sempre è l’assorbimento dei bambini quando debbono scrivere qualcosa, e prima di scrivere li vedi concentrati in una rêverie, che è il normale modo di farsi venire in mente delle idee. Vico pone chiaramente che tutti questi fenomeni di fantasticazione corrispondono a un uso regressivo del pensiero, ancorato a quello che lui chiama “sapienza poetica”. “Il più sublime lavoro della poesia è dare senso alle cose insensate”, dice in un famoso passo, “ed è proprio dei fanciulli prendere cose inanimate e trastullarsi con loro come se fossero persone vive”. I bambini non solo inventano storie per farsi un’idea delle cose che restano fuori dalla loro portata, ma in loro il fantasticare va assieme alla tendenza a toccare, a giocare con le cose, a esplorarle con le mani. E il fantasticare ha questo di essenziale: che è come un fenomeno tattile, come se noi ci orientassimo tattilmente fra ciò che resta impensato.
Massimo Rizzante
Il tuo discorso è chiaro: è necessario tornare a una nozione di fantasia che non coincide esattamente con quella di immaginazione; quest’ultima, nata dopo Kant, ha chiuso i ponti levatoi sull’aisthesis, sulla sensibilità e i suoi stati, e si è rinchiusa nella fortezza dello spirito, della ragione, della scienza. Fin quando ha avuto un forte legame con la memoria, la fantasia ha partecipato al processo cognitivo dell’uomo (penso a Montaigne, ad esempio). Questo mi sembra il punto essenziale: possiamo ridare valore alla nozione di fantasia se ridiamo alla fantasia la sua funzione perduta di regolatrice della conoscenza umana, di scrigno di forme ricevute attraverso i cinque sensi, di mediatrice tra corporeo e incorporeo. Mi sbaglio?
Gianni Celati
Nel modo in cui viene usata oggi, la parola “conoscenza” dà l’immagine di uno che fa i quattrini e poi li mette in banca. È l’idea d’un sapere neutro che posso mettere da parte come pura informazione, per capitalizzarlo nel mestiere che faccio. E l’informazione è intesa come qualcosa che posso immagazzinare a piacere, senza che questo mi coinvolga tanto. Questa idea della conoscenza è così falsa da diventare una galera del pensiero, perché nasconde tutto l’aspetto emotivo della faccenda. Ci nasconde che per aprirsi alla comprensione di qualunque cosa occorre sempre compiere proiezioni immaginative per figurarsi quello che non riusciamo ad afferrare. Queste proiezioni sono modi di interpretare le cose ma anche investimenti emotivi, legati ai fantasmi della mente, ossia alle nostre aspettative o illusioni. I Greci non avevano una parola per dire conoscenza, ma ne avevano una per dire intellezione: noésis. La noesi è per Aristotele un modo di ricezione o di percezione, perciò l’intelletto deve essere come una lente, ossia una trasparenza attraverso le immagini. Le immagini danno al pensiero la potenza della passione, perché, dice Aristotele, tutto il sentire dei sensi e ogni percezione delle cose corrisponde a una forma di passione – ossia a uno stato ricettivo con cui ci apriamo. Non è dunque nella forma bruta dello scambio di informazioni, che alla fine capiamo qualcosa, ma nel processo immaginativo con cui mi proietto verso un oggetto che mi appassiona, che si configura come un’esperienza e una passione.
Massimo Rizzante
Volevo, se mi permetti, riportare un passo di Aristotele, tratto da un’opera da te già citata in precedenza, Della memoria e della reminiscenza. Eccolo: “La memoria, anche degli intelligibili, non è senza immagine […] È chiaro dunque a quale parte dell’anima appartiene la memoria, cioè a quella cui appartiene anche l’immaginazione: sono oggetti di memoria per sé quelli che cadono sotto l’immaginazione, per accidente, poi, quelli che non sono separati dall’immaginazione”. L’immaginazione – che qui andrebbe tradotta con la parola fantasia – ha secondo Aristotele, e come avevamo già affermato, la funzione di regolare il flusso che viene dai sensi e che va verso l’intellezione. Ora, in termini filosofici c’è un problema che solo in età moderna sarà risolto, ovvero spazzato via (su ciò sarò per sempre debitore al saggio di Giorgio Agamben Infanzia e storia). Per i Greci il soggetto dell’esperienza – risultato di sensazioni, impressioni e ricordi – era il senso comune, il quale apparteneva a ogni individuo. Il soggetto della conoscenza, come tu hai appena detto, era invece il nous, il quale, unico e divino, risultava separato dall’esperienza. Per i Greci perciò il vero problema della conoscenza non era legato al rapporto fra soggetto e oggetto, ma a quello fra Uno e molteplice. La domanda fondamentale era: in che modo il nous, intelletto unico e separato, partecipa nei singoli individui affinché tutti singolarmente giungiamo a conoscere? Ciò non toglie che da Aristotele a Cartesio la formula “Nihil potest homo intelligere sine phantasmata” risultava naturale…
Gianni Celati
L’idea che non esista nessun atto intellettivo senza una figurazione immaginativa si trova nel De anima di Aristotele. Quell’idea appartiene a una visione della vita che non contemplava ancora la separazione tra ciò che diciamo soggettivo e ciò che diciamo oggettivo. Noi viviamo nell’epoca in cui la separazione tra il soggettivo e l’oggettivo è addirittura violenta, col risultato che siamo tutti “personalità divise”, con un dentro e un fuori quasi sempre inconciliabili. Cosa vuol dire soggettivo e oggettivo? Per Cartesio sono due regimi separati: corrispondono alla differenza tra anima e corpo, tra pensiero e cose esterne. Il soggettivo è il nostro pensiero che pensa il nostro essere. L’oggettivo è l’essere delle cose esterne che possono essere pensate come idee chiare e distinte. Cartesio insiste che questo avviene senza contributi dei sensi e dell’immaginazione. Il suo famoso esempio è quello del triangolo, che di fatto non esiste nella realtà, ma noi lo portiamo in mente come un’idea chiara e distinta, cioè oggettiva. Non c’è bisogno dell’immaginazione per pensarlo, dice Cartesio, perché non è un triangolo specifico, grande o piccolo, rosso o nero. È un modello ideale astratto, ed è attraverso modelli astratti che si realizzano i processi di oggettivazione che chiamiamo verità scientifiche. Ma il fatto è che noi non viviamo dentro a modelli astratti, noi siamo buttati nel mondo e ci arrangiamo con le proiezioni immaginative per capire come vanno le cose. Al tempo stesso il modello astratto realizza un’intellezione funzionale, su cui non dobbiamo più intenderci figurandoci le cose, e la passione percettiva non ha più senso.
Massimo Rizzante
La malattia dell’Occidente, affermi, è quella dell’astrazione. La malattia dell’astrazione, tuttavia, è una malattia antica, che risale agli albori del razionalismo moderno e ai sogni di Cartesio. Una malattia più recente è quella che Milan Kundera ha definito nel suo ultimo saggio, Il sipario, come “morale dell’archivio”, e che io, molto modestamente, chiamo enciclopedismo: un assurdo proliferare di informazioni e saperi, un’accumulazione senza freni di libri nel tentativo di abbracciare un Tutto, di cui – paradosso nel paradosso – da almeno un secolo, si predica l’inesistenza. Il risultato, al di là di un facile idillio con un falso concetto di eguaglianza, è che più concepiamo la memoria come archivio, più la nostra capacità figurativa, rammemorativa e reminiscente, viene meno.
Gianni Celati
Quasi in apertura della Critica della ragion pura, Kant dice che un concetto senza immaginazione è un concetto vuoto. Concetti vuoti sono ad esempio certe astrazioni usate come puri segni d’autorità con cui si crea una situazione coatta di ricezione. È tipico dei discorsi dei professori universitari, dei discorsi degli esperti sui giornali o alla televisione. I nostri politici sono maestri di questo genere di astrazioni a vuoto. Come il meccanismo funzionale cartesiano, così le astrazioni degli esperti non sottintendono una necessità di intendersi attraverso processi immaginativi, o passioni percettive. Le astrazioni degli esperti sono come la voce di Dio che viene giù dal cielo, e tu la ascolti intimidito. Quello dell’assoggettamento all’astratto come condizione coatta è un problema dei tempi moderni sempre di più acuto.
Massimo Rizzante
Il vero problema perciò non è, come invece i sociologi cercano di farci intendere da due decadi, quello della realtà virtuale opposta alla realtà concreta, ma quello del pericoloso sganciamento della virtù fantastica dalla memoria, ridotta ad archivio. Che ne è allora della figurazione? Che rimane, in questa situazione, della nostra capacità di far vivere nella mente ciò che non è presente? Che ne è, a questo punto, della nostra capacità di raccontare?
Gianni Celati
La narrativa d’oggi è ormai un’appendice dell’informazione giornalistica. È difficile trovare un romanzo d’oggi che non si appelli all’attualità. Ecco l’autore basco che scrive il romanzo sul terrorista dell’ETA, e quello irlandese che scrive il romanzo sul terrorista dell’IRA e l’autrice americana che scrive il romanzo sulle congreghe di pedofili, e l’autore italiano che scrive il romanzo su certi tipi della mafia. Sono libri che il lettore legge come se fossero commenti a una realtà di fatto. Qui però la “realtà” indica solo modi di vedere giornalistici – i modi dell’attualità – il tutto categorizzato secondo il criterio del “nuovo”. Per i giornali i fatti hanno valore solo quando cadono nella categoria del nuovo. Il nuovo è un dogma ma anche una continua intimidazione, perché tutti dobbiamo aver paura di essere visti come dei sorpassati dal nuovo, il che nel mondo attuale vuol dire essere scarti senza valore. A questo proposito c’è qualcosa di illuminante nel Don Chisciotte, dove si affaccia per la prima volta la questione della “realtà”, posta in un contrasto con l’immaginazione e le tendenze fantasticanti . E si affaccia anche l’idea che il nuovo sia qualcosa che spazza via le inutili anticaglie (i romanzi cavallereschi che hanno invaso il cervello di Don Chisciotte). Ma, posto questo schema, dove Don Chisciotte ha sempre torto, in quanto invasato dalla fantasie cavalleresche, poi succede che sono proprio le sue tendenze fantasticanti a arricchire di senso il mondo, episodio dopo episodio. Sono le sue fantasie e riflessioni a farci intravedere l’aperto mondo sotto l’aperto cielo come la nostra vera casa. Tutto il Don Chisciotte resta un esempio meraviglioso del pensare-immaginare, del vedere la memoria figurale attraverso la trasparenza delle immagini.
Massimo Rizzante
Prima hai detto di non credere nell’estetica così come è stata intesa dal Settecento in poi. Ora, leggendo le tue opere, compresi alcuni saggi, si approda a un’altra nozione, che è legata a quelle di “fantasia” e “memoria”, mi sembra altrettanto importante, vale a dire quella di “finzione”. È un caso se il tuo rifiuto dell’estetica moderna coincide con la critica alla pretesa moderna dei romanzi di regolare le avventure umane secondo le convenzioni della coscienza?
Gianni Celati
Quand’ero giovane ho avuto una borsa di studio che mi ha permesso di passare due anni a Londra, chiuso nella biblioteca del British Museum a studiare. Ne è venuto fuori quel saggio sulla nascita del romanzo, intitolato Finzioni occidentali. Io mi ero interrogato a lungo sul termine finzione riferito ai romanzi. Negli antichi non esisteva questa idea, neanche in Dante. In Dante c’è l’idea di una visione, che è una cosa molto diversa. Evidentemente quando i critici dicono che i romanzi sono finzioni vogliono dirci che sono costruzioni immaginative, dove non conta il valore di verità dei fatti narrati ma solo quello strategico dei modi di catturarci e affascinarci. Ma usando la parola in questo modo i critici tendono anche a mostrare ogni romanzo come una macchina programmata per catturarci, e tutte le costruzioni immaginative come trappole della seduzione. In questo senso la parola finzione sembra riferirsi sostanzialmente a una funzione mistificatoria, più o meno come dicevano i censori di Don Chisciotte che bruciavano i suoi libri di cavalleria – con la differenza che noi siamo uomini moderni “spregiudicati”. Così si intravede ancora una volta l’idea che la fantasia o l’immaginazione siano attività secondarie e mistificanti, disgiunte da ogni “serio” processo intellettivo. Ritrovo questo dito puntato in molta parte della sinistra europea, e anche in un critico come Roland Barthes. Questo critico francese ha scritto un libro famoso che si intitola Miti d’oggi, dove parlava di luoghi comuni quotidiani e pubblicitari. Ma perché chiamarli miti? Li chiama miti per dire errori intellettuali collettivi. Dunque “mito” vorrebbe dire mistificazione prodotta da una proiezione immaginativa – che è il modo di vedere più pesantemente positivista e ideologico. Infatti conclude il libro dicendo che il mito è sempre di destra. In Barthes è sempre molto forte la tendenza a restaurare la netta distinzione cartesiana tra principio soggettivo e principio oggettivo, identificando il primo nei fattori di seduzione letteraria e il secondo in una dottrina critica del reale. Qui accenno solo al fatto che in Vico c’è un modo diverso di intendere le finzioni – il verbo “fingere”, ossia le proiezioni immaginative – un modo dove il dualismo cartesiano è finalmente messo fuori gioco.
Massimo Rizzante
Certo, quel libro di Barthes ha ormai molti anni sulle spalle e porta con sé un’indelebile impronta ideologica. Un altro Roland Barthes, non molto diverso da quello di Miti d’oggi, è il critico che ha fatto dell’écriture il luogo dello spodestamento di quella nozione di tradizione, che basava la propria autorità su un’esperienza umana raccontata e, appunto, trasmessa. Ma lasciamo stare. Tutto ciò ci porterebbe troppo lontano. A partire dagli anni Ottanta, con Narratori delle pianure (1985), si accentua nelle tue opere e nelle tue riflessioni l’opposizione tra il “delirio critico razionalistico”, che vuole sempre spiegare e incasellare la realtà e il senso comune, un sapere pratico, incapace di discriminare, che ci riconduce alla prosa del mondo, in basso, nella terra dei luoghi comuni – termine quest’ultimo che usi spesso – così come quelli di “banalità”, “ovvietà”, “sentito dire”, in cui tutti noi siamo immersi. Che cosa può dirci a proposito di quell’epoca?
Gianni Celati
Per alcuni anni sono andato in giro per la valle del Po, prima insieme ad alcuni fotografi, poi da solo a prendere appunti. Sono venuti fuori tre libri con i fotografi, uno con Luigi Ghirri, e uno mio che è un diario di viaggio intitolato Verso la foce. Una delle attività che facevo era quella di piantarmi per interi pomeriggi nei bar di campagna e ascoltare tutto quello che si diceva. C’erano accenni a storie possibili a ogni frase, e di lì mi sembrava di capire come nascono i racconti. Ascoltando le conversazioni da bar, l’altra cosa che mi è veniva in mente è l’idea che noi viviamo dentro al “sentito dire” collettivo, ossia che tutto il mondo per noi sia come foderato dal “sentito dire”. Ad esempio: cos’è l’America? Cos’era la prima guerra mondiale? Come è stata la vita nei campi di concentramento? Non ne sappiamo granché, ma ne parliamo come di cose “note”, perché sono cose che immaginiamo in un modo o nell’altro attraverso un “sentito dire” (che può essere anche quello dei giornali). Il “sentito dire” è come uno spillo: qualcuno mi punge con quello spillo e mi spinge a farmi delle domande per capire di cosa si sta parlando. Questo è il lavoro di chi scrive racconti: sente una cosa, vuole capire ciò che si dice, e parte a fantasticare, ossia a farsi domande. Ciò che lega gli uomini sono le domande che gli uomini si fanno – non le affermazioni, ma il pensiero interrogativo, dove ogni interrogazione promuove altre immagini e fantasticazioni.
Massimo Rizzante
Mi ricordo che quando lessi Verso la foce (1989), il libro che raccoglie i quattro diari di viaggio che il narratore compie in compagnia di alcuni fotografi sul delta del Po, mi colpì molto la Notizia che tu, come autore, avevi posto sulla soglia del libro. Soprattutto la parte finale: “Ogni osservazione ha bisogno di liberarsi dai codici familiari che porta con sé. Ha bisogno di andare alla deriva in mezzo a tutto ciò che non capisce, per poter arrivare ad una voce dove dovrà sentirsi smarrita. Come una tendenza naturale che ci assorbe, ogni osservazione intensa del mondo esterno forse ci porta più vicino alla nostra morte, ossia ci porta ad essere meno separati da noi stessi”. Questa “tendenza naturale” è una variazione del senso comune? E lo scrivere racconti seguendo tale “tendenza naturale” è un movimento contrario a quello di creare finzioni? E ancora: scrivere sotto questo imperativo naturale che ci assorbe, significa scavalcare il recinto del territorio estetico per porci in un territorio puramente antropologico, di ascolto e visitazione fantastica degli altri?
Gianni Celati
La tua idea di ascolto e visitazione fantastica degli altri è un bel concetto, e adesso cercherò di svilupparlo. Ognuno di noi viene al mondo senza poter decidere quanto sarà alto, che faccia avrà, che carattere avrà, se sarà biondo o bruno: ma tutto questo costituisce, nel bene o nel male, la sua singolarità di individuo. Essere individui vuol dire accettare una singolarità che non abbiamo deciso noi, ognuno secondo il suo destino, secondo la sua faccia, o secondo le vergogne che si porta dietro dall’infanzia. Per contro essere separati da se stessi significa separarsi dal proprio destino di individui e dagli altri individui. In realtà poi ognuno di noi va sempre in cerca d’una sua popolazione, d’una popolazione d’individui a cui associarsi anche solo fantasticamente. Allo stesso modo i cani vanno in cerca d’altri cani con cui annusarsi, e i bambini cercano altri bambini con cui giocare, e gli adolescenti cercano altri adolescenti per parlare di cose da adolescenti. Gli antichi dicevano che il simile cerca il simile. La letteratura stessa a me sembra non un prodotto di autori separati, ma di popolazioni, di bande di sognatori, tra cui avviene quell’ascolto e quella visitazione fantastica di cui hai detto. Per questo la letteratura cavalleresca è la tradizione narrativa italiana che più bisognerebbe rimettersi a studiare. Perché non parla di individui separati nella loro cosiddetta psicologia, non parla dell’individuo moderno chiuso nel proprio guscio (ognuno a casa sua, con i suoi gadgets, prodotti di consumo e la propria interiorità), ma sempre della vita come un fenomeno vegetativo generale, dove tutto è collegato e tutto è animato. E parla di popolazioni e di bande di sognatori passionali e sbandati, puramente esposti alla fatalità del destino, come Don Chisciotte.
Massimo Rizzante
La “tendenza naturale”, per chi scrive racconti, dunque, è complementare a quella capacità fantastica che affonda le sue radici nel terreno del senso comune?
Gianni Celati
Sì. E riflettere sulla fantasia aiuta a capire quello che tu chiami senso comune: cosa ci lega l’uno all’altro nei pensieri a distanza, anche nel quadro d’una separazione generale degli individui. Per questo credo sia utile la ripresa del pensiero di Aristotele, di Vico, come ripresa di un’idea di intellezione collettiva. Il che vuole dire che possiamo anche essere soli, ma siamo sempre con gli altri – essere al mondo vuol dire essere con gli altri dall’inizio alla fine. Anche se sono su un’isola deserta, gli altri sono sempre con me in una trama che determina i miei gesti, i miei atteggiamenti, quello che voglio e quel che non voglio.
Massimo Rizzante
Vorrei ritornare su qualcosa che forse nella domanda precedente non ho espresso chiaramente. La “tendenza naturale” ad andare verso l’altro, a scoprire ciò che abbiamo tutti in comune – tendenza nella quale la fantasia ha un ruolo fondamentale – nei tuoi racconti procede, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, dall’esterno, attraverso la descrizione e l’osservazione. La tua prospettiva è perciò diversa da quella di molti scrittori moderni per i quali il fuoco privilegiato è lo spazio interiore. Mi sembra di poter dire che hai condiviso questa prospettiva antipsicologica con altri autori italiani e stranieri, primo fra tutti Italo Calvino. Fin dagli anni Settanta – ma probabilmente fin dall’inizio della sua carriera letteraria – uno dei problemi più assillanti per Calvino è stato: come descrivere le cose? Come farsi assorbire dall’esterno, evitando i trabocchetti dell’io? All’ombra della nozione di fantasia – che oggi Calvino ci avrebbe certamente aiutato a illuminare – ti chiedo: dove risiede secondo te la frontiera tra il tuo modo di vedere o di fantasticare rispetto a quello del tuo amico Italo?
Gianni Celati
Se c’è stato questo sodalizio fra me e Calvino, credo sia nato da una simpatia comune per certi libri. Ad esempio Ariosto e la letteratura cavalleresca, e poi i romanzi settecenteschi inglesi, e poi Swift e Defoe, fino a Beckett, che Calvino onorava molto (una volta l’ha visto per strada e dopo me ne parlava con emozione). Io vengo da una famiglia con un padre che a tavola recitava Ariosto o Dante, e considerava il suo massimo patrimonio uno scaffale di classici italiani; e questo mio retroterra interessava molto Calvino. A quei tempi, tra il 1968 e il 1970 a Parigi, andavamo a spasso parlando di cose da scrivere, e lui come fantasticatore a ruota libera era eccezionale, gli bastava uno spunto e partiva a raccontarti una storia. A quei tempi abbiamo chiacchierato per giorni interi, ogni volta che passavo da Parigi per andare a Londra (dove avevo quella borsa di studio) dormivo a casa sua. Certe volte si incazzava furiosamente con me per cose strane, come il fatto che attraversavo l’Europa in macchina senza una carta stradale: lui lo trovava inconcepibile. Ma ogni volta lo ritrovavo molto contento di vedermi per chiacchierare di libri letti e di idee sullo scrivere. Nell’ultima di queste mie soste a Parigi, io tornavo dall’America con le Avventure di Guizzardi finito da consegnargli, e lui mi è venuto a prendere all’aeroporto di Orly. Senza di lui non mi sarei mai messo a scrivere. È stato lui a scoprire su una rivista i primi brani di quello che sarebbe diventato Comiche; è stato lui a propormi di farne un libro per una collana di Einaudi; è stato lui a sollecitarmi a scrivere. Poi dovevamo fare quella rivista assieme, con Carlo Ginzburg e altri, ma è andata in fumo. Dopo tanto chiacchierare, quello che ci ha un po’ separati è stata la sua scoperta della semiologia. La semiologia a me è sempre sembrata come un boccone che ti resta in gola, e produce molta salivazione ma poche immagini, e non ti permette mai di abbandonarti a quello che è fuori di te.
Massimo Rizzante
Ma qui, con la fantasia come la mettiamo? Calvino, fino all’ultimo, fino alla stesura delle Lezioni americane, dove c’è un bellissimo passaggio su Dante, ha insistito con convinzione sulla nozione di fantasia…
Gianni Celati
Infatti Calvino è uno dei nostri autori più fantastici, più immaginativi. Anzi, quello è diventato come il suo marchio di fabbrica. Rileggendo i suoi racconti giovanili li trovo un po’ programmatici. E così la trilogia, con l’eccezione del Cavaliere inesistente. Di questo libro lui si vantava, a ragione, dicendo che era il “libro del maggiore scripturalist italiano”. La parola scripturalist non so dove l’avesse scovata, ma cadeva a proposito. Voleva dire che il suo era un lavoro di fantasia che seguiva certi spunti narrativi e usava la scrittura come una specie di disegno a mano libera. Non credo che nessuno abbia studiato l’influsso dei disegnatori sul suo modo di scrivere, cominciando da quello del nostro grande disegnatore Rubino. Calvino mi raccontava che Rubino capitava nella villa dei suoi genitori a Sanremo, quando lui era bambino, e molte volte gli faceva dei disegni per intrattenerlo – quei disegni con quelle linee art nouveau così eleganti. C’è dunque tutto un percorso di Calvino verso questo uso delle parole. Questa facoltà di usare la scrittura come uno stile disegnativo alla maniera delle vignette, dei fumetti o delle caricature, senza problemi di rappresentazione realistica della realtà, è stato ciò che ha dato a Calvino un’insolita libertà d’azione rispetto agli altri narratori italiani. Ma è anche qualcosa che lui a un certo punto ha sentito come contraddittorio. Molte volte mi ha detto: “Io devo pormi degli ostacoli, altrimenti sono uno scrittore della domenica”. Voleva dire che gli veniva troppo facile, ossia che si lasciava andare troppo alla facilità immaginativa, cosa che ad esempio in Marcovaldo è molto evidente. Nella villa di Castiglione della Pescaia c’era un grande salone; dei giorni arrivavo lì e lui era in un angolo che stava scrivendo, mentre sua figlia e sua moglie chiacchieravano, arrivava la donna di servizio, etc. Poi lui diceva: “Sentite cosa ho scritto”, e ci leggeva. La straordinaria facilità della sua vena fantasticante a partire da uno spunto qualsiasi, si sente molto nelle Cosmicomiche. Nel Castello dei destini incrociati e nelle Città invisibili, la fantasia disegnativa viene in primo piano, attraverso un confronto diretto con le figurazioni dei tarocchi e con le miniature dei vecchi libri di viaggi o con le immagini nelle mappe medievali. Ed è qui che ha cominciato a usare dei frames o incorniciature, che creano un effetto simile a quello postmoderno della autoriflessività.
Massimo Rizzante
Nella Presentazione che hai scritto con Jean Talon ad Altrove di Henri Michaux (2005), c’è un passo che mi è sembrato subito significativo, e ancor di più adesso, dopo quanto abbiamo detto: “Riprendiamo l’idea del pensiero come tragitto. Un bambino scrive un tema scolastico: si ferma, non sa più cosa dire. Ha scritto ciò che chiamiamo un ‘pensiero’. Ma, chiede Michaux, cosa c’è intorno alla frase che si blocca dopo aver espresso un pensiero? […] Ci sono ‘abissi di nescienza’. Sono gli abissi di tutto quello che non sappiamo ancora, o non sapremo mai”. Calvino fa parte di una categoria di scrittori che a un certo punto della loro vita, contemplando fuori della finestra, hanno ricominciato come bambini a scrivere i propri temi. Penso al suo amato Ponge. Tuttavia la sua contemplazione non contemplava l’abbandono, non contemplava il pericolo rappresentato dagli “abissi di nescienza” di cui parla Michaux, non contemplava la scrittura come “gesto”, “movimento sulla pagina” privo di giustificazioni, di significato. Che ne pensi? Questa riflessione è legata al problema della forma, problema che Michaux sembra non porsi. Calvino, invece, se lo poneva, eccome! Il suo amore per Perec non era forse legato alla sua ludica ossessione per le serie matematiche? Al suo distacco nei confronti della realtà? Nei tuoi racconti tutto questo non c’è. C’è piuttosto un abbandono alla contemplazione delle cose fuori di noi. Ma forse qui facciamo ritorno, senza saperlo, alla nozione di “tendenza naturale” di cui abbiamo parlato prima…
Gianni Celati
Non so. Posso aggiungere qualcos’altro su Calvino. Lui era uno molto più “abbandonato” di me, nel senso che era più sicuro di me nello scrivere le cose.
Massimo Rizzante
Credevo che Calvino fosse uno scrittore che prima di mettere la parola fine a un manoscritto si torturasse parecchio…
Gianni Celati
Beh, diciamo che aveva un’idea dello scrivere come ricerca. Una ricerca simile a quella scientifica, cioè dove per andare avanti bisogna spesso rimettere in gioco i presupposti del proprio lavoro.
Massimo Rizzante
Volevo tornare infine ancora sulla forma. Cosa succede allora quando si scrive? Qual è il percorso che si segue? Si tratta di tracciare con le parole delle linee in modo da creare, come tu dici a proposito di Michaux, “luoghi da esplorare”? “Bisogna lasciare che venga”, affermava ancora Michaux.
Gianni Celati
Sì, ma proprio qui la faccenda dello “scrivere naturale” merita una riflessione. Intanto non si tratta d’uno scrivere che si abbandona in tutti i tiraggi della soggettività, ma l’opposto. Quand’ero giovane ho studiato vari autori modernisti angloamericani, cominciando da Gertrude Stein. Ora Gertrude Stein aveva l’idea che non siamo noi, come persone singole o entità psicologiche, a scrivere ciò che si chiama letteratura. Secondo lei le opere letterarie sono scritte da qualcosa che mi sembra chiamasse “la natura umana” – espressione che suscita molti sospetti, mi rendo conto. Ma prendiamo Joyce. Quando scrive Finnegans Wake, Joyce ha l’idea d’un passaggio a un’altra dimensione del pensiero, non più individuale, ma che è come un general intellect, con immagini o frantumi di immagini fluiti nelle parole, attraverso cui gli uomini si intendono (usando la fantasia). Questa nozione sorta da una punta del modernismo, ricorda quell’arditissima costruzione filosofica che va sotto il nome di averroismo. Si tratta del commento a un passo del De anima aristotelico, da cui Averroè ricava l’idea d’un intelletto universale. Ed è un’idea viva nella tradizione islamica, nell’immagine dell’angelo Kalam, dotato della penna con cui scrive per gli uomini le parole del Corano, o scrive il sapere d’un intelletto che trascende quello dei singoli individui. Negli ultimi anni è rinata un’attenzione per questo sviluppo del pensiero antico, e segnalo un libro appena apparso, molto bello e utile: La trasparenza delle immagini di Emanuele Coccia. Io credo che avvicinandosi a questo tipo di intellezione, le strategie letterarie diventano cose secondarie, e diventa inutile anche la mitologia dell'”opera d’autore”.
Massimo Rizzante
È così che anche tu concepisci il tuo scrivere? Un movimento esplorativo che non si pone nessuna meta? Nessuna “opera”?
Gianni Celati
Non so se sia così che concepisco il “mio” scrivere. So che scrivere è comunque un rituale, che noi impariamo a scuola, quando siamo bambini. Una ritualità per cui ci si gratta la testa, si cerca di mettere in moto il pensare-immaginare, per farsi venire in mente una frase, per ricordare una parola. Tutto questo fa parte di qualcosa che è molto costruito in noi, e va inevitabilmente insieme a un certo grado di fantasticazione. Poi c’è qualcos’altro, che è la distanza da cui si guarda la figurazione delle parole che sorge dai segnetti scritti. Nei libro che hai citato, Michaux parla di una popolazione immaginaria, descrive i loro costumi e come sono fatti i loro teatri: “A teatro si rivela il loro gusto del lontano. La sala è lunga, il palcoscenico è profondo. Le immagini, le forme dei personaggi vi appaiono grazie a un gioco di specchi. Gli attori recitano in un’altra sala, e vi appaiono più reali che se fossero presenti. Più concentrati, più purificati, più definitivi, sbarazzati di quell’alone che produce sempre la presenza reale, faccia a faccia…”. Quello di cui sta parlando è il raddoppiamento del raggio nella dimensione speculare. Questo raddoppiamento è la distanza che ci sottrae al faccia a faccia con la realtà, e al tempo stesso rafforza la percezione come nel gioco di specchi, rendendola più trasparente della pura immediatezza. Perché in questo modo non vediamo soltanto qualcosa: vediamo il vedere, guardiamo il guardare, percepiamo l’atto del percepire. Il rituale dello scrivere prevede questo effetto, come una messa a distanza delle percezioni, per sottrarle alla casualità e portarle verso la trasparenza dell’intelligibile. Solo in questi termini riesco a scrivere, e faccio fatica a sopportare chi prende lo scrivere come un riflesso della cosiddetta realtà, personale o sociale che sia – senza vedere il processo rituale a cui le parole debbono essere sottoposte (metrica, ritmo, colore tonale, distanza focale).
Maggio – Agosto 2005
N.B.: Il 17 e 18 maggio 2005 Gianni Celati è stato invitato dal Collegio docenti della Scuola di Dottorato in “Letterature comparate e Studi linguistici” alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento a tenere un seminario sulla traduzione, dal titolo “Poesie tradotte per essere lette ad alta voce”. Al termine del seminario, ho voluto porre a Celati alcune domande su un tema che sapevo stargli particolarmente a cuore: la fantasia. Da qui è nato un dialogo in presenza di un folto pubblico di studenti e lettori. Il dialogo è stato trascritto da Walter Nardon e rivisto e corretto da me e Celati. (M. R.)

 Introduzione a Il desiderio infinito - Redazione
Introduzione a Il desiderio infinito - Redazione Sonetti del Badalucco/ 5 - Gianni Celati
Sonetti del Badalucco/ 5 - Gianni Celati Scuola di calore /1 - Massimo Rizzante
Scuola di calore /1 - Massimo Rizzante Incontro con Gianni Celati - Gianluca Virgilio
Incontro con Gianni Celati - Gianluca Virgilio Sonetti del Badalucco/ 4
Sonetti del Badalucco/ 4 Sonetti del Badalucco/ 3
Sonetti del Badalucco/ 3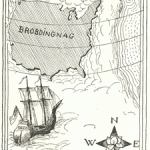 Il viaggio
Il viaggio





















