
per Mauro Martini
Un buon romanzo, di solito, si riconosce fin dalle prime pagine. Non solo: di solito, nelle prime pagine di un buon romanzo c’è già, in nuce e riconoscibile a una lettura attenta, tutto quello che verrà dopo, sia dal punto di vista tematico, sia da quello stilistico e formale.
Generation “P” di Viktor Pelevin, tradotto in Italia come Babylon (Mondadori 2000), non fa eccezione, anzi: le prime, fondamentali indicazioni di lettura si trovano già nell’epigrafe e nelle avvertenze che l’autore antepone al racconto vero e proprio.
L’epigrafe, laconica, recita: «In memoria della classe media». Si tratta, evidentemente, della classe sociale che sta per essere rappresentata – vedremo tra poco come, o meglio, attraverso chi – e la cui estinzione è stata spiegata da Pelevin stesso, in un’intervista, in questi termini: «La classe media in Russia, come tutto il fenomeno chiamato capitalismo, è stata assolutamente virtuale, inesistente. Credo che la scomparsa di questa classe media, essendo virtuale, sia stata una scomparsa virtuale». Ce n’è abbastanza per iniziare a pensare alla rappresentazione di una realtà non reale, fondata su una sorta di “vuoto esistenziale”.
Le avvertenze, oltre a ironizzare sul diritto di proprietà per i marchi registrati menzionati nel testo e sulla facoltà che l’autore si riserva di non credere completamente in ciò che scrive, ci pongono di fronte a un accostamento imprescindibile, quello dei «prodotti» e dei «politici» all’insegna del «mercato»: si tratta infatti, in entrambi i casi, di «proiezioni di elementi dello spazio informativo di area politico-commerciale, coercitivamente ridotte a qualità di oggetti percettivi della mente individuale». Una simile avvertenza, peraltro, non ci prepara soltanto alla lettura di un romanzo dove tutto il reale , vita politica compresa, è assorbito in una logica mediatico-pubblicitaria, ma ci mette di fronte anche a quella sorta di idealismo soggettivo che è il sostrato filosofico generale di tutta l’opera di Pelevin, introducendo così quel solipsismo che contraddistingue la concezione dell’uomo dell’autore e, di conseguenza, il suo personaggio.
Quando poi, finalmente, iniziamo a leggere il primo capitolo, intitolato proprio «Generation “P”», ci rendiamo presto conto che in queste prime otto pagine c’è davvero tutto.
Incipit: «Una volta in Russia è davvero vissuta una generazione giovane e spensierata, che aveva sorriso all’estate al mare e aveva scelto la Pepsi. Ormai è difficile scoprire perché le cose siano andate così. […] Molto probabilmente il motivo era che gli ideologi dell’URSS erano convinti che di verità ce ne potesse essere una sola. Perciò la generazione “P” non aveva avuto realmente alcuna possibilità di scelta, e i bambini sovietici degli anni Sessanta avevano scelto la Pepsi esattamente allo stesso modo in cui i loro genitori avevano scelto Breznev». Dal politico al prodotto, come si vede, il passo è breve: basta crescere all’ombra deformante di un’ideologia, e la realtà percepita ne verrà docilmente plasmata. Ma l’ideologia, per la generazione russa che ha scelto (si fa per dire) la Pepsi, è già un simulacro pubblicitario, e l’uomo da essa propugnato – o meglio: propagandato – è uno scimmione che «sbuffando tutto contento, avanzava con una jeep in direzione del mare abbracciato a fanciulle che se ne fregavano allegramente della parità fra i sessi». Per cui «già allora ci voleva poco a capire che in realtà la posta in gioco non era la Pepsi-Cola, ma i soldi cui questa era strettamente connessa».
Tuttavia, l’uomo deputato a incarnare da protagonista la generazione “P” in questo romanzo è un uomo particolare, potremmo dire un’eccezione. Il suo bizzarro nome è Vavilen, perché suo padre, a sua volta un originale rappresentante della generazione precedente (quella che aveva scelto Brenev), «era riuscito a conciliare la fede comunista con gli ideali della generazione degli anni Sessanta», affibbiando così al figlio l’acronimo delle iniziali dello scrittore “eterodosso” Vasilij Askënov e di quelle di Vladimir Lenin. (L’invenzione del padre rientra del resto in quel novero di «cose dubbie e strane» che, a partire da quell’epoca, iniziavano a succedere «nella lingua come nella vita».) Il giovane Vavilen, però, si vergogna di questo nome e, prima di poter approfittare a diciott’anni dello smarrimento del suo primo passaporto per farsi rinominare Vladimir, non trova di meglio che «mentire agli amici dicendo che suo padre l’aveva chiamato così perché era un appassionato di misticismo orientale e voleva alludere all’antica città di Babilonia, la cui dottrina segreta egli stesso, Vavilen, era destinato a ereditare». Ironia della sorte (e del romanzo), sarà proprio così: un nome farsesco – un destino farsesco, parodia ostentatamente inverosimile di un’iniziazione spirituale; e il romanzo, in questo senso, non è che la divertita narrazione di questo destino e del suo progressivo rivelarsi a un personaggio sempre più dimentico di quell’originaria fantasia autopoietica, sempre più immerso nel vortice mercificante del presente assoluto in cui l’intero suo paese, a partire dalla fine dell’Unione Sovietica, si trova letteralmente “spaesato”.
Presente assoluto significa, d’altra parte, fine di ogni teleologia, fine di ogni storia e, soprattutto, fine dell’eternità – e questo è il grande tema epocale affrontato nella seconda parte di questo primo, breve capitolo.
Il fatto è che Vavilen – che il narratore chiama sempre con il cognome, Tatarskij, non meno indicativo nel suo rimandare a una centralità geografica e culturale all’interno della vastità russa – è un poeta, o meglio: avrebbe voluto diventarlo. In questo senso, il suo è un caso «assolutamente tipico»: a ventun’anni scopre le poesie di Pasternak, ne rimane folgorato e inizia a scrivere versi (di dubbia qualità, ma questo fa parte del parodismo di Pelevin). Il tentativo di entrare all’Istituto letterario si risolve però in un mezzo fallimento: respinto al concorso per entrare al dipartimento di poesia, si deve accontentare dei corsi di traduzione dalle lingue dei popoli dell’URSS. D’altro canto, ciò in cui egli crede di più sono le sublimi fatiche serali «consacrate all’eternità». Ma con la fine dell’URSS non soltanto viene a mancare a Vavilen ilcôté professionale delle traduzioni, ma la stessa eternità per cui egli credeva di lavorare inizia a dare segni di cedimento: Vavilen capisce infatti che l’eternità è «arbitraria» ed esiste soltanto finché c’è una pluralità di persone che nutra «una fede sincera nella sua esistenza», e soprattutto capisce che essa può esistere «solo grazie alle sovvenzioni dello stato, oppure (il che non cambiava) come qualcosa di proibito dallo stato». Con il venire meno di queste sovvenzioni e proibizioni, anche quella pluralità di fedeli inizia a trasformarsi, finché lo spazio dell’eternità da essi percepito non si riduce ad «una microscopica macchia sul parabrezza della mente», mentre «intorno [cominciano] a sfrecciare paesaggi di tutt’altro genere». Tutto ciò, con una precisazione: l’eternità di Vavilen è un’eternità squisitamente russa, così come lo sono la storia e la realtà a cui egli fa esclusivo riferimento (Tatarskij, davanti a una vetrina, individua il “correlativo oggettivo” della propria inattualità in un paio di pacchianissimi stivaletti «di indubbia produzione sovietica», emblema di quella che un suo vecchio docente di letteratura definiva «la nostra gestalt»). Non è del resto un caso che Vavilen, come si apprenderà nel corso del romanzo, non sia mai stato all’estero: la Russia è il suo mondo, la sua unica dimensione esistenziale, ed è esclusivamente di questa dimensione che Pelevin constata e rappresenta la rapida trasformazione. E l’antefatto di questa trasformazione è appunto quello registrato dal nuovo Vavilen (un “nuovo russo” sui generis) in un taccuino non ancora deputato ad ospitare le idee e le ispirazioni improvvise del futuro copywriter: «Quando scompare il soggetto dell’eternità [ovvero colui che la pensa e che vi crede], scompaiono anche tutti i suoi oggetti». La prima conseguenza, in questa situazione, è la perdita di senso e di valore della poesia. L’ultimo sbocco lirico di Vavilen prima di ritrovarsi in una dimensione esistenziale nuova e per lo più sconosciuta è un componimento ispirato a una canzone rock che nello stesso tempo trae spunto dalla rappresentazione dostoevskijana dell’eternità come una banja. Se l’elemento grottesco e parodico si era già annunciato fin dall’inizio, questo capitolo introduttivo si chiude quindi con una “contaminazione” che è quasi un ammiccamento, l’annuncio implicito di un’intenzione estetica, di una poetica che fonde tradizione letteraria e cultura pop in un’unica dimensione compositiva.
«Una volta scomparsa l’eternità», e con essa ogni possibile senso teleologico del tempo, la nuova dimensione esistenziale in cui si trova Vavilen è quella del «presente» degli anni Novanta. È il presente assoluto di un mondo senza più «essenza», contraddistinto soltanto da «una spaventosa incertezza». In questo mondo, Vavilen matura le sue prime “qualità” – ossia «un cinismo sconfinato» e un’intuizione concreta per i dettagli umani – lavorando in un chiosco sotto casa, finché l’incontro con un vecchio compagno di corso dell’Istituto letterario non gli schiude la prima porta su una carriera, quella del copywriter, che assumerà sempre più le caratteristiche di un’iniziazione spirituale. La struttura del romanzo, a partire da questo momento, assume l’andamento avventuroso-picaresco che il capitolo introduttivo aveva solo annunciato: ogni capitolo successivo rappresenta, in questo senso, uno stadio ulteriore di formazione e svelamento del destino del protagonista, come nei più tipici romanzi d’iniziazione; in questa evoluzione, tuttavia, non manca l’aspetto “episodico” della struttura picaresca, perché la coerenza dello sviluppo tematico è condotta attraverso l’avvicendarsi lineare di motivi e personaggi spesso nuovi e inusitati, e soprattutto perché questo aspetto evolutivo ed iniziatico non è mai davvero percepito da Vavilen come tale, né restituito dallo stile di Pelevin attraverso modificazioni più o meno finalizzate del ritmo narrativo o dei contenuti. L’autore, infatti, gioca letteralmente con le corrispondenze che devono via via suggerire a Vavilen la «forza mistica» che guida il suo cammino, ostentando un’inverosimiglianza davvero divertita nella sua improbabilità, per cui l’iniziazione si svolge sì per stadi successivi, ma solo in virtù della ripresa ironica degli elementi forniti in precedenza – ossia, in sostanza, attraverso una rivelazione progressiva in forma parodica.
Il sottotesto principale di questa ripresa parodica, lo si era già accennato con le parole dello stesso narratore, è la cultura religiosa babilonese e caldea, che viene riassorbita in una rielaborazione, a sua volta ibridamente partecipata e ironica a un tempo, dello spiritualismo new age, di cui Pelevin ha una conoscenza certamente non superficiale (basta pensare, per esempio, alla sua personale rilettura delle filosofie orientali nel romanzo che precede Generation “P”, Il mignolo di Budda). A tutto questo bisogna aggiungere le suggestioni psichedeliche che Pelevin, dotato di un’immaginazione che lo rende un degnissimo erede di quelli che la critica considera i suoi più affini predecessori (Gogol’ e Bulgakov su tutti), sa restituire con rara efficacia; e infine la sua capacità di fondere tutto questo materiale in un magma testuale coerente. È infatti da questo magma che prende poi forma quello che potremmo chiamare, una volta postulata la connotazione ironica dell’insieme, l’impianto “teorico-critico” del romanzo, che vuole la specie umana assimilata ad un immenso organismo parassitario, l’«oranus», il quale vive grazie al meccanismo dei «wow-impulsi orale, anale e dislocatorio» cui sono soggette le sue cellule monadiche, ossia i singoli esseri umani, e il cui sistema nervoso elementare è ilmedium televisivo – donde la definizione del soggetto dei nostri tempi come «homo zapiens» (dall’atto dello zapping televisivo). La teoria, tutto sommato, finisce per risultare davvero credibile come interpretazione critica del presente, russo e non, ma è Pelevin stesso a relativizzare fin da subito questa credibilità nell’economia strutturale di un’opera il cui fine sostanziale non è altro che l’opera stessa nella sua interna compiutezza: l’esposizione esaustiva della teoria è infatti consegnata ad una pseudo-trance medianica di Vavilen, che in una fase di shopping antidepressivo acquista in un negozietto chiamato «Verso se stessi», oltre alla tavoletta apposita, una canottiera di un noto gruppo rock statunitense sulla quale è stampata l’effigie di Che Guevara. Il risultato sarà l’evocazione dello spirito di quest’ultimo e la sua firma in calce alle quindici lunghe pagine di questo pseudosaggio teorico dal titolo ardito L’identitalismo come stadio avanzato del dualismo: «Che Guevara, monte Sumeru, eternità, estate».
L’elemento parodico, d’altra parte, non riguarda soltanto questo materiale di cui l’autore si avvale nell’invenzione del destino individuale del suo personaggio, ma anche un preciso sottotesto collettivo, ossia quel retroterra culturale e letterario sovietico che fin dal suo primo romanzo, intitolato Omon Ra, Pelevin aveva mostrato di saper rimettere in gioco nella propria opera. Nel caso di Generation “P”, si tratta essenzialmente di richiamare in causa frammenti di quel retroterra, della sua propaganda e della sua tradizione letteraria, coinvolgendoli nel processo degenerativo del linguaggio pubblicitario. È anzi proprio questa l’operazione che fin dall’inizio, a partire da slogan come quello per le sigarette Parliament («Come diceva Puškin: Che cosa ci riserva il giorno che nasce? Parliament. No Java»), si imprime nella mente del lettore come il segnale più forte della deriva commerciale di un’intera cultura. Esemplare, in questo senso, lo spot ideato da Vavilen durante una pausa della seduta medianica di cui abbiamo riferito più sopra: «Spot pubbl./manifesto fotografico per il Sony Black Trinitron. Primo piano della manica di una giubba militare. Dita che trinciano sigarette Herzegovina Flor e cercano qualcosa sul tavolo. Voce con accento caucasico: “Hai visto la mia pipa, compagno Gorkij? Io non la vedo. Qui non c’è un tubo”. “Come non c’è un tubo, compagno Stalin? Eccolo qua, il tubo catodico del Trinitron Plus, l’unico degno del condottiero del proletariato mondiale!” (Variante possib. – Mitsubishi – monitor View Sonic.) Rifletterci sopra».
Dall’interazione di tutti questi sottotesti scaturisce la “realtà irreale” che contraddistingue la seconda metà del romanzo, nella quale si verificano quell’accostamento tra politica e mercato e quel senso di “vuoto”, di virtualità del tutto, che si annunciavano fin dalle primissime pagine del libro. Dopo qualche tempo di lavoro più o meno precario e di esperienze mistico-allucinogene più o meno rivelatrici, Vavilen, grazie al solito ex-compagno di classe Morkovin (che ricorda la figura ausiliaria dell’aiutante delle fiabe russe), fa finalmente il suo ingresso all’«Istituto di Apicoltura», un edificio di epoca staliniana dove in realtà vengono elaborate (e non ri-elaborate) in digitale le immagini degli uomini che determinano la vita del paese. Il senso del grottesco di Pelevin raggiunge qui il suo apice: ricordo ad esempio il tappeto cosparso di cocaina nell’ufficio del capo, o l’ex-attore per bambini ora incaricato di recitare su un set segretissimo i movimenti di un Eltsin solo virtuale, o l’immagine di un Lebed-Gagarin immortalato con un coniglietto in mano al posto della colomba per la copertina di «Playboy» sotto lo slogan «La Russia sarà bella e grassottella», o ancora il problema dei megahertz controllati dagli Stati Uniti in nome di un’improbabile tutela della svolta democratico-mercantile in Russia. Perfino il «fattore islamico», in questo centro di elaborazione del destino politico della nazione, può rivelarsi un bluff virtuale, l’espediente mediatico di facciata per riparare un danno provocato ad uno “sponsor” come la J.R. Reynolds Tobacco da un designer che nelle mani computerizzate di un Lebed’ ovviamente virtuale ha sostituito un pacchetto di Camel con uno di Gitanes.
In questo contesto, anche l’ultimo capitolo (se si esclude il breve capitolo finale, che è un epilogo) può venire annunciato nel corso dell’ennesima esperienza allucinata di Vavilen come un’«ultima trasmissione» dal titolo «La stanza d’oro». È lo stadio finale, il momento dell’iniziazione definitiva, grazie alla quale il protagonista assurgerà a «dio vivente», secondo la rilettura del mito babilonese che lo vuole marito in terra della dea Ishtar: una sorta di caldeo dell’era telecratica il cui corpo «nebulizzato» apparirà incessantemente in televisione, negli spot come nei telegiornali, nei ruoli e con i mascheramenti più diversi. Tra questi, tuttavia, campeggia nel finale del romanzo quel «Tuborg Man» con cui il giovane copywriter aveva iniziato da tempo ad identificarsi “poeticamente”, mentre i suoi ultimi legami con il sogno dell’eternità andavano via via sciogliendosi e la sua trasformazione da «artista» in «creativo» si compiva nella Babele pubblicitaria globale: «Era lo spot rimasto incompiuto per la birra Tuborg con lo slogan “Sta, viator!” (variante per le emittenti locali: “Think final”) in cui prendeva vita la famosa immagine dell’etichetta con il viandante solitario. Tatarskij, con la camicia bianca aperta sul petto, cammina lungo un sentiero polveroso sotto un sole a picco. A un tratto si ferma, assorto nei suoi pensieri, si appoggia a una staccionata e con un fazzoletto si terge il sudore della fronte. Passano alcuni secondi e il nostro protagonista evidentemente si tranquillizza: dando le spalle alla telecamera si ficca in tasca il fazzoletto e riprende lentamente il suo cammino verso un orizzonte azzurro e luminoso su cui si stagliano nuvolette alte e leggere».
Il sospetto, sorto nel Vavilen reale per un brevissimo istante subito dopo la sua “elezione”, che tutto ciò sia frutto di un fatale fraintendimento del mito e della sua verità, verrà rapidamente sopraffatto dal senso e dall’esercizio immediati del potere acquisito: il nuovo “sacerdote” dell’irreale realtà «politico-commerciale» russa non avrà più bisogno di pizzicarsi violentemente le zone del corpo più ricche di terminazioni nervose per scacciare le insidiose domande sulla “verità ultima” che un tempo facevano pericolosamente capolino nei suoi pensieri («E allora su cosa si basa tutto questo?», «Chi è il farabutto che ha scritto questa sceneggiatura?», «Davvero tutto ciò accade solo per far sì che un qualche trippone di un mondo superiore tiri su un bel gruzzolo da questa specie di pubblicità?»), semplicemente perché egli avrà capito che, in assenza di una risposta effettiva – se si esclude quella, estemporanea, che consegnerebbe il tutto alla «ferrea legge della necessità» – la stessa domanda non ha alcun senso. Lo avrà capito, o meglio: lo avrà definitivamente dimenticato.

 Lo Zibaldone campano di Enrico De Vivo
Lo Zibaldone campano di Enrico De Vivo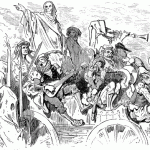 Don Chisciotte disoccupato
Don Chisciotte disoccupato Nell’oceano della scrittura digitale
Nell’oceano della scrittura digitale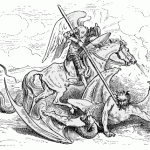 Hermann Broch e il romanzo polistorico
Hermann Broch e il romanzo polistorico





















