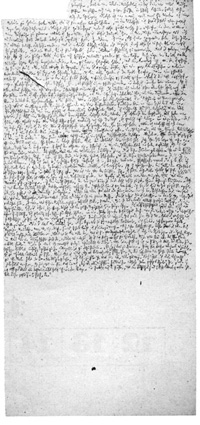
“Guardando attraverso la lente. Esperienze di un decifratore”, è questo il titolo del modesto contributo che presento nell’ambito dell’iniziativa bolognese. Ma non voglio fare giri di parole; preferisco entrare subito in argomento e dirvi che l’esperienza fondamentale del decifratore Echte è stata quella dell’errore. Per dirla con Franz Hessel, ‘Gli errori degli amanti’; anche così avrei potuto intitolare questa mia relazione. Infatti Werner Morlang ed io senza ombra di dubbio abbiamo amato durante il nostro lavoro questi fogli misteriosi e affascinanti. Dunque, veniamo alla nostra ‘scuola dell’errore’. In che cosa consisteva?
Posso dire che la parola errore si riferisce qui sia al fenomeno della micrografia in senso lato, sia, in dettaglio, ai diversi modi di lettura di singole espressioni. Si trattava di errori che di volta in volta venivano corretti nel corso di un lungo e laborioso processo di chiarificazione.
Mi ricordo ancora bene il primo testo sconosciuto con cui posi mano al lavoro nell’estate del 1980. Si trattava di una scena dai fogli 185 e 177 , ossia due di quei 117 fogli di carta patinata nei quali la grafia di Walser è ancora di calibro relativamente grande e ben leggibile. Nel componimento in questione un erudito conversa con una ragazza. Una ‘ragazza sulla nuvola’ (Mädchen auf dem Wolke), così decifrai, in modo ardito, la grafia, e pensai che nei microgrammi Walser utilizzasse immagini quasi surreali. Ma successivamente si insinuò il dubbio e poco tempo dopo constatai che in effetti si trattava di un ‘ragazza del popolo’ (Mädchen aus dem Volke).
Dal punto di vista empirico l’errore è facilmente spiegabile: nella micrografia di Walser non è possibile distinguere ‘s’ da ‘f’, ‘W’ da ‘V’ , anche molte altre lettere così come gruppi di lettere risultano tra loro pressoché uguali. Ma forse il dato più interessante in tutto ciò è quello relativo alle aspettative dei nostri sensi.
All’epoca, quando Werner Morlang ed io cominciammo la decifrazione, la prosa bernese di Walser era ancora fortemente sospettata di stranezza che, laddove la sperimentazione si faceva più ardita, minacciava di scivolare nella stravaganza, anzi nel patologico. Si pensava di dover tener conto in certo qual modo di cadute di stile e di oscurità tematiche e si riteneva che ci si potesse costantemente imbattere in qualcosa di sconveniente se non, appunto, di patologico. Solo così si può spiegare, a mio avviso, il fatto che Jochen Greven e Martin Jürgens, pionieri nella decifrazione dei microgrammi, nella trascrizione del Räuber-Roman (Romanzo del brigante) proponessero modi di lettura decisamente astrusi. Citare oggi queste dizioni sarebbe per loro probabilmente imbarazzante. Eppure Martin Jürgens avrebbe dovuto essere del tutto immune da una frettolosa patologizzazione dei testi walseriani; infatti egli fu il primo a dimostrare con la sua monografia sull’autore di Biel l’infondatezza e l’insostenibilità metodologica del ‘sospetto patologico’ allora vigente. E tuttavia si riteneva Walser capace di scrivere sciocchezze, ad es. si arrivò a credere che egli avesse utilizzato una parola come ‘Singeliheiten’ (che si pensava l’autore potesse aver derivato dal francese ‘cinglé’, ossia ‘sferzato’) , laddove invece in verità aveva scritto ‘Simpelcheibe’ (sempliciotto). Anche i migliori e i più esperti conoscitori di Walser non avevano in quel momento capito, o almeno così sembra, la pregnanza, dell’espressione walseriana relativa al proprio stile inesorabile (Unerbittlichkeitsstil). Che Walser, nonostante le audacie linguistiche, nonostante i neologismi e le espressioni sperimentali, fosse già nelle sue bozze uno stilista di strettissima osservanza, un autore che come nessun altro si vietava sin dalla prima stesura di un testo qualsiasi trascuratezza, a questa cognizione allora nessuno di noi era arrivato.
Certo questo era comprensibile: il fenomeno della micrografia non suggeriva che veniva per lo meno toccato il confine tra normalità e patologia? Non si poteva forse aprire un qualsiasi manuale di psichiatria e trovarvi esempi di micrografia simili alla scrittura lillipuziana dell’autore di Biel? Almeno così sembrava. Inoltre, lo stesso Carl Seelig aveva messo in correlazione la micrografia di Walser con la sua ‘malattia psichica’. Nel corso dei due decenni che ho trascorso presso l’archivio Robert Walser, ho avuto modo di conoscere una buona dozzina di psichiatri e tutti, senza eccezione e con stupefacente sicurezza, sono arrivati allo stesso verdetto: l’autore della grafia era schizofrenico o psicotico. Soltanto uno di loro ha preso in considerazione alcolismo o morbo di Parkinson. Coloro che hanno una qualche familiarità con psichiatri saranno forse della mia stessa opinione laddove affermo che il modo di rapportarsi alla propria fallibilità non è certamente la migliore qualità di tali medici. E ritengo che questo non debba meravigliare. Se il comportamento umano viene ridotto a dei ‘sintomi’ e il destino di un individuo viene spiegato con cause ‘endogene’, la diagnosi stessa metterà al riparo da dubbi e incertezze. Spero di avere in futuro l’opportunità di mostrare attraverso una critica metodologica, scientifica, che in campo psichiatrico la concezione di malattia si fonda su di un pensiero pre-illuminista e che un concetto come quello di schizofrenia ha la stessa struttura logica che nel XVII e nel XVIII secolo era alla base del termine ‘flogìsto’. Tale parola indicava un elemento dell’aria, elemento di cui tuttavia, nonostante continue ricerche, non si riuscì a dimostrare l’esistenza. Con questa parola era nata anche un’ipotesi errata, che non poteva condurre alla comprensione del vero fenomeno. Qualcosa di analogo si è verificato con il termine schizofrenia, che costituisce una ipotesi troppo semplice per la designazione di un fenomeno estremamente multiforme e induce ad una sistematizzazione fuorviante e non produttiva di tutti i casi che appaiono riconducibili a tale patologia. Fu addirittura Freud a criticare, già nel 1913, l’errore logico-concettuale alla base del termine schizofrenia, ma sino ad oggi si è sempre ignorata la sua valida obiezione. Sotto questo aspetto, nella psichiatria ancora manca l’esperienza dell’errore. Per lo studioso di letteratura è particolarmente difficile sottrarsi alla autorità interpretativa della psichiatria, in quanto lo stesso Walser è stato in istituti di cura per malattie mentali e ha confessato a Carl Seelig di aver avuto profonde crisi negli anni ’20. I suoi fogli scritti a matita sono un riflesso di ciò? Sono un semplice rispecchiamento di una crisi? Sono un prodotto di patologia latente o manifesta? Anche in questo caso, ho fatto l’esperienza dell’errore, e cioè – così oggi sono portato a credere – in un modo tipicamente walseriano. Come spesso accade nella vita e nella produzione dell’autore di Biel, anche qui, ad uno sguardo superficiale, l’apparenza inganna. Così come per lo ‘stile inesorabile’, anche per quanto riguarda la comprensione della micrografia Walser stesso ha fornito la spiegazione – la si deve solo prendere sul serio. Inizialmente non si riusciva a considerare il fenomeno dalla prospettiva giusta; responsabile di tale dato era forse la parola ‘microgramma’ (Mikrogramm) che partiva, credo, da un’ipotesi sbagliata. Il termine era stato scelto da Jochen Greven sulla scorta di ‘stenogramma’ (Stenogramm), in quanto egli supponeva che Walser avesse rimpicciolito il calibro per poter scrivere più velocemente, questo nella speranza che la grafia divenisse più fluida e che ciò potesse contrastare le sue difficoltà di scrittura. Jochen Greven da un lato, Werner Morlang ed io dall’altro abbiamo frequentemente discusso, spesso animatamente, di tale questione e oggi sono più che mai convinto che l’ipotesi della accelerazione è stata uno di quei tipici errori in cui l’autore di Biel induce così facilmente. Alla base di ciò si supponeva un Walser scosso dalla crisi, il quale per superare il suo blocco psicologico doveva in certo qual modo nascondere a se stesso la scrittura, cercando di sottrarla alle coordinate spazio-tempo e spingendola così al limite della percettibilità. Anch’io per diverso tempo ero di questa opinione, ma devo dire che ora mi sono ricreduto. Questa teoria era infatti ‘costruita’ dall’esterno. Ma quando io stesso ho preso in mano la matita e mi sono imposto di produrre un foglio calligrafico di ‘microgrammi’, ho capito rapidamente i termini della questione. La precisione, la mobilità e la modulazione motoria, la regolarità e soprattutto la singolare concentrazione delle righe, tutto questo non poteva essere il risultato della accelerazione, al contrario: tali qualità, incrementando la velocità di scrittura, non si potevano realizzare, piuttosto esse andavano perse. Inoltre, dato questo più significativo, delineando velocemente una grafia così fitta e così minuscola, la mano, il braccio, il collo, la cintura scapolare dopo poco tempo erano come pietrificati. In altri termini, mi venne un ‘crampo da scrittura’. Vorrei raccomandare a chiunque si interessi al fenomeno della micrografia di intraprendere questo tentativo. E vorrei anche consigliare di non interrompere l’esperimento prima di aver portato a termine almeno un foglio a matita della gracile bellezza e regolarità che caratterizzano i 526 fogli che Walser produsse tra il 1924 e il 1933.
Se vi sottoporrete a questo esperimento, sarete protagonisti di una singolare esperienza: inizialmente il vostro avversario sarà l’irrigidimento che percepirete e che dovrete calmare. E dovrete a questo punto imparare a dominare voi stessi, ad avere pazienza, dovrete cioè imparare a concentrarvi più sul percorso che sulla meta. La priorità andrà alla riuscita dell’atto grafico, non al tentativo di fissare in fretta e furia qualcosa che avete pensato. Inizierete a scrivere in modo più tranquillo, più rilassato, poiché potrete constatare che, mentre disegnate in maniera attenta e misurata una frase, improvvisamente da questa stessa si generano nuove idee. In tal modo, sperimenterete la lenta produzione dei pensieri nel corso della scrittura e ne sarete felici: non avreste mai pensato di essere repentinamente visitati da così tante idee.
Un fiume che scorre velocemente procede diritto; un fiume che scorre lentamente, invece, serpeggia, forma meandri, deviazioni, ampliamenti, cercandosi ovunque nuove vie. Qualcosa di simile si può dire per lo stile ornamentale, a tratti digressivo, di Walser, alle cui frasi egli dà modo di sviluppare il proprio andamento, il proprio ritmo. Non c’è l’intenzione di realizzare qualcosa strumentalmente, in fretta, così come si può. Volontà espressiva e contenuto espressivo si sviluppano insieme durante la realizzazione dello scritto; in tal modo voler dire (meinen) e dire (sagen), volere e potere finiscono, idealmente, per coincidere. L’ideale si identifica con il manoscritto bello esteticamente, gracile nei dettagli e nell’insieme delicato, un foglio calligrafico delle Mille e una notte. Il manoscritto ‘bello’: ho impiegato non poco tempo a capire quanto fosse importante per Walser l’aspetto esteriore di ciò che scriveva. Infatti egli poteva capire da questo, e solo da questo, che aveva realizzato un vero atto creativo derivante da ciò che c’era in lui di puro, di integro. “Scoprivo continuamente che c’era in me qualcosa di integro”, afferma Walser in una prosa, come se egli stesso fosse meravigliato che questa sua fonte non si inaridisse.
Naturalmente parte integrante della attività letteraria di Walser erano anche afflizioni e contrasti di diverso tipo, delusioni personali, irritazione nei confronti di colleghi privi di tatto, di editori e redattori, ma il flusso serpeggiante delle frasi riusciva a metabolizzare, ad eliminare tali resistenze, o meglio, per dirla metaforicamente, a trasformare tutto in allettanti ghirlande linguistiche e grafiche.
“Scrivere sembra derivare da disegnare”, si legge nella prosa Sätze (Frasi). Disegnare e designare: in Walser è ben evidente l’origine comune di queste due forme. Esse si combinano, si intrecciano in maniera concreta, visibile. I rari casi dove la scrittura non riesce al primo colpo, dove dunque c’è bisogno di correzioni, non si notano affatto in quanto i tratteggi delicati e regolari usati per cancellare blocchi di testo nell’insieme creano un’immagine di completa bellezza.
“Il foglio sa quanto è bello?”, si chiede Walser in uno degli ultimi testi – dal titolo lapidarioProsastück (Prosa) – scritti poco prima del ricovero a Waldau. Egli stesso era ben consapevole del fatto che i suoi fogli fossero belli, in quanto questa bellezza era la condizione, il presupposto per la riuscita della sua attività. Questi fogli erano la prova evidente di un esercizio di guarigione che sempre andava a buon fine, esercizio che era cominciato a causa di un fastidio nell’uso della penna, la quale procurava crampi della mano. La ‘lotta’ con la penna, paradossalmente, aveva indotto Walser a provocare poi il disagio per poterlo superare, procedimento questo che implicava, a detta dello stesso autore, “una accresciuta fatica. Ma tuttavia”, così si legge in Bleistiftsskizze (Schizzo a matita), “poiché per me tale fatica era in certo qual modo un divertimento, mi sembrava, così facendo, di guarire. Nella mia anima nasceva ogni volta un sorriso di soddisfazione […] per il fatto che vedevo me stesso essere attivo letterariamente in modo così accurato. Mi sembrava, tra l’altro, di lavorare con la matita in modo più sognante, più tranquillo, più riflettuto; credevo che questo modo di scrivere mi portasse ad una forma particolare di felicità”. Ma se era così, come si possono spiegare quelle crisi degli anni bernesi, crisi di cui Walser parla a Carl Seelig e alle quali fa riferimento anche nei suoi testi. Come mai Walser è finito in clinica? In merito posso dire soltanto che tale forma particolare di felicità evidentemente non escludeva la crisi. Di entrambi questi fenomeni i sei volumi Aus dem Bleistiftgebiet (Dai fogli scritti a matita) costituiscono una testimonianza toccante, anche se ritengo che l’esperienza della felicità, del riuscire, nonostante tutto, nel proprio intento, prevalesse. Walser ci ha lasciato nei suoi microgrammi non meno di 2000 pagine di testi. Tuttavia, che questi testi all’epoca fossero rimasti sconosciuti può essere interpretato come un segno del fatto che il mondo letterario non era pronto a recepire una produzione siffatta. Nella sopra menzionata prosa Bleistiftskizze Walser si esprime con cautela: “Io credevo”, afferma oscillando tra la forma del passato e quella della possibilità, “che questo modo di scrivere mi portasse ad una forma particolare di felicità”. Egli era in ogni momento consapevole che questa felicità era precaria, soggetta a minaccia, in bilico sulla punta della matita come sulla lama di un coltello. Come nel 1919, quando, riflettendo sull'”ultima prosa”, Walser finisce per creare un ulteriore componimento, anche negli anni successivi egli continuerà a produrre letteratura secondo un procedimento analogo.
“Le affermazioni vogliono dire il proprio contrario”, scrive Canetti. Un paradosso simile si trova nei fogli a matita di Walser. Anche i pensieri di suicidio di cui recano traccia due poesie del sesto volume finiscono per testimoniare il proprio contrario, ossia la continua creatività, vivacità di Walser, il quale si mostra in grado di trasformare tali esperienze dolorose in una delicata immagine grafica, in un affascinante foglio di script art. Permane certo una certa dose di sarcasmo: “Rallegriamoci di questa vittoria dell’arte”, si legge alla fine del ‘Räuber’-Roman. Ma si trattava di una sorta di vittoria di Pirro, in quanto sia quest’opera che le sopra menzionate poesie con pensieri di suicidio rimasero nel cassetto di Walser, senza che egli le trascrivesse, rimasero cioè nella scatola di scarpe contenente i suoi manoscritti. Lo stesso si può dire di diversi brani in cui l’artista confessa di “non poterne più della scrittura” o di sentirsi oppresso dal tran tran quotidiano. Egli non nega di essersi più volte avvicinato al confine del totale venir meno della scrittura; Walser sposta questo confine sempre più avanti, allontanandolo da sé. Rispetto a questa arte di autoterapia e di rigenerazione il Barone di Münchhausen è da considerarsi un acciarpone privo di fantasia.
Ma quando Walser nel gennaio 1929 si rese conto che il prezzo di questa arte eroica era troppo alto e, in seguito a vicende imbarazzanti occorse con le proprietarie della stanza in cui alloggiava, chiese alla sorella Lisa di potersi stabilire da lei per un certo periodo, alla donna mancò il coraggio di accogliere il fratello e di offrirgli protezione. Il risultato di questo rifiuto, che è al tempo stesso comprensibile e riprovevole, è ben noto a tutti: il ricovero nella clinica di Waldau. Chiedersi oggi se all’epoca non ci fosse stata un’alternativa a tale destino è ozioso, vorrebbe dire cercare di afferrare il vento. Ma la volontà walseriana di affermarsi letterariamente non si era ancora esaurita. Dopo un certo lasso di tempo, egli di nuovo prese in mano la matita.
I testi del quinto e sesto volume dell’edizione Aus dem Bleistiftsgebiet ci conducono molto vicino al momento decisivo della ospedalizzazione. Troviamo infatti qui prose e poesie che sono state scritte poco prima del ricovero e anche testi stesi durante il soggiorno presso la clinica di Waldau. Questi ultimi si distinguono dalla produzione precedente? Contengono forse indicazioni in merito allo sviluppo psichiatrico dello scrivente? La risposta è semplice: no. Ora come in passato la letteratura walseriana procede – per usare le parole dell’autore stesso – come se “il tempo sia stato sempre tempo, lo spazio sempre spazio, l’essere umano sempre essere umano, l’erudizione sempre erudizione, il bello sempre il bello.” L’unica differenza risiede forse nel fatto che i testi del periodo di Waldau evidenziano tutto ciò in maniera ancora più contenuta che in passato. Anche la bellezza dei fogli a matita ora non palesa più la ricchezza grafica di un tempo. Walser scrive a Waldau pochi testi, che annota sui suoi foglietti in maniera chiara, delicata, impeccabile, utilizzando un calibro minutissimo, ai limiti della percezione visiva. Si annuncia qui una graduale revoca dello scrivere? Forse ora la letteratura appare a Walser – come egli in precedenza aveva annotato – “comica”?
È in fondo “come se non fosse successo niente”? È vero che “nessuno gli ha fatto nulla”? Tutto è accaduto come per caso? Cosa ha pensato la sua “anima ebbra di bellezza”?
Voglio terminare prima di perdermi in ulteriori errori.
(Traduzione dal tedesco di Anna Fattori)

 Fantasia walseriana - Marco Ercolani
Fantasia walseriana - Marco Ercolani Intorno a Preferisco sparire. Colloqui con Robert Walser 1954-1956 - Marco Ercolani
Intorno a Preferisco sparire. Colloqui con Robert Walser 1954-1956 - Marco Ercolani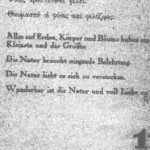 Come reimparai a scrivere - Robert Walser
Come reimparai a scrivere - Robert Walser Perché mi piace viaggiare - Robert Walser
Perché mi piace viaggiare - Robert Walser





















