
Giacometti, Equilibrio
Il vecchio aveva deciso di arare il terreno in pendenza anche se era piovuto da poco e nell’ultimo tratto in discesa, al momento di far manovra, il trattore s’è ribaltato e lui c’è finito sotto. Da quel giorno non ha più mosso le gambe e ha dovuto vendere tutto, vacche, maiali, conigli, oche e tacchini, tutto tranne le galline, perché almeno nel pollaio riusciva a cavarsela sulla sedia a rotelle. Aveva sistemato una passerella di legno per superare il gradino e le galline sembravano capire che la situazione non era più la stessa visto che rimanevano dentro con la porta aperta. Quanto alla vecchia, lei aveva l’Alzheimer e non s’era accorta di nessun cambiamento.
Al tempo dell’incidente loro figlio era già sposato e faceva il chimico industriale in una ceramica della zona. Abitava in un altro comune ma finito il lavoro passava dai due vecchi, prendeva la roba sporca da lavare, spazzava per terra, tirava lo straccio, dava il deodorante per togliere l’odore di urina e dopo preparava qualcosa da mangiare. E siccome era rimasta la vigna c’era da far qualcosa anche in campagna.
Ma un giorno, mentre stava preparando il verderame, il figlio è tornato in casa e si è seduto davanti al vecchio. L’ha guardato in silenzio senza dire niente, poi ha detto che lui non ce la faceva più, che aveva anche un’altra famiglia, cioè una moglie e due figli, e non poteva continuare a perder tempo con l’uva quindi aveva deciso di estirpare tutto. Il vecchio s’è limitato a guardarlo in faccia muto come una statua ma il giorno dopo s’è fatto trovare con le braghe piene di merda, e se qualcuno avesse osato toccare la vigna lui si sarebbe cagato addosso dalla mattina alla sera per tutto il tempo della vita che gli rimaneva da vivere.
Quanto al resto della famiglia, il figlio del vecchio aveva sposato una donna che aveva il padre che lavorava all’ambasciata italiana di Buenos Aires, e al momento della pensione aveva deciso di stabilirsi in Argentina con la moglie perché gli sembrava un posto adatto per passarci la vecchiaia, ma poi era arrivato il crac finanziario che aveva mandato in fumo i suoi risparmi e sei mesi dopo era morto per arresto cardiaco. In seguito, passato un anno, dato che la pensione di reversibilità che spettava alla moglie non arrivava, lei aveva era ritornata per vivere vicino alla figlia, solo che poi, col passare del tempo, dodicimila chilometri lontani dal marito sepolto le erano sembrati un’enormità e ha cominciato a insistere per tornare a Buenos Aires. Oppure per riesumare la salma e trasferirla in Italia. La figlia sperava di distoglierla dal chiodo fisso del marito oltreoceano e le parlava dei bambini, che erano il futuro, diceva alla madre, ed era meglio se pensava a loro, ma lei non mostrava nessun attaccamento per i nipoti e s’è abbandonata alla tristezza. Così ha iniziato a piangere, e piangeva per davvero dalla mattina alla sera.
I nipoti erano due. Il primo che ho conosciuto è stato il maggiore, uno che aveva in mente solo i cavalli. Me lo ricordo perché in primavera c’era la fiera del cavallo e lui mi portava gli inviti convinto di farmi un piacere. Erano cinque anni che ci andava e l’ultima volta era orgoglioso per un incarico svolto allo stand del rodeo. Un ragazzo alto come una pertica che vestiva da vecchio, con dei pantaloni in fustagno, oppure di lana col risvolto in fondo e la piega stirata. E mai una volta che girasse la testa verso una ragazza. Essendo il più alto della classe stava seduto all’ultimo banco, teneva la schiena dritta e non faceva mai una domanda. Ma più che altro era il modo come guardava che faceva impressione, sguardo fisso, dritto, senza batter ciglio, e un sorriso accennato che sembrava beffardo e invece era solo un tic nervoso. Durante l’intervallo rimaneva al banco, tirava fuori un panino al burro, mangiava e sfogliava una rivista di cavalli.
Il secondo l’ho conosciuto quattro anni dopo e la prima volta che l’ho visto l’ho scambiato per il fratello maggiore. Era tale e quale a lui, e come l’altro sedeva nell’ultimo banco. Forse un po’ più alto e ancora più magro, un torace stretto, da piccione, e una faccia cavallina. Quanto alle ragazze, stessa cosa, né lui si degnava di guardarle né una ragazza s’è mai girata verso di lui. La differenza più spiccata tra i due fratelli, per quello che mi ricordo io, era che il giovane mangiava il panino senza burro, non nominava i cavalli, e l’unica volta che ha fatto una domanda ha chiesto come si faceva la polvere da sparo.
Tutta questa storia mi viene in mente perché qualche giorno fa ho incontrato la madre coi due figli. Erano in macchina e guidava il più vecchio. Facevano retromarcia lungo una strettoia dove non si riusciva a manovrare. Allora mi sono avvicinato e ho allungato la mano per salutare, prima alla madre poi al fratello maggiore. Lei ha cercato di dire qualcosa di spiritoso mentre lui aveva stampato in faccia il solito mezzo sorriso. Ho chiesto come andava tanto per dir qualcosa perché bastava guardarli per sapere come andava. E infatti lei, tanto per dare un’idea, ha detto che un suo cugino di Parma le aveva consigliato un viaggio al santuario di Padre Pio, a vedere se poi le cose andavano un po’ meglio. Era stata lei a raccontarmi tutta la storia della famiglia, durante le ore di ricevimento genitori. Veniva ogni settimana.
Io non li vedevo dai giorni degli esami, quando il più piccolo era stato bocciato, e volevo sapere come l’aveva presa suo padre, ma non avevano ancora trovato il coraggio di dargli questa delusione, e il padre era convinto che il figlio minore fosse iscritto all’università. Invece doveva ripetere l’anno e non sapeva se l’avrebbe fatto, ha detto la madre. Intanto lui stava seduto dietro e non fiatava. Guardava il muro alle mie spalle, e lo fissava così tanto che m’è venuto da girar la testa anche a me. C’era scritto Betta ti amo.
Una volta la madre era venuta a scuola per dire che s’era ammalato e lo doveva tenere a casa per un mese. Era successo che il padre prima di estirpare l’ultimo filare di vigna voleva che i figli imparassero a potare e li aveva portati in campagna, solo che era gennaio, c’era la neve per terra e dalla costa del monte scendeva un vento gelido. Il giorno dopo il più giovane aveva la febbre e s’è fatto un mese di broncopolmonite con versamento pleurico. Quando è tornato a scuola era così sottile che poteva passare dalle inferriate della cancellata.
E quando li ho incontrati in macchina, benché fosse seduto, m’è bastata un’occhiata per capire che era stata la sua magrezza la cosa che m’aveva impressionato di più. L’abbigliamento, il silenzio, l’isolamento che aveva attorno, le frasi a bassa voce, quasi inascoltabile, la lentezza, il panino asciutto, senza burro, era tutto secondario, cioè tutti aspetti che improvvisamente mi sono sembrati una conseguenza della sua magrezza, e mi sono ricordato di un giorno di primavera, quando durante l’intervallo avevo alzato la testa mentre l’aula era vuota e c’era solo lui. Era là che guardava fuori della finestra e a me era venuto in mente che poteva diventare un campione del digiuno, cioè pensavo che se l’arte del digiunatore fosse stata una disciplina sportiva, o perlomeno una disciplina artistica, lui sarebbe diventato un vero campione, e senza sforzo, un prodigio per semplice costituzione naturale, un artista della fame capace di rimanere chiuso in una gabbia per un mese intero senza toccare cibo, e senza parlare con nessuno, senza bere, e sarebbe sopravvissuto perché sembrava privo di necessità, un organismo ridotto all’essenziale che non richiede il consueto scambio col mondo, nemmeno sotto il profilo alimentare, un sistema fisico e psichico a bassissimo consumo che forse non emetteva scorie e poteva preservare intatta la sua magrezza. L’avrebbero studiato, gli avrebbero dato un premio per questa arte della rinuncia, e in nessun altro settore avrebbe ottenuto tanto successo.
Durante gli scrutini d’esame, arrivati a discutere del suo caso, io ero per farlo volare via, aprire le porte e lasciarlo andare come se fosse un passero in gabbia, e per spiegare qualcosa della sua vita m’era scappato detto che forse la madre faceva il medico all’ospedale, l’avevo sentito dire, ma nessuno dei colleghi voleva crederci, era impossibile, con due figli del genere, e hanno insistito così tanto che a forza d’insistere mi hanno convinto che mi sbagliavo e forse faceva l’infermiera, ho detto. Ma quando li ho incontrati mentre facevano manovra, prima di andar via ho fatto cenno al suo lavoro ed è saltato fuori che era proprio cardiologa, all’ospedale di Parma, ma mi sembrava tutto così inverosimile che il giorno dopo ero di nuovo insicuro, e forse avevo capito male.
Lo volevano bocciare già l’anno prima, questo fratello minore della famiglia Saccani, ma in quarta il cognome l’aveva salvato perché in ordine alfabetico veniva alla fine, e dopo la carneficina, i colleghi si erano fatti prendere dalla stanchezza, cinque bocciati erano sufficienti, aveva detto il professore di matematica, però se lo scrutinio fosse iniziato dalla zeta, Saccani sarebbe stato il primo a rimetterci le penne.
Io comunque l’avrei promosso anche quest’anno ma l’esame è diventato un conteggio e occorre un minimo stabilito, ormai non c’è niente da fare e i santi protettori dovrebbero pensarci prima, se hanno idea di salvare qualcuno, perché adesso il risultato finale si ricava come il saldo in banca, un atto di contabilità fra entrate e uscite, dato che nella scuola s’è imposto il modello della partita doppia.
Dunque promosso in quarta e bocciato in quinta, il giovane Saccani. L’unico bocciato della classe. E alle sette e mezzo di sera quando il gruppo dei professori commissari stava scendendo per consegnare in segreteria il pacco dei verbali con le prove e tutti gl’incartamenti dell’esame, appena girato l’angolo, dopo l’ultimo gradino, s’era intravista la famiglia Saccani che aspettava il verdetto nell’atrio in fondo al corridoio. Allora i colleghi commissari si sono fermati subito come se avessero dimenticato un documento prezioso da includere nel pacco. Nessuno voleva incrociare la madre e i due fratelli. E dopo essersi consultati, due di loro sono tornati su per le scale per uscire dalla parte del cortile, e altri due hanno imboccato l’uscita di sicurezza facendo scattare l’allarme. Naturalmente sono fuggiti quelli che volevano la bocciatura e così siamo rimasti io e la collega di storia dell’arte, ma anche lei avrebbe fatto carte false pur di scappare solo che è zoppa.
Davanti alla madre che ci guardava in silenzio non abbiamo detto niente. E’ bastato lo sguardo. Poi lei è scoppiata a piangere e il fratello maggiore s’è fatto avanti prendendola sotto braccio come se fosse lui il marito mentre l’altro fratello se ne stava in disparte indifferente alla bocciatura. Poi il maggiore ha detto qualche parola, ma erano frasi smozzicate che pronunciava col tipico sorriso che quattro anni prima l’aveva salvato all’esame perché quel sorriso lasciava intendere una profondità che non c’era, ma se i due fratelli fossero stati gemelli, e il più vecchio avesse dato l’esame quattro anni dopo nella stessa commissione del più giovane, allora non ci sarebbe stato niente da fare per nessuno dei due. E invece adesso frequentava il quarto anno di medicina, il maggiore, e si capiva che era lui la consolazione della madre.
Quella sera, dopo che la madre aveva smesso di piangere m’aveva chiamato in disparte per dirmi qualcosa di riservato, cioè che il figlio più piccolo era sempre stato un bambino sfortunato, soprattutto a scuola, fin dalle medie, e già in seconda i suoi compagni lo picchiavano senza motivo. Era alto ma non reagiva, rimaneva fermo a prenderle in silenzio e il pestaggio si ripeteva ogni giorno senza che lui dicesse niente a casa. Lei s’era accorta di qualcosa solo perché una sera era entrata in camera sua mentre lui si metteva il pigiama, e aveva visto un torace pieno di lividi. Avevano provato in tutti modi a farlo reagire, gli dicevano di darle indietro, soprattutto il nonno che lo teneva al podere sperando che a forza di spalare il letame acquistasse qualcosa della rudezza campagnola, ma non era servito a niente e alla fine l’avevano trasferito in un’altra scuola.
E poi la madre mi ha raccontato anche un’altra cosa, cioè che gli ultimi mesi prima dell’esame l’avevano mandato in cura da uno psicologo che si mostrava molto ottimista. Garantiva che superato l’esame, il ragazzo avrebbe cambiato tutto nella sua vita, avrebbe trovato la fiducia che gli mancava e la grinta che occorreva per andare avanti, e sarebbe andato all’università, e grazie alla vita nuova avrebbe conosciuto nuovi amici e perfino una ragazza, e si sarebbe meritato un lavoro prestigioso al termine degli studi, una professione in cui avrebbe fatto valere le sue doti di pazienza, diceva lo psicologo alla madre le volte che si fermava per sapere come andava. Dunque il ragazzo veniva incoraggiato ad affrontare l’esame con fiducia in se stesso, e la madre a sperare nel fatto che l’ultimo anno non si bocciava mai.
A me, mentre la madre raccontava delle prospettive che le faceva intravedere lo psicologo, erano venute in mente le prospettive della lattaia che nella favola andava al mercato pensando a cosa fare col ricavato della brocca piena di latte. E credeva di comprare due pulcini, che poi sarebbero diventate galline e avrebbero prodotto delle uova, e col ricavato avrebbe comprato un agnellino, e con la lana un vitellino, e il vitellino crescendo avrebbe reso il necessario per comprare l’abito da sposa, ma poi, pensando al matrimonio, la lattaia era inciampata su un sasso e la brocca s’era rotta.
Quella sera che dopo gli scrutini il grosso dei colleghi se l’era svignata, io sono tornato a casa e mentre stavo sdraiato sul divano per un momento ho invidiato quel ragazzo, avrei voluto disporre della sua arte per trovare un po’ di indifferenza e azzerare il rapporto col mondo. Poi mi sono tirato su e mi sono preparato per uscire ma sulla soglia è suonato il telefono e anche se in ritardo ho risposto lo stesso. Era la madre che si scusava per le lacrime di un’ora prima, per il comportamento infantile, ma nel dir così ha ricominciato a singhiozzare. Io dovevo uscire subito ma non osavo interromperla, e quando alle fine si è calmata, prima di mettere giù, ha detto che comunque la bocciatura era stata un’ingiustizia perché suo figlio non era da meno di Veroni.
Io non ho detto niente perché aveva ragione, ma cos’avrei doduto fare? Impuntarmi? Ad esempio dire ai colleghi: signori colleghi professori, fermi tutti, che se bocciate Saccani dovete bocciare anche Veroni. Benissimo! avrebbero detto i colleghi professori, bocciamo anche Veroni. Ma per Saccani non sarebbe cambiato niente se avessimo bocciato anche Veroni. O forse sì, qualcosa sarebbe cambiato perché la madre di Saccani era andata a vedere i tabelloni dei voti, e in mezzo a un gruppo di ragazzi c’era anche lui, Veroni, che ridacchiava perché la commissione aveva individuato il vero somaro della classe.
Poi c’è stata la cena di fine anno e mentre andavo verso il ristorante con la mia collega di storia dell’arte lei parlava mentre io volevo parlare di qualcos’altro, e quando siamo entrati al ristorante mi sono reso conto che Veroni era improvvisamente antipatico. Faceva lo spiritoso raccontando delle barzellette e cercava la mia approvazione ma io non riuscivo a far valere la presunzione di innocenza e lo guardavo in faccia. E anche un altro m’è sembrato improvvisamente antipatico perché non so quante volte aveva ripetuto che a lui sarebbe bastato un calcio in culo, per uscire, mentre invece, adesso che il minimo dei voti l’aveva raggiunto, se ne stava col grugno pieno di rabbia, e non appena gli ho chiesto cos’aveva è saltato fuori che aveva da recriminare sul voto perché l’esame l’aveva fatto molto bene, secondo lui.
Al momento dei saluti ho anche chiesto come mai non c’era Saccani, e dopo che tutti si sono guardati in faccia con aria interrogativa, come per cercare un suggerimento, è stato chiaro che nessuno gli aveva detto niente.

 La moglie di Nietzsche
La moglie di Nietzsche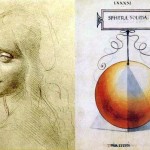 Il 25 aprile
Il 25 aprile Il sacchetto
Il sacchetto





















