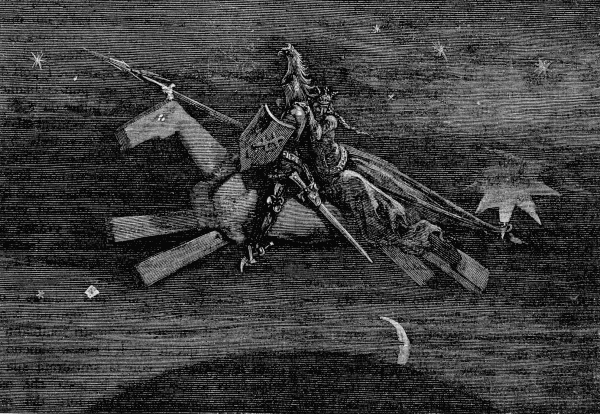
I.
Nella prima delle quattro parti che compongono Vertigini di Winfried Georg Sebald, Henry Beyle, a cinquantatre anni, rievoca l’impresa del passaggio del Gran San Bernardo, cui aveva partecipato diciassettenne a seguito delle truppe napoleoniche. Si tratta di una lunga riflessione sulle incertezze della memoria. Nel ricordo di quella fatica, fra tanti episodi, le immagini più vive sono quelle del generale Marmont a Martigny, in abito da consigliere di Stato, e della vista della città di Ivrea, immersa nella luce del crepuscolo. Beyle – che Sebald non chiama mai col suo celebre pseudonimo, Stendhal – consiglia di non comprare mai riproduzioni degli scorci e delle vedute che ci affascinano durante un viaggio: “La riproduzione infatti finisce per sostituirsi totalmente al ricordo che abbiamo di qualcosa, anzi, si potrebbe addirittura dire che lo distrugge”. Per questo, aggiunge, ci si ricorda meglio dell’impressione suscitata da qualche quadro trascurato, minore, che dei quadri mille volte riprodotti. La riproduzione distrugge il ricordo (sottrae un oggetto al suo contesto originario, direbbe Benjamin) ma soprattutto lo trasforma in qualcos’altro. Sebald sottolinea, infatti, come proprio per le sue convinzioni Beyle rimanesse profondamente deluso nello scoprire fra le sue vecchie carte un’incisione intitolata Prospettiva d’Ivrea, che corrispondeva in tutto all’immagine della città nel suo ricordo. Così pure – ma qui la coscienza era già più vigile – mette in luce come Beyle fosse ben consapevole che durante l’impresa del Gran San Bernardo il generale Marmont non avrebbe mai potuto indossare l’abito celeste e blu da consigliere: aveva indossato, più comunemente, la propria divisa da ufficiale. Eppure sono quelle le immagini in cui la memoria si è cristallizzata.
Sebald segue Henry Beyle in un bordello, nelle avventure amorose, nel suo innamoramento per l’interprete del ruolo di Carolina nel Matrimonio segreto di Cimarosa, come nelle sue visite ai luoghi dei grandi scontri. Beyle, che non aveva quasi mai preso parte ad un combattimento, si recò nel 1801 sulla spianata di Tortona dove un anno prima aveva avuto luogo la battaglia di Marengo che tanto entusiasmo gli aveva suscitato. È tutto un susseguirsi di impressioni, di ricordi fugaci, di una realtà che ha perso la sua evidenza; anzi, che per ritrovare la sua evidenza, nell’esperienza del giovane Beyle, ha bisogno dell’immaginazione.
Diversamente dalla riproduzione, il documento non si pone come una copia di qualcosa di esistente: è, di fatto, parte di quel qualcosa. La lettera autografa di un’altra epoca, come il cappello dell’attore, un certificato di nascita, o la sedia di un tribunale appartengono al contesto originario di un fenomeno (ne sono stati e forse ne sono ancora parte, in virtù del rapporto tra materia e memoria). Proprio in questo senso, seguendo ciò che del tempo va a sedimentarsi nella materia, è possibile comprendere non solo l’inganno e la delusione di Beyle di fronte all’incisione della città di Ivrea, ma lo stesso modo di operare di Sebald, che com’è noto nelle sue opere fa largo ricorso alle immagini in termini allusivi, non didascalici. Il quadro di una battaglia inserito nel testo, l’immagine di una donna, il disegno medico delle affezioni ulcerose alla gola provocate da un’infezione venerea, diventano nel libro di Sebald (nel contesto originario cui il libro dà luogo nei confronti del lettore) non una didascalia, ma un documento del racconto: parte integrante, per così dire, della sua evidenza.
II.
Ne Il filo e le tracce, prendendo in esame alcune convenzioni letterarie che mirano a produrre un “effetto di verità”, Carlo Ginzburg si sofferma sulla qualità che presso i greci costituiva uno degli elementi di maggior pregio in una narrazione, sia per gli storici che per i poeti: l’enargeia, la “vividezza”, la chiarezza del racconto, quella che Quintiliano nell’Institutio oratoria tradurrà come evidentia in narratione. Questa qualità appare a tal punto importante che, giudicando della veridicità di Omero, Polibio lo pone dalla parte della storia (e quindi della verità, in contrapposizione al mito) proprio in ragione della “vividezza” cui tendono i molti particolari apparentemente accessori inseriti nella sua opera, quali ad esempio i numerosi dettagli a corredo del Catalogo delle navi nel secondo libro dell’Iliade. L’evidenza riguarda il modo della narrazione, quello per cui “la cosa viene espressa con parole tali che il fatto pare svolgersi davanti ai nostri occhi” come scrive Cicerone, sempre citato da Ginzburg. La nozione di enargeia implica sia l’accuratezza della descrizione, sia la strategia retorica di presentazione. Anzi, per Ginzburg si può immaginare una sequenza di questo tipo: “narrazione storica – descrizione – vividezza – verità”.
La questione è centrale, lo stesso percorso della storiografia potrebbe essere descritto attraverso il mutamento della nozione di evidenza:
“La differenza tra il nostro concetto di storia e quello degli antichi potrebbe riassumersi così: per i greci e i romani la verità storica si fondava sull’evidentia (l’equivalente latino di enargeia proposto da Quintiliano); per noi sui documenti (in inglese, evidence)”. (C. Ginzburg, Il filo e le tracce, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 22)
L’evoluzione storica della nozione di evidenza è ricca di conseguenze. Guardando al problema storiografico dal punto di vista letterario, la questione sembra appunto rinviare all’alternativa tra un racconto mostrato attraverso procedimenti letterari specifici, ed un racconto costruito sulla scorta di una raccolta documentaria; tra un racconto che cerca di comunicare la visione immediata di un fatto ed uno che lo inserisce in una diversa articolazione fondata su di un documento. Da una parte, dunque, starebbe la demonstratio di un fatto, il gesto dell’oratore che punta l’indice, la descrizione persuasiva, l’ekphrasis; dall’altra, più semplicemente, la narrazione e la ricostruzione documentaria.
Pur senza proporre una vera analogia, sembra il caso di riflettere sul problema dell’evidenza anche nella letteratura.
Finché si riconosce un valore positivo, tecnico alla retorica – grosso modo fino all’alba del XVIII secolo – la letteratura conserva un ampio raggio di autonomia rispetto alle altre discipline: la persuasività è legata ad un procedimento retorico. Nel Settecento, invece, la letteratura comincia a incamminarsi verso quella serietà (avvertita come necessaria) che sarà tipica dei tempi a venire: un processo al termine del quale l’evidenza non sarà più frutto di una strategia letteraria più o meno persuasiva (ma sempre ricondotta all’ambito della retorica) ma della ricerca documentaria e della “ragionevolezza” (definita su di un piano etico: ciò che è serio diventa realistico).
Come è noto, il realismo ottocentesco fonda la sua evidenza su una retorica della narrazione drammatizzata in scene che si presumeva documentaria (e la presunzione non è del solo Zola, è già piena molto prima di Balzac). Una retorica ben analizzata nei saggi W. C. Booth, ma anche in Finzioni occidentali di Gianni Celati.
Quella dell’Ottocento è una modalità narrativa che, naturalmente, il XX secolo mette in crisi, sia nelle opere del Modernism sia, e con maggior libertà, nei romanzi della seconda metà del secolo, nei quali si torna ad una prevalenza del telling, del romanzo raccontato. Come ha scritto Kundera, la frontiera dell’inverosimiglianza (retta dalla presunzione documentaria), la cui dissoluzione è già piena nei racconti e romanzi di Kafka, viene del tutto vanificata nel secondo Novecento dalle opere di Gombrowicz, Garcia Marquez, Rushdie, Fuentes. Certamente viene superata d’un tratto dall’opera di Borges.
Tuttavia, poiché il problema dell’evidenza, della funzione conoscitiva della narrazione e della sua persuasività rimane uno dei nodi centrali della pratica narrativa, ci si trova comunque di fronte a nuove esigenze, ad una nuova interrogazione sull’evidentia letteraria.
In merito a questo aspetto, i procedimenti tipici del romanzo riguardano storicamente la definizione del personaggio (un individuo parziale, incoerente, per nulla omologo né all’eroe epico né al soggetto filosofico, e per questo più libero, vitale) e la composizione (non necessariamente sequenziale, cronologica, ma tematica). A questi elementi, alcuni autori del secondo Novecento vengono ad aggiungere la ridefinizione delle categorie temporali, oppure un nuovo spazio di descrizione infinitesimale. Altri ancora – ed è qui che ci si deve soffermare – fanno ricorso all’inserzione di documenti nel corpo della narrazione.
L’impiego dei documenti nella narrazione è un espediente antico quanto la storia del romanzo. Quel che qui si cerca di comprendere, però, è la diversa funzione che ora il documento sembra assolvere. In termini generali, il suo impiego può ancora essere ricondotto ad una strategia di motivazione dell’arbitrarietà letteraria, vale a dire al processo di legittimazione della narrazione, alla ragione per la quale si racconta una storia e non un’altra (del resto, stiamo parlando di evidentia); ma qui non si tratta di un manoscritto ritrovato, e neppure di un documento che si può ricondurre al gioco paratestuale delle prefazioni, avvertenze, postille, note, oppure a quello della mise en abîme.
In Sebald, la presenza del documento (vero o fittizio che sia) è quella di un corpo estraneo, che non appartiene al dominio della letteratura, ma a quello della storia. Un corpo che non si fonde con la vicenda narrata. Accade così qualcosa di analogo a quel che succede nei collage della pittura. L’impiego di immagini, o di documenti nella narrazione, quando non abbia scopo illustrativo, didascalico degli eventi narrati (ma introduca invece nuovi elementi, taciuti dal racconto), va ad incidere in modo determinante nel quadro della composizione.
III.
Il 27 settembre 1801, all’alba, Henry Beyle si fermò dunque “sulla vasta e silenziosa spianata – si udivano soltanto le allodole alzarsi in volo – dove il 25 Pratile dell’anno avanti, esattamente quindici mesi e quindici giorni prima, come egli annotò, aveva avuto luogo la battaglia di Marengo”. Mosse lo sguardo lungo la distesa, ripercorrendo la dinamica degli scontri, l’attacco decisivo della cavalleria guidata da Kellermann, il fronte austriaco sfondato. Qua e là, lontani, spuntavano alcuni alberi morti. Abbracciando l’intera pianura: “Vide, in parte già completamente sbiadite e scintillanti nella rugiada notturna, le ossa di sedicimila uomini e le carcasse di quattromila animali, che lì avevano perduto la vita, sparpagliate a grande distanza tra loro”.
Il divario, lo scarto tra le immagini della battaglia che aveva in mente (e a cui era ritornato più volte) e lo scenario di completa desolazione che gli stava dinanzi “a testimoniare la realtà dello scontro avvenuto, suscitò in lui un vertiginoso senso di confusione, mai provato in precedenza.” Negli anni che seguirono, ripensando a quella giornata, ebbe l’impressione che tutte le sconfitte a venire, le campagne militari, la stessa rovina di Napoleone non lo avessero che ricondotto a quel preciso stato d’animo, come se allora ne avesse avvertito misteriosamente il presagio.
L’Henry Beyle di Sebald ritorna, nelle sue peregrinazioni in terra lombarda, sulle ragioni di un’assenza, su ciò che manca alla sua esperienza di uomo e di soldato, una storia parallela della sua vita, che forse solo per caso non ha vissuto. I documenti, le fotografie che Sebald inserisce nel racconto non sono che questo, mezzi per produrre una testimonianza, una strategia narrativa per portare in evidenza ciò che non è ancora stato espresso verbalmente, o quello che non si può ancora esprimere. Di fronte a quella distesa di cadaveri Beyle si sente colare a picco. Nel complesso dell’opera di Sebald il procedimento delle immagini inserite nel racconto riguarda sempre le ragioni di una scomparsa: in primo luogo, ed in misura preponderante, la scomparsa che ha avuto luogo nei campi di sterminio, presente nei libri dello scrittore tedesco a partire dagli Emigrati fino ad Austerlitz.
IV.
Carlos Fuentes dedica a Jorge Luis Borges uno dei saggi più lunghi raccolti nel volume Geografia del romanzo. Dopo un accenno autobiografico, in cui l’autore ricorda la propria infanzia bilingue (inglese e castigliana, come quella di Borges), la lettura prende in esame un aspetto che Fuentes vuole più dimesso, meno celebrato nell’opera del grande scrittore argentino, quello di un “Borges scrittore urbano latino-americano”. Un aspetto che può apparire secondario e che tuttavia permette di giungere al nucleo centrale del continente borgesiano.
“Ciò che propongo in questo saggio è un periplo che segua quello dello stesso Borges, dalla sua situazione argentina, alla scoperta, attraverso questa, della storia come assenza, della necessità di immaginare questa assenza mediante delle finzioni (…)”. (C. Fuentes, Jorge Luis Borges: la ferita di Babele, in Id., Geografia del romanzo, Milano, Pratiche, 1997 (2006), p. 37)
Si tratta, in questo caso, di confrontarsi con un’altra forma di assenza: “Un vecchio motto dice che i messicani discendono dagli aztechi e gli argentini dalle navi.” Uno scrittore messicano, ricorda Fuentes, può evocare la piramide di Chichén Itzà o le molteplici forme del barocco delle chiese. Quello argentino, perduto nelle distese interminabili della pianura, “può solo evocare l’ombu, l’albero solitario. Perciò Borges inventa uno spazio, l’Aleph, da dove si possono vedere, senza possibilità di sbaglio, ‘tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli’”.
Nella costruzione di una seconda storia, una storia fittizia, fantastica, una metafisica che non si afferma mai del tutto (messa in crisi com’è dal suo stesso linguaggio ironico), Borges non si serve dell’epica, della “storia conclusa”, ma della “storia romanzesca”, la storia delle nostre possibilità, della nostra immaginazione. Parte dall’invenzione di un punto di osservazione, quello delle “sponde”, dai confini incerti che segnano la frontiera tra lo spazio urbano e quello rurale. Un’invenzione che gli consente di proporsi come uomo di frontiera che si muove fra i territori, fra le culture (europea, asiatica e americana), fra le consuetudini, fra le lingue (inglese e spagnolo). La frontiera tra spazio urbano e spazio rurale sembra concentrare, nella sua marginalità, l’assenza di ciascuna storia.
In questa dimensione transitoria, incerta, Borges estende il dominio della letteratura oltre l’ambito del realismo, fino a fare delle forme dello spazio e del tempo veri protagonisti dei racconti. Alcuni suoi personaggi dimorano tra la sicurezza topografica della realtà urbana e la dispersione dello spazio rurale: La pampa e i sobborghi sono dei recita il titolo di uno dei saggi compresi nella sua raccolta La misura della mia speranza. Oltre che nei racconti che trattano direttamente della pampa, però, l’esempio può essere colto anche in uno degli aspetti secondari di un’opera molto nota.
Il narratore del celebre racconto Funes, o della memoria (compreso in Finzioni) ricorda il primo incontro con il protagonista. Verso la fine dell’inverno del 1884 si trovava a Fray Bentos, in Uruguay. Un giorno, mentre tornava a cavallo dalla tenuta di San Francisco con suo cugino, Bernardo Haedo, felice per la tempesta che li incalzava dopo una giornata di caldo, in una stradetta incontra il giovane Ireneo Funes, con le scarpe di corda. Il cugino gli chiede l’ora e Funes, senza consultare né orologi né il cielo, risponde: “Mancano quattro minuti alle otto, ragazzo Bernardo Juan Francisco.” Il giovane protagonista, che incarna l’immagine stessa della memoria, vive su questa soglia, nei sobborghi.
Due anni più tardi, dopo una caduta da cavallo, Funes rimane paralizzato. Come è noto, la sua memoria diviene prodigiosa, totale. Trascorre le sue giornate a letto, in preda ad una feroce e solo talvolta serena coscienza del tempo:
“Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes: tutti i tralci, i grappoli e gli acini di una pergola. Sapeva le forme delle nubi australi dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata d’un libro che aveva visto una sola volta, o con le spume che sollevò un remo, nel Rio Negro, la vigilia della battaglia di Quebracho.” (J. L. Borges, Finzioni, Torino, Einaudi, 1955 (1995) p. 102)
Nell’immobilità (agli arti inferiori), la sua facoltà prodigiosa si nutre di dettagli: nulla è inutile, ma nulla conta davvero. In questo universo senza dispendio, senza eco, non c’è alcuna possibilità di espressione. Nonostante le sue doti, Funes se ne va senza lasciare traccia. Per questa ragione il narratore confessa di aver scritto il racconto e di aver chiesto a tutti quelli che lo conobbero di scrivere una testimonianza di lui. È a questo destino che Funes si è esposto.
Funes inventa idiomi impossibili, sistemi di numerazione immaginari, classificazioni fantasiose e inutili: scoperte che non hanno bisogno di essere registrate, ferme come sono nella sua implacabile memoria. “Discerneva continuamente il calmo progredire della corruzione, della carie, della fatica. Notava i progressi della morte, dell’umidità. Era il solitario e lucido spettatore d’un mondo multiforme, istantaneo e quasi intollerabilmente preciso”.
L’assenza che abbiamo citato non riguarda solo un destino storico, come a volte Fuentes sembra lasciare intendere. La metafisica ironica e impotente di Borges, fitta di tempi reversibili, spazi a più dimensioni, saggi, racconti, romanzi inventati e dati per scritti, documenti fittizi a fondamento di storie concrete, si apre su un’assenza che sembra avere qualche analogia con quella evocata da Sebald:
“Due immensi silenzi si riuniscono a Buenos Aires. Il primo è quello della pampa sconfinata, la visione del mondo da un angolo perpetuo di 180°. L’altro è il silenzio dei vasti spazi dell’Oceano Atlantico. Il loro punto d’incontro è la città di Rio de la Plata, dove ambedue i silenzi invocano: ‘Per favore, dateci voce’.” (C. Fuentes, ibid., p. 39)
La formidabile fantasia dell’autore si confronta con la morte senza nome, spesso violenta, cui i personaggi di questa terra vanno incontro: l’esito paradossale è che nulla, neppure la metafisica borgesiana (come la memoria di Funes, prodigiosa e insieme sterile) può dar ragione della loro scomparsa.
V.
La letteratura si confronta fin dalle origini con ciò che non è documentabile. Davanti a taluni eventi si comincia a immaginare, a congetturare (perfino a sragionare), perché non ci sono, né ci possono essere ulteriori elementi di comprensione.
A partire dalle tragedie che hanno caratterizzato la storia del Novecento, in particolare dai fenomeni di genocidio, ci si è interrogati spesso sulla scomparsa, la fine che non lascia tracce, l’esperienza di un uomo del quale la storia non salva neppure il nome. Di fronte a certi episodi (privi di documenti e di testimonianze), nonostante l’appello al silenzio, non si può rispondere che immaginando. Tuttavia, questa propensione non va intesa psicologicamente, non va ridotta ad una mera modalità di compensazione: è opportuno restituirle quantomeno la funzione di una “gnoseologia inferiore”. Al soggetto al centro di queste fantasie, infatti, possiamo ben riconoscere una minima dignità ontologica: non quella del soggetto, ma almeno quella incoerente e mobile del personaggio romanzesco.
Nel caso di Danilo Kis in Clessidra – come in quello di Sebald – la novità formale dell’espressione letteraria di fronte al fenomeno della scomparsa sembra risiedere nel ruolo singolare affidato al documento in rapporto al personaggio: il documento come testimonianza “indiretta”. Come accennato, la lettera del padre, le fotografie in bianco e nero, il quadro di una battaglia restano nel libro con la loro enigmaticità di corpi estranei, che non illustrano, ma anzi contrappuntano la narrazione. Quest’ultima, non si fonda propriamente su di loro, non accampa pretese documentarie, non si sostituisce al documento, ma anzi viene ribadita nel suo statuto di finzione. Così il protagonista non si sostituisce in alcun modo al soggetto storico, ma rimane un personaggio romanzesco.
L’evidenza della scomparsa è lasciata così allo scarto tra finzione e documento, che sulla pagina restano giustapposti, divisi, senza alcuna pretesa, né possibilità di sintesi (se non, artisticamente, entro il quadro compositivo del romanzo).
VI.
La frontiera tra la realtà urbana e la desolazione della pianura – di cui si diceva parlando di Borges – è il punto che consente di affrontare il timore della scomparsa, fin troppo presente nella storia sudamericana. Per affrontare questo timore, e la rovina che vede prossima nella città di Buenos Aires, l’avvocato e poi magistrato a riposo Héctor Pereda, il protagonista del racconto Il gaucho insostenibile di Roberto Bolaño, lascia la città per trasferirsi definitivamente in campagna, nella sua estancia a Capitán Jourdan. Il racconto descrive la progressiva metamorfosi dell’ex-giudice in una sorta di gaucho intellettuale, improbabile e dubbioso, eppure orgoglioso e temerario quanto basta per stringere il coltello in pugno e piantarlo nel ventre di un seccatore.
“Le notti europee saranno anche buie come la bocca di un lupo, ma non le notti americane, che semmai sono buie come il vuoto, come un luogo senza appigli, un luogo aereo, pura assenza di riparo, sia sopra che sotto.” (R. Bolaño, Il gaucho insostenibile, Palermo, Sellerio, 2006, p. 31)
“L’Argentina è un romanzo, diceva [Pereda], quindi è falsa, o, almeno, piena di menzogne. Buenos Aires è una terra di ladri e di guappi, un posto simile all’inferno, dove la sola cosa che valga un soldo sono le donne e a volte, ma molto di rado, gli scrittori. La pampa, invece, è l’eternità. Un camposanto senza limiti è la cosa più simile alla pampa che si possa immaginare.“ (R. Bolaño, Il gaucho insostenibile, Palermo, Sellerio, 2006, p. 36)
La pianura, un camposanto senza limiti, un po’ come la spianata di Marengo. L’avvocato-magistrato-gaucho avanza nella campagna, mentre Buenos Aires e la civiltà argentina sprofondano lentamente nella depressione economica e progressista (della quale il figlio, scrittore di successo, sembra essere cosciente solo in parte). In questa desolazione rurale c’è per Pereda l’invito a un confronto quotidiano con la rovina, con la possibilità di scomparire, che per quanto illuda miseramente – come un gesto anacronistico, una consolazione giunta fuori tempo massimo – si rivela più concreto del richiamo della città.
In generale, nel quadro dei romanzi di Bolaño, ricchi di complicazioni, di documenti fittizi, di autori immaginari che si confrontano con altri reali (del Beno Von Archimboldi di 2666,ma anche del poeta peruviano César Vallejo di Monsieur Pain e per non parlare di un’intera letteratura inventata, La letteratura nazista in America) questo racconto è singolare per lo sviluppo lineare, perfino prevedibile. Tuttavia, in questo confronto con la pampa, che dà il titolo all’ultimo libro “composto” per la stampa dall’autore prima di morire, sembra emergere chiaramente uno degli aspetti più interessanti dell’opera di Bolaño, vale a dire la possibilità di riportare interamente la questione della scomparsa entro i limiti della narrazione, come elemento propulsivo, dinamico, narratizzabile (pur senza scadere nella ripetitività modulare dell’indagine, dei gialli e perfino dei noir, sottogeneri tutti ripercorsi dall’autore). Se in molti romanzi e racconti di Bolaño le cause militari e criminali della scomparsa sono esplicitamente al centro della narrazione, qui restano sullo sfondo, nell’eco di questo fenomeno, di cui si affrontano invece le circostanze esteriori, quelle di una caducità più generale, alla quale è difficile sentirsi estranei.
Paradossalmente, sembra che nei confronti del fenomeno della scomparsa, l’opera di questo autore – nonostante i numerosi aspetti nabokoviani – tenda a fare a meno sia dei documenti che della metafisica, tenda insomma (attraverso un sapiente uso dell’ellissi), a riconsegnare la narrazione e lo stesso romanzo alla loro piena libertà. Si veda un altro esempio eloquente di Bolaño, il già citato Monsieur Pain.
Nel 1938, a Parigi, il grande poeta peruviano César Vallejo giace in un letto d’ospedale. È agonizzante, anche se “tutti gli organi sono intatti”. Nessuno sa dare conto del suo male: è afflitto da un incessante singhiozzo. Pain, esperto di mesmerismo, è chiamato da Madame Reynaud a visitarlo. Nonostante le ritrosie, l’aperta ostilità dei medici della clinica, riesce a vederlo. Quando, però, mostra la volontà di avvicinarglisi di nuovo, l’oscura organizzazione dell’ospedale e soprattutto dei concretissimi emissari spagnoli, gli impongono di desistere, rassicurandolo, anzi, sulle condizioni del poeta. Il poeta sta bene, per questo – il lettore può concludere – lo lasciano morire in un letto d’ospedale. Sullo sfondo, la Spagna è condotta alla rovina. Vallejo muore. Aragon pronuncia l’orazione funebre.
VII.
Nella frontiera tra spazio urbano e spazio rurale, nella desolazione della pampa argentina (ma, potremmo aggiungere, anche in quella della frontiera americana, o in quella simulazione del deserto che sono gli ospedali) ci si espone alla possibilità di scomparire senza lasciare traccia, si riconosce la storia come assenza di storia, che in Borges assume tutte le dimensioni del fantastico (metafisica, teologia, fantascienza, da lui trattate come varianti diverse dello stesso gene
e). È qui che si forma lo iato tra ciò che non si può fare a meno di immaginare, di produrre con la propria fantasia, e il residuo, il corpo estraneo che testimonia l’evento della scomparsa o ciò che ha tentato di opporsi al vuoto di un’assenza. Non è un caso il fatto che sia proprio in questa desolazione – se si vuole gettare uno sguardo sull’orientamento letterario postmodernista – che vada ad accumularsi una messe di materiali spuri che cercano di contrastare la paura del vuoto: documenti, manoscritti, illazioni storiche, segrete e fantastiche che dovrebbero certificare la nostra esistenza e che pure non vi riescono, documenti che caratterizzano, ad esempio, L’incanto del lotto 49 di Thomas Pynchon.
In questo libro, sorprendentemente – se si pensa a quanto se ne siano allontanati i suoi epigoni – ci si trova di nuovo di fronte ad uno sviluppo del tema della storia come assenza. La singolare, rocambolesca odissea che Oedipa Maas compie, in quanto esecutrice testamentaria di Pierce Inverarity, attraverso gli Stati Uniti (durante la quale si imbatte ad ogni passo nelle tracce dell’antico sistema postale segreto Tristero), conduce ad una conclusione in parte prevedibile:
“Settimane addietro lei si era dedicata a trarre un senso da ciò che Inverarity si era lasciato alle spalle, mai sospettando che il lascito fosse l’America.” (T. Pynchon, L’incanto del lotto 49, Torino, Einaudi, 2005, p. 169)
“Cosa restava da ereditare? Quell’America cifrata nel testamento di Inverarity, a chi apparteneva? Pensò ad altri vagoni merci, immobilizzati, dove i bambini sedevano sulle assi del pavimento a cantare come topi nel formaggio tutta la musica che usciva dalla radiolina della madre; ad altri abusivi che stendevano i teli delle loro capanne dietro sorridenti cartelloni lungo tutte le autostrade, o dormivano nei cimiteri delle automobili, negli abitacoli denudati di Plymouth incidentate; o addirittura, arditi, passavano la notte come bruchi in cima ai pali, nelle tende dei guardafili, dondolando tra una rete di fili telefonici, proprio all’interno delle sartie di rame e del miracolo laico della comunicazione, impassibili ai muti voltaggi che guizzavano per chilometri della loro estensione, tutta la notte, nelle migliaia di messaggi non uditi. Ricordò i vagabondi che era stata ad ascoltare, americani che parlavano la propria lingua con cautela da studiosi, come se fossero in esilio da qualcos’altro, di invisibile e tuttavia coerente con la terra allietata in cui viveva lei; e viandanti sulle strade di notte, saettanti entro e fuori il fascio dei fari senza alzare lo sguardo, troppo lontani da qualunque centro abitato per avere una vera destinazione.” (T. Pynchon, L’incanto del lotto 49, Torino, Einaudi, 2005, p. 171)
È in questo contesto incerto, in questa dispersione tra gli ultimi della società, tra coloro che, appunto, non lasciano traccia di sé (non nella prospettiva fiduciosa dell’Occidente, del Far West, ma nella possibilità di scomparire senza lasciare traccia), che Pynchon trova il senso più profondo della frontiera americana.
VIII.
L’esempio di Sebald, come quello di Kis, mostrano che di fronte alla scomparsa, in particolare a quella che ha avuto origine nei campi di sterminio, non ci si può indurre a credere di poter fornire una compensazione simbolica: l’unica verità dell’arte è quella di ciò che è dichiaratamente finto. E la sopravvivenza del documento, come già quella del paesaggio di Ivrea, non è che un monito a non identificarvisi.
In Borges e Pynchon, davanti alla storia come assenza di storia, la soglia tra spazio urbano e spazio rurale sembra segnare la più persuasiva nozione di frontiera: tra ciò che ha bisogno di un riconoscimento sociale (e riesce a trovarlo) e ciò che è sempre sul punto di scomparire. E lo stesso Fuentes ne ha dato un grande saggio con La fontera de cristal, un romanzo in nove racconti.
Le terre in cui ci si muove, sono dunque terre di confine.
Come ultimo appunto, verrebbe voglia di commentare che il realismo, inteso tradizionalmente, rimane per lo più un fenomeno urbano (del resto, non è un caso se negli esempi di realismo “rurale”, come quelli di Verga o di Tozzi, siano scopertamente presenti elementi mitici). Solo oltrepassando questa frontiera, questa soglia letteraria, ci si può rimettere nel mezzo di una narrazione restituita alla sua forza, alla sua funzione antropologica e forse anche alla sua evidenza.
Nota
Di seguito i testi nelle edizioni che sono state citate in questo intervento:
R. Bolaño, Monsieur Pain, Palermo, Sellerio, 2005;
R. Bolaño, Il gaucho insostenibile, Palermo, Sellerio, 2006;
R. Bolaño, 2666, Milano, Adelphi, 2007. J. L. Borges, Finzioni, Torino, Einaudi, 1955 (1995);
J. L. Borges, La misura della mia speranza, Milano, Adelphi, 2007; G. Celati, Finzioni occidentali, Torino, Einaudi, 2001 (1975, 1981);
C. Fuentes, Geografia del romanzo, Milano, Pratiche, 1997 (Net, 2003);
C. Fuentes, La frontera de cristal, Madrid, Alfaguara, 1996 (Paris, Gallimard, 1999);
C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Milano, Feltrinelli, 2006.
D. Kis, Clessidra, Milano, Adelphi, 1990.
T. Pynchon, L’incanto del lotto 49, Torino, Einaudi, 2005.
W. G. Sebald, Gli emigrati, Milano, Bompiani, 2000 (nuova edizione Milano, Adelphi, 2007),
W. G. Sebald, Austerlitz, Milano, Adelphi, 2002 (2006);
W. G. Sebald, Vertigini, Milano, Adelphi, 2003.
*
L’intervento è tratto da Finzione e documento nel romanzo, a cura di Massimo Rizzante, Walter Nardon e Stefano Zangrando, uscito in questi giorni presso la casa Editrice Università degli Studi di Trento. Il volume raccoglie i contributi del Seminario Internazionale sul Romanzo (tra gli altri, quelli di Eraldo Affinati, Gianni Celati, Antonio Moresco, Ornela Vorpsi, Ingo Schulze). Per informazioni: Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici, Via S. Croce, 65 – 38100 TRENTO – Tel.: 0461 881777 – 881722 – Fax: 0461 881751 – e-mail: editoria@lett.unitn.it.

 L’evidenza è un’illusione? L’avventura e il romanzo. Conversazione con Walter Nardon - Enrico De Vivo
L’evidenza è un’illusione? L’avventura e il romanzo. Conversazione con Walter Nardon - Enrico De Vivo La tradizione del poliziesco e il poliziesco senza tradizione: sulle tracce di Ricardo Piglia - Miguel Gallego Roca
La tradizione del poliziesco e il poliziesco senza tradizione: sulle tracce di Ricardo Piglia - Miguel Gallego Roca Il saggio è la forma del tu. Dialogo con Belinda Cannone - Simona Carretta
Il saggio è la forma del tu. Dialogo con Belinda Cannone - Simona Carretta Una macchina per raccontare tutti i futuri. Macedonio Fernández nel XXI secolo - Miguel Gallego Roca
Una macchina per raccontare tutti i futuri. Macedonio Fernández nel XXI secolo - Miguel Gallego Roca L’eccezione di Maertens
L’eccezione di Maertens Forse sognare. Su Angera e il progetto Infinite Jest – serie tv
Forse sognare. Su Angera e il progetto Infinite Jest – serie tv Iside
Iside Sette canestri
Sette canestri





















