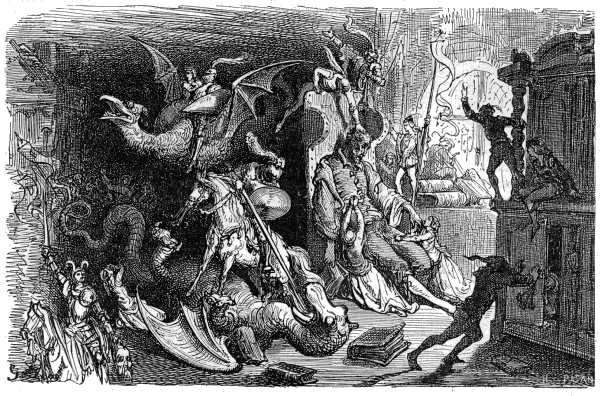
In una lettera indirizzata al musicista Antonio Chiuminatto e datata 5 aprile 1930, Cesare Pavese (che in quel periodo continuava lo studio dell’inglese e viveva parzialmente a Torino) dichiara a proposito dell’America e dei suoi scrittori:
Siete quanto di meglio c’è al mondo! Non solo per ricchezza e livello di vita materiale ma proprio come vitalità e forza artistica, il che significa pensiero e politica e religione e tutto. Vi è toccato il predominio in questo secolo su tutto il mondo civilizzato come già accadde alla Grecia, e all’Italia, e alla Francia. Ne sono sicuro. Quello che nel suo ristretto ambito ha fatto nella vecchia Europa il cinema americano, – e io me la son sempre presa con quelli che sostengono che è stata la sua organizzazione finanziaria e la pubblicità a imporlo: io dico che è, non tanto il suo valore artistico, quanto la sua superiorità in energia vitale, non importa se pessimistica o gioiosa, – quel che ha fatto il cinema, dico, farà l’insieme dell’arte e del pensiero americani. Ognuno dei vostri scrittori meritevoli scopre un nuovo terreno di esistenza, un nuovo mondo, e ne scrive con una sincerità e immediatezza di spirito per noi ineguagliabile. […] un buon libro europeo d’oggi è, in genere, interessante e vitale solo per la nazione che l’ha prodotto, laddove un buon libro americano parla a una folla più vasta, scaturendo, come scaturisce, da necessità più profonde e dicendo cose veramente nuove e non soltanto originali […].
In un’altra lettera, indirizzata una ventina d’anni dopo a Paolo Milano, Pavese afferma che L’uomo in bilico (Dangling Man) di Saul Bellow non gli era piaciuto. Aveva avuto la sensazione di ritrovarsi davanti a «un coscritto che aspetta di essere chiamato alle armi. Un uomo che non ha altra scelta, nell’attesa, che girare a vuoto, rimuginando. Alcuni suoi pensieri e certe sue idiosincrasie paiono interessanti, ma nell’insieme il protagonista manca di consistenza, non simboleggia niente di universale (alienazione dell’uomo contemporaneo, imminenza della morte): non rimane altro che un ego irritato».
«Girare a vuoto, rimuginando». «Un ego irritato». Due immagini azzeccate. Specialmente per un figlio della diaspora ebraica russa. Si potrebbe dire che è esattamente questo ciò che gli intellettuali ebrei hanno portato con sé in America: il profumo di un altrove e una lunga storia. Individui a parte, ego incandescenti, le loro modalità di pensiero, come la speculazione, lo scetticismo e l’autoironia, costituiscono l’essenza stessa del loro umorismo. E poi le vestigia di una cultura socialista; cortesia e barbe lunghe; un brulichio di lingue e un ricco idioma vernacolare, lo yiddish. E infine, per Saul, l’importanza fondamentale assegnata al testo. Era un popolo del Verbo.
Certo, un bagaglio pesante da portarsi appresso e da smerciare attraverso l’America profonda, una volta sbarcati dal transatlantico. L’America aveva già la sua tradizione, ereditata dall’Antico Testamento, situata un po’ a destra rispetto al fondamentalismo islamico – orrore per l’Inferno, odio del Piacere, Predestinazione e Puritanesimo. Una letteratura radicata o nel territorio (da Twain a Willa Cather) o in una Terra di Nessuno metafisica (Whitman e Melville).
Inoltre, durante la Grande Guerra, quando nacque Saul, l’America (E. E. Cummings, Hemingway, Fitzgerald) stava precipitandosi in Europa, proprio come l’Europa in America.
Fu durante la Grande Crisi che le due parti si ritrovarono l’una di fronte all’altra, ed è difficile dire quale ebbe la meglio. Hollywood – i fratelli Marx in particolare – aveva contaminato l’anima WASP. Questo, per qualcuno come me che frequentava nel pieno degli anni Quaranta l’università ultra-WASP di Yale (come immigrato cattolico di origine italiana), era piuttosto evidente. Le battute migliori, la ricchezza della lingua e tutte le asprezze della vita concreta si potevano trovare in Groucho Marx ben prima che in Faulkner. Fu allora che cominciai a leggere la Partisan Review, imbattendomi in un Saul alle prime armi, in Sid J. Perelman e in suo cognato, Nathaniel West.
Si percepiva con chiarezza che se fossero riusciti a liberarsi dai tic e dalle manie tipici degli ebrei d’Europa (che hanno ucciso l’opera di diversi scrittori ebrei di second’ordine, da un Roth all’altro) per creare qualcosa di nuovo in America, tutto il resto sarebbe venuto da sé. Dovevano cominciare dalla loro lingua, tanto originale quanto esuberante.
Ma un cambiamento di questo tipo non si era ancora realizzato. Non quando io ero all’università, né quando Pavese scriveva quelle parole. La delusione di Pavese era del tutto comprensibile – proprio come era nel giusto quando vedeva nell’energia e nel piglio inventivo americano il contrassegno della sua cultura. E il Saul di Un uomo in bilico doveva ancora trovare e infondere l’energia necessaria alla sua lingua per descrivere l’America, cosa che seppe fare magistralmente con Augie March.
Saul stesso era pienamente consapevole del cambiamento sopravvenuto in lui:
Vedevo che la letteratura americana si era resa schiava del modello inglese, senza una ragione sufficiente […]. La tentazione era legittima, certo, ma non accettabile. Significava abbandonare il proprio modo di parlare, la lingua di tutti i giorni. Capofila di questo ‘grammaticalmente corretto’ era il New Yorker. […] Shawn (l’allora caporedattore) aveva patteggiato con il Talmud, in favore del Modern English Usage di Fowler […]. I miei primi libri li avevo scritti in puro mandarino. Sperando che la mia merce ricevesse il salvacondotto di H. W. Fowler. Con Augie March ho voluto dare una forma nuova alla frase americana. Qualcosa come una fusione di confidenza ed eleganza. […] La lingua della strada e il grande stile […] In quel periodo ero agitato dalla passione di inventare.
«Una fusione di confidenza ed eleganza». Sì. Esattamente questo, ed è migliorato di libro in libro. È una lingua che appartiene solo a Saul e che pare sempre depotenziata – se non decisamente spocchiosa – ogni volta che la si ritrova adattata, imitata e utilizzata da altri scrittori (e non faccio nomi).
In superficie – se si esclude la sua armatura di senso, il suo cemento metaforico – questa nuova lingua è piena di swing, scoppiettante. Ti fa scompisciare dalle risate: è fatta per questo. Giochi di parole, autoironia, continui saliscendi. Limitarsi a imitarla in superficie, tuttavia, significa socchiudere appena il cancello che introduce nel Giardino, là dove cresce il melo, dove sono in attesa Eva e il Serpente. Tutto ciò perché al cuore stesso dello stile di Saul si cela un’intelligenza acuta e raffinata che interroga senza posa l’Albero della Conoscenza. Come ha affermato a proposito di John Auerbach (in un testo che è forse l’ultimo che Saul abbia scritto), Bellow possiede «quel dono di trasmettere istantaneamente a quanti hanno antenne predisposte a ricevere su frequenze atipiche». Il dono di spremerti le meningi come fossero palle da biliardo in perpetuo movimento e di raggiungere, pagina dopo pagina, quello che James Wood (che è di gran lunga il più perspicace fra i critici di lingua inglese) chiama l’«allegra e sbrigliata libertà di costruire frasi audaci sino alla temerarietà».
Trasmettere su «frequenze atipiche» è una strategia ad alto rischio. Le onde radio sono sempre infestate da parassiti. La frequenza ottimale è una variabile. Ma l’essenza del processo risiede in un orecchio fenomenale. Un orecchio che ascolta tanto quanto parla. Wood cita il modo in cui Saul descrive Ramona, l’amante di Herzog: «Non era una di quelle belle noli me tangerine» (il celebre Noli me tangere, for Ceasar’s I am reso immortale da sir Thomas Wyatt illustra alla perfezione il fatto che Ramona non appartiene a Herzog!). Ma di queste meravigliose trovate linguistiche potrei citarne a dozzine, a centinaia. In esse le locuzioni più comuni si rinnovano, subendo ogni volta un leggero scarto rispetto alla norma.
Prendete ad esempio l’espressione bas-bleu per indicare certe donne intellettuali (espressione derivata dal colore delle calze portate dalle prime studentesse di Oxford). Ecco quel che Susan Sontag diventa nelle mani di Saul: «Più guêpière che bas-bleu». Al Bard College c’era un mediocre sociologo di nome DeGré. Capitò che, senza alcun motivo, passassimo a casa sua una serata piuttosto spinta e ad alto tasso alcolico, proprio la notte della morte di Dylan Thomas. Sua moglie si chiamava Muriel. Entrambi concordavamo sul fatto che la coppia avesse una figlia davvero insopportabile. Ricordandola recentemente, Saul ha esclamato: «Ah! sì! Le troisième DeGré». Il Terzo Grado, un interrogatorio vivente!
Tutto comincia sempre con alcune battute, con dei doppi sensi. Frizzanti come quelli di Groucho Marx. Poi, questi incominciano a entrare nel testo per essere infine incorporati nelle descrizioni. Dico ciò per sottolineare fino a che punto quello di Saul sia uno stile orale. Sentitelo parlare e osservatelo, vedrete un’intelligenza al lavoro, alla costante ricerca del bon mot juste. Regala un piacere immenso. Come sempre – quando si vede l’ingegno all’opera!
***
Poi bisogna varcare una precisa soglia, andare oltre il linguaggio. Trovare quella che Saul chiama «la voce». Quante volte l’ho visto bocciare una dopo l’altra le diverse versioni di un romanzo (da Herzog in poi) perché «la voce» non era quella giusta. La «voce» è qualcosa di impalpabile. È l’anima. Non un’anima qualsiasi, ma l’anima del personaggio: ciò che ne costituisce l’identità, il linguaggio, le aspirazioni, i tormenti, gli smarrimenti.
La voce individuale è qualcosa di simile a quella che altrove Saul ha chiamato «l’anima primaria»: l’io originario esasperato dal non potersi manifestare. Un giorno o l’altro dovrete tutti riportarlo in superficie questo io originario, sessuale o mentale che sia, come ha fatto Saul, dovrete diventare un accumulatore di energia orgonica e sciogliere le tensioni muscolari (quello che fanno le mogli, insomma) che impediscono all’io vero e proprio di esprimersi. Allentate le resistenze – così da liberarvi dalla rigidità della lingua classica – e tutti loro, i Valentine Gerbach, gli Herzog e i Ravelstein vi parleranno. Diventerete voi il loro intermediario.
Ebbene sì, una nozione squisitamente romantica! Nel significato che il termine ricopriva nell’Ottocento. IO, io, io… e già si sente il grido di Beethoven! Il Nobile Selvaggio è la figura che domina quel secolo. Ma questo selvaggio ha un lato oscuro, e non è così nobile quanto vuol sembrare. Finirà per fondersi in Cuore di tenebra di Conrad (uno dei libri-chiave di Saul) perché il Nobile Selvaggio rappresenta l’Anima Primaria e l’Anima Primaria è insondabile e terribile.
È sempre la loro eterna e (molto) Particolare Prima Persona che fa procedere i personaggi di Saul, esattamente come, secondo me, è la sua Prima Persona che l’ha spinto ad avanzare nella vita. Tutti quei personaggi – i cattivi, i millantatori, gli illusionisti di professione, gli stravaganti, quelli con i fagotti stracolmi di grandi idee, quelli che il-successo-è-dietro-l’angolo, gli zoppi, gli storpi, i malaticci, gli emarginati – non sanno uscire da loro stessi e gridano «Io, io, io!». Muoiono di amor proprio non corrisposto. Restano imprigionati nei loro solipsismi.
C’è in Saul una tendenza al personaggio esemplare alla maniera dei prerazionalisti (qualcosa mi dice che per lui noi non meritiamo del tutto di essere gli umani che siamo!). Il tale rappresenta l’ira, quell’altro la malinconia, quel tipo è un sanguigno, mentre quella è una donna flemmatica: perché per lui il corpo è qualcosa di sostanziale. Questa è un’assoluta peculiarità di Saul: il suo modo di cogliere le manifestazioni fisiche degli esseri umani è il tratto che lo distingue meglio dagli altri scrittori. Inizia avvicinandosi il più possibile all’essere umano: osserva. Pensate alla quantità di pagine dedicate da Proust alla dissezione degli animi: Saul desidera a tutti i costi inciderli in un corpo, incarnarli.
Prendiamo qualche pagina a caso di un racconto degli anni Ottanta, Cugini. C’è anzitutto Militie:
Militie era corpulento, quasi obeso, con un bel viso da falco, un profilo fiero, un corpo viziato e vistosamente elegante, agghindato, uno sguardo spavaldo e polemico.
E poi la sua prima moglie, Libby:
…che pesava più di centoventi chili e camminava frettolosa per l’albergo sui suoi tacchi a spillo, era quella che noi chiamavamo una «bionda da suicidio» (i capelli se li tingeva da sola).
Fino alla manfrina sul cugino Tanky:
«Lo conosco da quando era in fasce» o «Ero presente alla sua circoncisione».
Questi non sono fatti da sottoporre all’attenzione della corte: che era un bambino enorme; che niente di così grosso si era mai installato su un seggiolone; o che ha ancora l’espressione di quando era appena nato, un’aria di sicurezza e di allegra insolenza. Il suo caso è un’illustrazione del proverbio spagnolo:
Genio y figura
hasta la sepultura.
Il marchio ‘divino’ o, come preferirebbero dire i più, genetico, restava visibile anche nella corruzione e nella rovina.
Qui «l’umore», l’emblema, è l’obesità collettiva che, di volta in volta, si carica del peso dei «milioni» che sono stati stornati: da e verso la Mafia.
Saul sembra dirci che ogni vita è viscerale e l’unica cosa che ci separa dall’urlo primitivo è l’istruzione, la conoscenza. E queste parole fanno un gran bene. L’umanità, tuttavia, soffre di un eccesso di ‘spiegazioni’. La domanda di Herzog è: «Che cosa avete intenzione di fare quando vostra moglie si trova un amante? Sfilare il vostro benamato Spinoza dalla biblioteca e leggere quel che ha da dire sull’adulterio? Sulla schiavitù umana?».
Una cultura più vasta non è apparentemente in grado di fornire un maggior numero di rimedi al dolore e al tradimento di quanto non possa fare la lingua classica. Nelle primissime versioni di Herzog gli strappi violenti fatti al ‘tessuto’ del personaggio avevano trovato modo di esprimersi solo in forma di lettere. Le lettere, infatti, mettono alla prova la voce.
Non è un caso se le nostre tre riviste hanno tutte una sezione intitolata Arias. Le arie erano dei motivetti che accompagnavano la cena. Rappresentavano qualcosa di estremamente personale, preferibilmente unico, per lo scrittore (a lungo mi sono meravigliato dell’ammirazione di Saul per Samuel Butler e per i suoi Ramblings on Cheapside finché non ho capito che Butler aveva scritto delle arie senza saperlo!).
Così ogni protagonista (generalmente eponimo) – Herzog, Henderson, Augie, Ravelstein – dei suoi romanzi ha una voce unica: quel che dice concorda misteriosamente con il suo modo di dirlo. Meglio ancora: sarebbe impossibile dire in maniera diversa quello che sta dicendo. E, abbastanza curiosamente, i suoi libri meno convincenti sono proprio quelli non apertamente governati da questa esplicita denominazione. È come se Bellow avesse dovuto scoprire il legame esclusivo tra nome e voce per sentirsi finalmente libero – potendo scrivere come il personaggio stesso avrebbe scritto – di descrivere con affetto, se non addirittura con piacere, tutte le sue manie.
La lingua e lo stile. La sua tecnica narrativa privilegiata – «Ascoltate, aprite bene le orecchie, ho qualcosa da dirvi» – c’entra qualcosa. Ma, più importante ancora, è il modo in cui Saul espone la visione del mondo dei suoi personaggi, il giudizio su loro stessi, le offerte devolute all’altare della vita quotidiana, quel che hanno da dire sul passato e sul futuro, i loro amici e i loro nemici, il loro universo specifico – quel mondo che non appartiene ad altri che a loro stessi e che (con doloroso disappunto) non è avvertito dagli altri – tanto meno dalle donne, eterne escluse da quest’ambito privato, anche quando il protagonista le accoglie tra le sue braccia.
Egli è il Grande Osservatore: osservatore dei tratti distintivi (dai denti alla Stonehenge di Pierre Thaxter al delirio orientale delle vestaglie di Ravelstein), dei difetti e delle virtù, dell’andatura a gondola di Valentine Gerbach come dei tropismi del linguaggio comune, efficaci o fallimentari che siano. Portare a termine quest’impresa, riuscire ad essere tutti loro, per intero, ognuno con il vocabolario che gli è proprio, richiede una potenza immaginativa straordinaria. Richiede allo stesso tempo una ‘distanza’ che, ai miei occhi, costituisce uno dei punti di forza di Saul come scrittore, e il segno di una profonda angoscia come essere umano, marito, padre, amico.
Sa evitare il pedagogismo, la spiegazione, l’ammonizione e non cede a quell’ossessione tipica del Novecento che consiste nel bombardarvi di consigli del tipo: «Se fossi in lei…». Sembra piuttosto che voglia farci imparare tutto da soli, analizzando in modo dettagliato la nostra ‘vita quotidiana’ darwiniana. Spetta a noi confrontarci con la nostra psiche, con le nostre speculazioni finanziarie, con la natura temporale del nostro corpo, con l’enigma della morte. Non ha la benché minima intenzione di immischiarsi nella nostra vita privata e di dirci quel che bisogna fare.
Ricordo un giorno. Stiamo passeggiando in un parco di Chicago. L’erba è bruciacchiata, il vento soffia orizzontale. Una delle mie imprese è fallita, uno dei suoi matrimoni è appena naufragato. Tuttavia, lui si ritrova improvvisamente più ricco ed io sto vivendo un momento di perfetta felicità con colei che all’epoca era mia moglie – stabiliamo dunque di vigilare l’uno sull’altro: lui non si sarebbe più lanciato in un matrimonio senza prima avermi interpellato, né io in un affare senza avvertirlo. Uno scambio di favori, diciamo.
Naturalmente la cosa non ha funzionato. Siamo rimasti amici proprio perché non ci scambiavamo consigli. Ci bastava essere presenti in caso di bisogno.
Anche questo c’entra con la ‘distanza’. Se capita di dare un consiglio, va fatto indirettamente. Ciò non significa che io non abbia mai ricevuto un buon consiglio da Saul – è capitato – ma il consiglio veniva sempre presentato come un principio universale e non aveva niente di quelle intrusioni indiscrete tipiche di un’intellettuale come Ann Landers.
In un romanzo scritto di recente, non riuscivo a sistemare tutto un bagaglio di ‘idee’ assolutamente vitali per il mio protagonista. Saul mi ha detto: «Prendi il Lettore per mano e lui ti seguirà ovunque». Che significa: digli ciò che ha bisogno di sapere e perché, concentra l’informazione sul tuo personaggio e assicurati che tutto sia chiaro. Un principio, a tutti gli effetti. Non semplicemente un consiglio.
Le voci sono dunque tenute a distanza. Tuttavia è innegabile che ciò in cui Saul riesce meglio è scrivere su coloro che ama. Un aspetto molto conradiano. Nei libri di Conrad i vari capitani, che si assumono la responsabilità di molte vite umane, hanno tutti le loro debolezze, così come le loro piccole manie. Ma si può essere certi che l’autore li ama tutti. Perché Conrad, anche lui, ha capito quanto la vita sia complessa e insolubile. Di qui la presenza, nei libri di Saul, di Delmore Schwartz, di Chanler Chapman, di Alan Bloom, di Saul Steinberg, di Fred Dupee, di Harold Rosenberg, di me stesso e di dozzine di altri. Ciò significa che una piccola (ma anche una grande) parte di noi è stata da Saul rappresentata, catalogata, resa fittizia e infine riutilizzata per le necessità dei suoi romanzi. «Spero non ti ferisca», mi scrisse inviandomi Il dono di Humboldt (Humboldt’s Gift). «Ti voglio molto bene, altrimenti non mi sarei occupato di te».
Ha sempre avuto più difficoltà nel parlare di donne.
Il motivo è semplice: è troppo legato a loro. Distante, ironico, altero e spesso sprezzante – ma ugualmente generoso, tollerante e vagamente compassionevole – con gli uomini che ama, con le donne è come se venisse proiettato fuori di sé. Lo privano di ogni difesa.
Mi viene in mente un possibile accostamento tra Henry Adams (scrittore che entrambi ammiriamo molto) e Saul. Al venticinquesimo capitolo de L’educazione di Henry Adams (che è una delle tre grandi autobiografie della letteratura mondiale, con quella di Benvenuto Cellini e di Hector Berlioz) Adams partecipa alla chiusura della Grande Esposizione di Parigi del 1900. È in compagnia di Samuel Pierpont Langley, suo mentore scientifico, al tempo segretario dell’Istituzione Smithosiana e fisico specializzato dell’aeronautica. Langley aveva sessantasei anni, Adams sessantadue.
Il capitolo s’intitola La dinamo e la vergine.
Adams passeggia nella «grande sala delle dinamo» e, mentre «si abituava alla grande galleria di macchine», ha una sorta di rivelazione:
cominciò a sentire le dinamo da dodici metri come una forza morale, pressappoco come i primi cristiani sentirono la Croce. Lo stesso pianeta terrestre pareva meno impressionante, nella sua antiquata, metodica rivoluzione annuale o giornaliera, di questa immensa ruota che girava a brevissima distanza a una velocità vertiginosa e mormorava appena – ammonendo con un brusio appena percettibile a tenersi un pelo più discosti per rispetto della potenza – mentre non avrebbe svegliato un bimbo addormentato vicino alla sua intelaiatura. Dopo un poco, si cominciava a rivolgerle preghiere; un istinto ereditario insegnava l’espressione naturale dell’uomo di fronte alla forza silenziosa ed infinita.
Povero Adams, è tremendamente adirato contro tutto ciò che è Nuovo:
L’uomo si era trasferito in un nuovo universo che non aveva con quello antico una scala di misurazione comune. Egli era entrato in un mondo soprasensibile, in cui non poteva misurare nulla salvo mediante fortuite collisioni di movimento impercettibili ai sensi, forse anche impercettibili ai suoi strumenti, ma percettibili fra loro, e pertanto a qualche noto raggio di luce all’estremità della scala.
Gli storici, continua a spiegare Adams (immagino li opponga ai romanzieri), «si occupano di stabilire sequenze – chiamate narrazioni o storie – presupponendo, tacitamente, un rapporto di causa ed effetto». Ormai, confrontato a questo mondo nuovo, Adams sente che il valore di tali forze «non poteva avere altra misura se non quella dell’attrazione che esse esercitavano sulla sua mente. Doveva trattarle come le aveva percepite: come attrazioni convertibili, reversibili, interscambiabili rispetto al pensiero».
Proprio come il protagonista di uno dei romanzi di Saul, o come Saul stesso, Adams deve confrontarsi con una serie di problemi insolubili:
Si aprì qui un’educazione totalmente nuova, che promise di esser quella di gran lunga più rischiosa di tutte. La lama di coltello lungo la quale egli [Adams ] doveva strisciare […] divideva due regni di energia che non avevano nulla in comune se non l’attrazione.
Con l’immagine dei due regni, Adams vuole naturalmente indicare la Dinamo (simbolo dell’ignoto dello spirito) e la Vergine (che, assieme a Venere, è l’immagine della forza rappresentata dalla donna):
[…] era lei la dinamo animata; era la riproduzione – la più grande e la più misteriosa di tutte le energie; tutto ciò che le occorreva era di essere feconda. [….] esercitava sulla mente umana un’attrazione assai maggiore di quanto si potessero mai sognare tutte le macchine a vapore e le dinamo; eppure questa energia era ignota alla mente americana.
[I – continua]

 Literaturistan - Massimo Rizzante
Literaturistan - Massimo Rizzante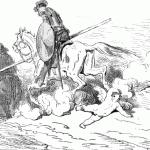 Per farla finita con le smanie dell’Ego/ 2 - Francesca Lorandini
Per farla finita con le smanie dell’Ego/ 2 - Francesca Lorandini





















