Il fuoco della Seconda guerra mondiale ardeva ancora in molte parti d’Europa, la tregua era vicina, la Germania era allo stremo, le sue città devastate da bombardamenti a tappeto, Vienna era occupata dall’Armata Rossa, Roma dalle forze armate americane, e nel bunker di Berlino la furia del dittatore si volgeva ai suoi ultimi giorni di vita quando, nel marzo 1945, apparve per l’editore newyorkese Pantheon Books il romanzo di un esule austriaco. L’autore era uno di quegli scrittori scomparsi, privati della cittadinanza, vittime della persecuzione razziale scampate spesso per un pelo alla morte, che la Storia, sotto forma di m arci a trionfale nazionalsocialista, aveva strappato ai lettori dei paesi d’origine. Così fu poco meno di un miracolo che un romanzo di ben ottocento pagine, avente per argomento le ultime diciotto ore di vita del poeta latino Virgilio, potesse uscire dalle tipografie contemporaneamente in tedesco e in inglese. Era la grande fatica del quasi sessantenne Hermann Broch, l’esito di un lavoro più che decennale, un libro addirittura maniacal-patetico, dal linguaggio stravagante, un’ultima impertinenza da parte del modernismo letterario, un monumento d’illeggibilità.
Era difficile giudicare se si trattasse di un capolavoro o di un grandioso fallimento: «un libro per nessuno», constatò il filosofo Günther Anders in una delle prime recensioni. Solo i lettori particolarmente eccentrici potevano entrare in confidenza con l’opera, e a quanto pare oggi le cose non sono cambiate. Di rado un’opera così audace dal punto di vista formale ha avuto un’eco tanto limitata. Vi furono alcune recensioni garbate e anche favori amichevoli come quello di Hannah Arendt, che ne rilevò la connotazione avanguardistica, ma nel complesso il verdetto fu quello del silenzio. Ora si potrebbe incolpare il momento infelice della sua apparizione, la fine della guerra in Europa e con essa il collasso di tutti i canali di distribuzione, l’ignoranza del mercato americano nei confronti della letteratura straniera, in particolar modo quella sperimentale. Ma sarebbe solo una parte della verità. Il Doctor Faustus del collega Thomas Mann, che Broch stimava e con il quale dialogò per molti anni, uscì nello stesso periodo, raggiunse un pubblico assai più ampio e divenne un’opera dall’immenso fulgore spirituale, una sorta di testamento della cultura tedesca. Al contrario, La morte di Virgilio non ha mai raggiunto niente e nessuno, né i lettori, né le più importanti cerchie intellettuali (i membri della scuola di Francoforte, ad esempio), né la giovane generazione di scrittori della Germania o dell’Austria postbellica. A quanto pare, inoltre, Broch, che conduceva una vita da pendolare tra New York e Princeton, fu più che altro un fenomeno dell’East coast. Nessun esponente della potente comunità degli esuli in California, politicamente orientata a sinistra, ne fa menzione. Ad ogni modo l’autore de Gli affari del signor Giulio Cesare non si accorse mai di lui. Nel suo Diario di lavoro, dal quale di rado restavano esclusi avvenimenti letterari di tale portata, Bertolt Brecht non ne fa parola.
Fin da prima dell’uscita, l’autore era dolorosamente consapevole che il suo libro si sarebbe venduto con difficoltà. Solo un sistema di prenotazioni avrebbe reso possibile l’edizione tedesca. Broch spedì centinaia di lettere a potenziali lettori un po’ ovunque negli Stati Uniti. I destinatari erano per lo più fuoriusciti come lui, psicoanalisti, avvocati, professori di varie università, scienziati indipendenti, e tra essi vi erano molte celebrità. Broch, uno dei più assidui epistolografi del ventesimo secolo, ebbe con molti di loro una corrispondenza duratura, anche privata. Tra i primi lettori certi vi furono Albert Einstein e Thomas Mann, e desta una suggestione tutta particolare immaginare lo scopritore della teoria della relatività, il celebre scienziato con la lingua fuori, come un ammiratore delle trasmigrazioni brochiane dell’anima.
Nondimeno tutto ciò gli servì poco. Fin dall’inizio La morte di Virgilio fu avvolto dall’aura di solitudine e impenetrabilità che ancor oggi (e oggi più che mai) ne assicura il durevole insuccesso. Del resto, che libro era mai? Fin dal titolo stesso faceva pensare a un polpettone storico che la maggior parte dei passeggeri della metropolitana newyorchese avrebbe liquidato con uno sbadiglio. Era finita l’epoca dei bestseller internazionali come Gli ultimi giorni di Pompei di Bulwer-Lytton o Quo vadis di Sienkiewicz. E la resurrezione del genere sarebbe stata riservata solo al cinema hollywoodiano degli anni cinquanta, quando sullo schermo avrebbero cominciato a brillare i colori e il passaggio allo schermo gigante avrebbe attirato un pubblico di massa con pellicole come Ben Hur o Il faraone. Ma è difficile immaginare che il Peplum, poi divenuto così popolare, si sarebbe potuto utilizzare per quel Kammerspielche erano le ultime ore del poeta Virgilio – anche solo per via dei dialoghi irrecitabili.
E fu proprio questa lingua impastata e onirizzante, maestosamente tortuosa, con i suoi rallentamenti e ritardando drammatici, priva di capoversi per pagine e pagine, a conferire all’insieme l’apparenza di un mostro prosastico. Il romanzo era strutturato in quattro grandi blocchi che riunivano i capitoli sotto il segno degli elementi – acqua, fuoco, terra, etere – e per lunghi tratti era scritto in forma di monologo interiore. Certo, vi apparivano personaggi: uno schiavo, un medico di corte, varie figure popolari dei sobborghi, due vecchi amici e infine lo stesso imperatore Ottaviano Augusto; ma scomparivano subito, nonostante tutti gli ingredienti usuali dell’arte romanzesca come la descrizione dei luoghi, il paesaggismo o l’elemento drammaturgico e dialogico; si dissolvevano in un tessuto complessivo allucinato, dove il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà e azione s’intrecciavano indissolubilmente. Il fanciullo Lisania, figura fantomatica di oggetto erotico-pedagogico, o la sposa Plozia, morta molto tempo prima: nei sogni febbrili del moribondo erano tanto reali quanto irreali, come tutti gli altri. Uno dei pochi, se non l’unico elemento trainante dell’azione era la lotta per la conservazione del manoscritto dell’Eneide, una lotta condotta essenzialmente con mezzi retorici. Se al principio il poeta è determinato a distruggere i preziosi versi, man mano che il corpo indebolisce egli si abbandona ad argomentazioni interminabili. L’accessorio di scena più importante in tal senso è il baule con i rotoli dei manoscritti, che spesso cambia posizione e alla fine anche proprietario, sicché da questo punto di vista il romanzo è una novella sovradimensionata. Ma la problematica che vi si trattava, trasposta nell’antichità, era quella dell’autore stesso, la questione dello scopodi ogni arte. Nella biografia di Publio Virgilio Marone, l’espulso, figlio di un possidente espropriato dell’alta Italia, Hermann Broch, l’ebreo errante, riconobbe il proprio destino. Nell’incontro al vertice di poeta e sovrano egli espresse un sogno vagheggiato che nel ventesimo secolo allettò non pochi artisti. Operava qui un inafferrabile idealismo, qualcosa di disperatamente europeo. Per l’ultima volta tutto gravitava intorno al sogno di un’aristocrazia spirituale e della grande missione dell’artista, i cui giorni, al di fuori di quel libro, erano ormai contati da un pezzo. Qui c’era qualcuno che, attraverso il personaggio di Virgilio, intonava il canto del cigno per l’Occidente distrutto dal fascismo. Ma chi se ne sarebbe lasciato ancora incantare?
Per capire come ancora a quell’altezza abbia potuto vedere la luce un simile unicum dell’arte romanzesca borghese e ottocentesca, bisogna richiamarne alla memoria il retroterra storico. Le cause prime risalgono all’inizio degli anni trenta. Pare che lo stimolo decisivo sia venuto dal libro di un vecchio conoscente di Broch, negli anni in cui questi pubblicò i primi interventi saggistici nella rivista Der Brenner di Innsbruck. Si suppone che, accanto alle celebrazioni in onore del poeta latino per il bimillenario della nascita, a dare l’abbrivo sia stato il saggio di Theodor Hacker, uscito per l’occasione, dal titolo programmatico Virgilio, padre dell’Occidente. L’idea di fondo che da quel momento avrebbe animato Broch era press’a poco questa: Virgilio è il perfetto poeta patriottico, il tipo fondamentale del rivoluzionario conservatore che ritorna poi più volte, nei momenti di svolta della Storia, in poeti-profeti come Rousseau o Tolstoj. Un simile custode dei valori, dal linguaggio possente, riemerge sempre quando una civiltà sprofonda nella crisi e la società diviene in larga parte amorfa e violenta, condotta allo sbando da correnti di massa, logorata dall’interno da conflitti fratricidi. «Virgilio, precursore del Cristianesimo; Rousseau, precursore della Rivoluzione francese; Tolstoj, precursore del Bolscevismo: tutti e tre poeti e profeti» – questa è l’agile formula escogitata da Broch nel suo ambizioso studio sull’isteria di massa, precisamente nel secondo capitolo, che sviluppa una fenomenologia dello stato crepuscolare. Così intesa, l’opera di Virgilio è la summa di tutti i valori positivi dell’antichità greco-romana, non solo mappa costituzionale e fondamento patriottico, ma anche il certificato poetico di garanzia di un nuovo ordine pacifico nei confini del buon impero. Nella glorificazione virgiliana della Pax augustea i più lungimiranti potevano già indovinare il futuro di un mondo di nazioni unite sotto l’egida della Pax americana.
Questi tuttavia non sono gli unici paralleli storici. Più volte il romanzo ritorna sulle tre grandi catastrofi che dopo il tramonto della repubblica avevano lasciato un vuoto minaccioso nel cuore della società romana: la perdita della conoscenza, la perdita del dio e l’orrore delle devastazioni. Per ognuna, Broch, il diagnosta dell’epoca, aveva presente un rivolgimento storico successivo. Se la perdita della conoscenza allude al fallimento dell’Illuminismo europeo, la perdita del dio fa pensare alla sentenza nietzscheana sulla fine del Cristianesimo. E le devastazioni non rimandavano soltanto ai lunghi anni di sangue dopo l’assassinio di Giulio Cesare, che gettarono uno spirito sensibile come Virgilio in una cupa malinconia, ma anche alle atrocità e ai massacri perpetrati dalle truppe della Wehrmachtnella guerra mondiale allora in corso, come anche alla totale insensatezza dello sterminio degli ebrei, di cui correva voce ormai da tempo in tutto il mondo. Anche il personaggio di Augusto viene attualizzato. Egli appare come il tribuno del popolo che, forte del consenso di quest’ultimo, può permettersi di opporre il proprio veto a un senato rissoso, proprio come un moderno presidente o premier occidentale che in tempi di grave crisi difenda dinanzi al parlamento il superiore interesse dell’autoconservazione nazionale. Il vincitore della guerra civile romana è anche colui che «sconfisse le forze oscure d’Oriente». È nota la preoccupazione che destava in Broch l’idea di una posizione di supremazia del marxismo armato dell’epoca. E così nel romanzo sul più grande tra tutti i latini s’intrecciano i leitmotiv politici di Broch in quegli anni. Il buon pastore Roosevelt, fautore del New Deal e salvatore delle democrazie contro l’assalto della barbarie, vi è trasfigurato non meno della critica del poeta alle correnti totalitarie del suo tempo, il suo richiamo a un diritto civile universale per tutti gli uomini, la sua speranza di una riconciliazione tra poesia e politica.
Nel periodo in cui scrisse il romanzo, Broch era dedito instancabilmente a vari progetti politici ideali, che nella loro comune tendenza universalistica superavano sotto quasi ogni aspetto i miopi interessi dei partiti e dei governi. Una riflessione sulla sua opera non può prescindere dai ponderosi studi sulla cosiddetta teoria dell’isteria di massa, dal suo impegno per i diritti umani e per la Società delle Nazioni in chiave antifascista, dalle ricerche sociologiche e psicoanalitiche e con esse l’autoanalisi cui si sottoponeva senza pause. Broch era tante cose in una: paziente e analista, teorico del romanzo e autore che sperimenta, un’organizzazione “individuale” di soccorso e il suo proprio istituto di ricerca sociale. Era impegnato in così tanti progetti contemporaneamente – destando in ciò la preoccupazione dei suoi editori – che la sua prosa spesso ne risentiva; per questo il lavoro al romanzo su Virgilio si protrasse per tanti anni. Concepito inizialmente come un racconto breve destinato alla fruizione radiofonica, il nucleo tematico è menzionato per la prima volta nel 1937. Quando l’autore, un anno dopo, viene arrestato in occasione dell’Anschluss dell’Austria, è già stata ultimata la terza versione con il titolo Racconto sulla morte. Passeranno sette simbolici anni, tra ininterrotti ampliamenti e trasformazioni, prima che il romanzo pervenga alla sua forma definitiva e monumentale, imponente come una s info nia di Bruckner.
Ora, è sempre facile rimproverare a posteriori a uno scrittore di essersi perso in diversi lavori marginali. Ma per quanto frammentaria e politicamente infruttuosa sia rimasta gran parte di questi ultimi, essi appartenevano pur sempre alla concezione spirituale del romanzo. Non era soltanto l’orgoglio del creatore; Broch aveva ottime ragioni per supporre che dopo la guerra il suo libro avrebbe potuto rivelarsi utile per la riconversione dell’umanità in Germania. Che poi un popolo caduto così in basso avesse tutt’altre preoccupazioni e desideri, fa parte del tragico malinteso di cui La morte di Virgilio è un’eloquente testimonianza. C’è qualcosa di ironico nel fatto che al centro del libro vi sia il destino di un’opera poetica che ebbe la fortuna di trovare la via alla letteratura universale. Secondo un saggio detto latino, il destino dei libri dipende dall’accoglienza del lettore. Ma al grande romanzo di Hermann Broch toccò in sorte d’essere dimenticato.
Quanto meno il libro era letto per davvero e discusso seriamente tra gli amanti della letteratura, tanto più rapidamente divenne una leggenda. Si ha l’impressione che, non appena pubblicato, sia scomparso tra le nubi, come quelle vette immense che si vedono sempre soltanto da grandi distanze e avvolte nelle nebbie. È nota la sentenza salomonica con cui Thomas Mann, in veste d’esperto, si trasse d’impaccio. Egli parlò di uno dei «più inusitati e radicali esperimenti mai intrapresi con il duttile strumento del romanzo», e pare di cogliervi l’allusione a una certa stravaganza e all’uso improprio della forma. Presto si cominciò a parlare di un ultimo esemplare del moderno romanzo borghese; fu affiancato alle opere di Proust e di Joyce. Broch stesso, nei suoi scambi epistolari, rise di tali paragoni benevoli ma fuorvianti. Il teorico del romanzo che era in lui richiamò l’attenzione sul vocabolario consapevolmente tradizionale, in contrapposizione alle innovazioni tecniche di un Joyce (il suo metodo di condensazione lessicale nel Finnegans Wake). Vi erano certo alcune affinità, ma, come ammise Broch a proprio sfavore, non erano molto maggiori di quelle tra un bassotto e un coccodrillo.
Degna di nota è invece una particolarità stilistica trascurata dalla maggior parte degli osservatori. Nessun altro romanzo moderno si è avvicinato come questo, nella composizione e nell’idea, alla poesia lirica. A rigor di termini non gravita forse tutto quanto, in quest’opera mastodontica, attorno a una questione: la funzione della poesia e la sua dimensione storica? L’accurato inserimento di citazioni in versi dalle Georgiche, l’Eneide e le Bucoliche di Virgilio non è più, come nel racconto biografico tradizionale, una semplice tecnica di coloritura; vi è in gioco invece la stessa forma narrativa. Il verso elegiaco diventa il modello di una nuova prosa romanzesca; il flusso di coscienza dell’eroe si avvicina alla forma lirica. Di qui i riecheggiamenti di Rilke, inconfondibili, o di Hölderlin. Non a caso durante il lavoro al romanzo sono nate diverse poesie, una delle quali inizia con le parole: «Poiché austera è la linea della verità; non credere alla letizia». L’ultimo tentativo di rottura del moderno romanzo borghese doveva condurre nei campi della poesia, questa era l’idea. Broch stesso vedeva nella propria composizione una novità assoluta per il genere romanzesco. Credeva di aver creato una sorta di poema lirico composto di periodi inusitatamente lunghi. Non per nulla rimandava spesso e volentieri alle Elegie duinesidi Rilke, il suo oggetto di studio prediletto nell’epoca in cui lavorò alle varie versioni. Le molteplici rielaborazioni sono sempre anche aggiustamenti metrici, si potrebbe dire, correzioni tecnico-versificatorie entro i singoli blocchi costruttivi, che Broch apportava finché non aveva preso forma lo stile innodico-ontologico voluto. Così facendo, come narratore egli commise un peccato mortale. Rompendo consapevolmente con la prosa romanzesca e la sua sobrietà, preferì affidare all’elemento lirico la rappresentazione di ciò che di contradditorio vi è nell’uomo. «Poiché la poesia lirica ha sempre portato alla luce quella sfera dell’anima in cui le sue contraddizioni si completano a vicenda».
Per molti anni La morte di Virgilio è stato uno dei miei tesori segreti. Avevo diciott’anni quando me ne capitò in mano un’edizione tedesco-orientale autorizzata dell’editore Volk und Welt, nella collana Ex Libris: un bene prezioso, dall’invitante sovraccoperta verde. Innamorarsi presto dei libri sbagliati fa parte dei rischi della vita di uno scrittore. Ma in fondo non siamo solo noi che scegliamo, nei casi eccezionali sono i libri a sceglierci tra la moltitudine dei lettori. Non dimenticherò mai l’entusiasmo che mi colse leggendo la scena d’apertura. Era costituita da un’unica frase che, procedendo e formandosi a un ritmo ondulato, descriveva l’arrivo della flotta imperiale nel porto di Brindisi. La lingua da sola sortiva qui un effetto che aveva qualcosa di musicale e al contempo cinematografico. Broch stesso, in uno scambio epistolare con l’allievo di Freud Paul Federn, parlò con spregio delle proprie «frasi tortuose». Ma fu grazie a queste frasi tortuose che allora scoprii la lentezza del raccontare.
Questo saggio, apparso in Germania nell’edizione bilingue del volume Der Tod des Vergils. Ausgewählte Texte, con estratti dal romanzo di Hermann Broch, 32 disegni a tutta pagina di Anselm Roehr e un’introduzione di Durs Grünbein (Ulrich Keicher Verlag, Warmbronn 2009), è stato pubblicato in Italia nel numero 53/54 della rivista «Nuova prosa».

 Picaro qua, picaro là - Claudio Morandini
Picaro qua, picaro là - Claudio Morandini Lettera de genere - Stefano Zangrando
Lettera de genere - Stefano Zangrando An awesome place I’ve slept - Stefano Zangrando
An awesome place I’ve slept - Stefano Zangrando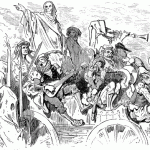 Don Chisciotte disoccupato - Stefano Zangrando
Don Chisciotte disoccupato - Stefano Zangrando La parola «avvenire»
La parola «avvenire» Un estratto da Una disperazione confusa
Un estratto da Una disperazione confusa “Se pensiamo in modo più iniziale”
“Se pensiamo in modo più iniziale” La vita raggiante
La vita raggiante





















