
C’è una dedica e una cartina geografica all’inizio di Narratori delle pianure. La dedica suona così: ‘A quelli che mi hanno raccontato storie, molte delle quali sono qui trascritte’. La cartina segna gli spostamenti di un anonimo viandante. Chi narra non ha nome. Il suo è un intento antico: raccogliere di paese in paese delle storie per poi raccontarle a una comunità di ascoltatori in grado di meravigliarsi e di trasmettere a voce la loro esperienza ad altri, magari ripetendo quelle storie con qualche variazione.
Ciò è ancora possibile in un mondo in cui la comunità di ascoltatori si è trasformata in un pubblico di lettori solitari e silenziosi? In un mondo in cui ogni autorità del racconto è venuta meno? Non si tratterà anche nel caso delle storie di Narratori delle pianure di finzione?
La sfida di Celati è proprio questa: in pieno regime di finzioni realistiche, in cui ogni racconto è ridotto dall’autore e dal lettore a un significato psicologico o sociale, ripristinare un regime di «finzioni a cui credere» (come suona il titolo di un suo saggio del 1984), ridare un valore cerimoniale al racconto individuale, mantenendo così un legame profondo con la tradizione, che altro non è per Celati che un’infinita ripetizione di racconti già raccontati, di storie passate di bocca in bocca, di ‘meraviglie del sentito dire’.
Certo, le storie di Celati sono storie senza ‘consiglio’, non portano in calce nessuna morale. Si fanno carico della loro perdita d’autorità. Ciò nonostante, prendono per mano il lettore e lo conducono alla ricerca di un’organizzazione possibile dell’osservazione del mondo esterno. Celati ha detto una volta, a proposito di Narratori delle pianure, che il solo scopo delle sue storie è quello di ‘portare sollievo’. Che cosa voleva dire? Credo semplicemente questo: narrare quel che c’è fuori, ovvero organizzarne l’osservazione, dovrebbe sollevarci dall’incubo dell’irreggimentazione teorica, da quel ‘delirio di consapevolezza’ che mentre classifica e spiega le cose ci allontana dalla possibilità di costituirci parte in causa.
La critica di Celati alla cultura razionalista trova compimento e soluzione in una rinuncia al romanzo moderno (novel), colpevole fin dalle sue origini settecentesche di incorniciare la fabulazione entro un programma critico, e in una rinuncia alla short story realistica, anch’essa, come il primo, riducibile a uno sviluppo di azioni finalizzate a una spiegazione discorsiva.
L’abbandono di questi territori, l’abbandono simultaneo cioè del romanzo, della short story e della critica, conduce Celati a quello stato di vero abbandono che è il contrario dell’inventare storie ben congegnate.
È come se un geografo, improvvisamente stanco di disegnare le sue carte, si fosse deciso a non calcolare più gli intervalli tra un luogo e un altro e avesse cominciato a misurare secondo il suo passo e il suo respiro tutta la difficoltà e tutta la bellezza di inoltrarsi in una terra incognita, quale in effetti l’esistente è, una volta dimenticati meridiani e paralleli.
C’è un piccolo ponte levatoio tra la cittadella fortificata delle nostre idee e le nostre emozioni, tra la nostra cosiddetta sfera interiore e la possibilità di dimenticare chi siamo, tra il sentirsi a casa e il sentirsi perduti. Per molti uscire di casa, o dal bunker che è diventata la loro casa, significa imbattersi nella banalità, nel ‘sentito dire’, dove non c’è salvezza.
Chi si sente perduto nel ‘sentito dire’ sembra avere una cattiva coscienza e un alto tasso di disprezzo per l’umanità, sebbene dalla cittadella fortificata delle sue idee dica di prodigarsi per ogni uomo. Attraversare quel piccolo ponte levatoio non è facile. Non tanto perché è molto più sicuro restarsene con chi ci fornisce sempre delle spiegazioni su tutto, quanto perché, attraversato quel piccolo ponte, si comincia di nuovo a balbettare, a fare i conti con il fondo emotivo di ogni nostra conoscenza. Passare dalla topografia dei luoghi alla terra incognita dell’esistente è riuscire a rinunciare al disprezzo dell’adulto che si balocca con le teorie a favore di un’ars immaginativa capace di pensare il mondo come nell’infanzia: quell’’età dell’infanzia’ di cui scriveva Giambattista Vico, la cui logica poetica presiede a diverse attività conoscitive anche in età adulta, ma che non è possibile rimettere in circolazione senza una pulsione regressiva.
Ecco, narrare, per Celati è l’atto incalcolabile di un malinconico che non teme né il riso né la follia né l’idiozia né l’incanto – sia nel senso di rapimento per meraviglia sia nel senso di intontimento improvviso e inspiegabile di fronte a qualcosa che è fuori di noi –, non teme lademenza insita in ogni stato malinconico, non teme cioè di perdere il controllo che la mensesercita sullo spazio emotivo. È sprofondando in questo tipo di stato malinconico, infatti, che lo scrivere diventa una forma di adesione empatica e insieme una possibilità di scambio di esperienza con gli altri. Il problema della ‘letteratura’ non è perciò quello di disegnare un atlante, quanto quello di incamminarsi senza sosta verso l’al di là che ci costituisce.
Celati, oggi, è il solo scrittore di lingua italiana nella cui opera comica e malinconica il lettore può valutare tutta la grandiosa difficoltà in cui si dibatte un pensiero immaginativo da quando, agli albori dei Tempi Moderni, la sede del pensiero ha assunto su di sé, unificandole, le facoltà dell’intelletto e quelle dell’immaginazione.
[Questo testo è la Prefazione al volume “Letteratura come fantasticazione”, Edwin Mellen Press 2009]

 Nomi - Massimo Rizzante
Nomi - Massimo Rizzante Fellini e il maschio italiano /1 - Gianni Celati
Fellini e il maschio italiano /1 - Gianni Celati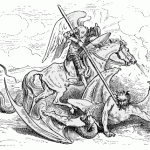 Hermann Broch e il romanzo polistorico - Stefano Zangrando
Hermann Broch e il romanzo polistorico - Stefano Zangrando Un ribelle conservatore - Massimo Rizzante
Un ribelle conservatore - Massimo Rizzante Prosa, poesia, maschio, femmina
Prosa, poesia, maschio, femmina Massimo Rizzante risponde a una sua studentessa su Milan Kundera
Massimo Rizzante risponde a una sua studentessa su Milan Kundera La modernità di Alejo Carpentier
La modernità di Alejo Carpentier





















