
Opera di Francesco Lauretta
«Cosa aspetti, andiamo, andiamo!, insiste Katia, dando dei colpetti contro il poggiatesta di Diego. Lasciamo stare, può essere pericoloso, mormora Marta. Katia allora la squadra con gli occhi grandi e fissi. È ubriaca e ha preso una delle pastiglie di Frank, ma il vero problema è un altro: a suo giudizio lei è una minorata, una maniaca che pensa solo alle trote. Per Katia sono un sinonimo di schifezza, le trote. Di schifezza e di povertà.
Secondo me è meglio lasciar perdere, ribadisce Marta. Diego però non la spalleggia. Fissa il torrente davanti al muso del fuoristrada con i gomiti appoggiati al volante. Non si vede quasi nulla, ma per quel che si può giudicare è impetuoso.
Siamo passati sabato scorso con i Nani, non è niente!, dice Katia, con la sua voce di bambina che fa i capricci. Sembra parecchio grosso, ribatte lei. È lui che ce l’ha grosso!, dice Katia indicando la nuca di Diego, e comincia a ridere. Ride tenendosi la mano davanti alla faccia, come si ride a scuola, e poi si piega in due, e si batte i pugni sulle gambe. Ride da sola, e da quanto ride le lacrimano gli occhi. Ride e piange.
Torniamo indietro, dice Marta. Diego alza impercettibilmente le spalle e irrigidisce il collo, come quando suo padre annuncia che farà i salami. Lei sa che pensa che ha ragione: si intendono anche senza bisogno delle parole, loro. Si sono sempre intesi senza bisogno delle parole. Si capiscono con la pelle, con il ritmo del fiato. Il fatto è che non vuole far la figura del pauroso di fronte a Katia.
Tua cugina è una cagasotto!, dice Katia. Ha ancora la faccia piena di lacrime, però adesso è seria. Diego si volta verso Frank, quasi implorando che lui decida di non andare. Ma Frank è fatto completo: una striscia di bava gli scivola in verticale sul giaccone da cacciatore e forma un piccolo lago sui pantaloni con le tasche sulle cosce. E comunque anche se si svegliasse non si tirerebbe certo indietro: è stato lui il più entusiasta dell’idea di Katia.
Allora lasciami guidare a me, Frank me l’ha promesso di lasciarmi guidare!, dice Katia, sporgendosi in avanti, a quanto pare decisa a passare davanti scavalcando i sedili. Diego si gira e le mette una mano sulla spalla: lei si risiede, anche troppo docile. Non è giusto!, piagnucola.
Andiamo a casa, dice Marta, quasi sottovoce. Se lo sente nella pancia, che può succedere qualcosa di brutto. Già in discoteca aveva il gusto di polvere sotto la lingua, il gusto che si accompagna al ricordo di sua madre. Katia non cerca più di passare davanti, ma in compenso si mette improvvisamente a urlare. Io voglio passare, non potete impedirmelo!, grida più forte che può, come fanno a volte i bambini. Lo abbiamo deciso tutti assieme, non potete tirarvi indietro!»
Visione, impeto narrativo e stile che trae forza dal basso, da una prosa che induce la lingua non solo a scelte di espressività terragna o colloquiale, ma anche a rinunce che ne dissimulano l’esattezza. Questo è l’incipit di Sacrificio, romanzo di Giacomo Sartori apparso nel 2008 presso peQuod e del quale è in procinto di uscire una ristampa per i tipi del medesimo editore, oggi Italic. L’occasione è l’adattamento teatrale del testo, curato da Sartori assieme al Gruppo Stradanova Slow Theatre in collaborazione con la Provincia di Trento, la cui prima andrà in scena al teatro Cuminetti di Trento il prossimo 24 maggio. Ripropongo qui di seguito, ad accompagnare la buona novella, la recensione al romanzo che scrissi cinque anni fa per «alias».
*
Giacomo Sartori, classe 1958, è un autore trentino residente a Parigi che pochi anni fa aveva dato prova di un notevole talento di romanziere con Anatomia della battaglia (Sironi 2005), in cui la lenta morte di un padre autoritario narrata con lucidità partecipe dal figlio ex-terrorista si fondeva con l’anamnesi di ciò che di irresistibilmente fascista cova nell’esistenza individuale e collettiva nostrana. In precedenza, oltre all’esordio novellistico de Di solito mi telefona il giorno prima (Il Saggiatore 1996), Sartori aveva trattato l’incrocio tra peculiarità individuale e genus locale anche in Tritolo (Il Saggiatore 1999), che affondava il coltello della conoscenza romanzesca nella duplice piaga della psiche borderline e del torbidume sociale del Sudtirolo profondo. Con Sacrificio (peQuod, pp. 189), Sartori ripropone un’ambientazione provinciale e montana, ma optando stavolta per un’universalità almeno in parte extra-storica che affonda le sue radici in un genere classico, la tragedia, apparentemente distante dall’albero narrativo del romanzo moderno e nei confronti del quale l’odierna narrativa mainstream manifesta una sensibilità e quindi un’ospitalità pressoché nulle.
Cos’è l’abnegazione quando, anziché scaturire da una fede o un ideale, è rilasciata a strappi dalla passione erotica come un ormone del dolore? Quali ragioni restano all’amore quando giunge a negare l’autoconservazione in nome di una grazia sempre di là da venire? Sacrificio risponde a queste domande, senza indulgere in psicologismi di sorta, con una storia compatta e serrata, in cui la narrazione è interamente al servizio dei personaggi, dei loro demoni interiori e dei loro atti imperativi.
In un’anonima valle trentina, un gruppo di giovani appena adulti trascorre i giorni uguali di un inverno senza neve tra lo zelo del lavoro e l’evasione serale tra pub, discoteca, freccette e stupefacenti. Ma la decadenza dell’ambiente, in cui convergono l’angusta mentalità paesana ereditata dai padri e le nuove corruzioni insinuate dagli interessi economici di chi preferisce un impianto di risalita a un parco naturale, è rotta fin dalle prime pagine dalla morte assurda di un membro del gruppo durante il folle guado di un torrente, a bordo di fuoristrada, in una notte di pioggia. A partire da questo evento, figura carica di allusioni del delitto che chiuderà il romanzo, si dipana una vicenda circolare di amori non corrisposti, di bontà immolate, di violenze più o meno gratuite – dove ad animare ogni gesto e ogni parola è appunto una sorta di forza ontologica e ineluttabile, la «necessità cieca» della tragedia.
La padronanza dei mezzi narrativi e l’empatia di cui Sartori è capace danno vita a personaggi grandiosi nella loro tormentata semplicità, dai protagonisti Marta e Diego, spinti nell’infelicità amorosa dalla tensione irrisolta tra «desiderio e bisogno di pace», alla fatale Katia, incarnazione moderna e degradata dell’eterno femminino: creature d’inaudita vivezza che accompagnano il lettore ben oltre i limiti linguistici e cartacei dell’opera che le custodisce.

 È arrivato Godot! - Marion Brasch
È arrivato Godot! - Marion Brasch Il cimitero - Georg Gehlhoff
Il cimitero - Georg Gehlhoff Eudemonia lagarina.
Eudemonia lagarina. 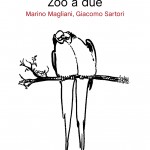 Zoo a due - Redazione
Zoo a due - Redazione Generation P o la deriva commerciale dello spirito russo (e non) nell’era telecratica
Generation P o la deriva commerciale dello spirito russo (e non) nell’era telecratica Lo Zibaldone campano di Enrico De Vivo
Lo Zibaldone campano di Enrico De Vivo An awesome place I’ve slept
An awesome place I’ve slept





















