
Se il giardino di Epicuro fosse uno studio di registrazione, lo si troverebbe poco fuori Nogaredo, sul basso versante occidentale della Vallagarina, nel sud del Trentino, dove la strada che attraversa il centro abitato inizia a salire verso Sasso e Noarna aprendo lo sguardo del visitatore sul panorama urbano di Rovereto. Lì, in una casa di poche famiglie, vive e lavora Marco Olivotto, musicista e demiurgo del suono, ma non solo.
Lo conobbi qualche anno fa, quando alcuni vecchi amici, membri di una band trevigiana che tra gli anni novanta e i primi duemila aveva lasciato una traccia ineguagliabile nel rock italiano, mi invitarono a un loro convegno in incognito proprio lì, tra le mura dello studio. Loro si chiamano Estra e ci sarà occasione di riascoltarli, visto che di recente hanno annunciato una reunion con un crowdfunding che, in due sole settimane, ha raggiunto e superato la somma richiesta per la realizzazione di un nuovo lavoro. Prima ancora di quel ritrovo clandestino, tuttavia, era stato il loro cantante Giulio Casale, che nel frattempo conduceva una carriera da solista, a sorprendermi con una visita serale a due passi dal Mart, dove allora abitavo, reduce dall’incontro con quello che sarebbe poi diventato il suo assistente in studio e responsabile della comunicazione.
Oggi di Marco Olivotto so qualcosa di più e, nonostante avessi presente quanto nelle ultime settimane si fosse dato da fare per gli Estra, gli ho chiesto di incontrarci innanzitutto per sapere qualcosa di un suo nuovo libro. No, non ha a che fare con la musica: di quella Olivotto aveva già raccontato nell’autobiografia La musica del silenzio (Edizioni Osiride, 2009), un volume che, oltre a rimembrare certi incontri sorprendenti – su tutti Peter Hammill, co-fondatore dei Van der Graaf Generator – ed entrare nel dettaglio dell’avventura esistenziale e sonora dell’autore, sorprende per la gratitudine che lo pervade e che esprime l’indole di un uomo versato nella cura dell’anima. La novità editoriale si intitola invece Capire il colore. Fotografia – grafica – stampa (ed. Il castello), un manuale che nasce dall’altra passione di Olivotto, che sviluppa e perfeziona una pubblicazione precedente e che, prima ancora di uscire, ha raggiunto con le sole prenotazioni la vetta della classifica del settore su Amazon.
Fisico di formazione e figlio di un fotoamatore, Olivotto non aveva mai smesso di interrogarsi sulla qualità dell’immagine, men che meno di fronte alle parti cartacee di cd e dvd. Ma è solo nel 2009, dopo la nascita del figlio Simone e una fase di rivolgimento personale, che iniziò ad approfondire la questione frequentando alcuni corsi di Dan Margulis, un maestro del trattamento del colore in digitale, e trasformandosi presto a sua volta da allievo a docente. Oggi insegna a Trento, nel corso di Alta Formazione Grafica e alla Trentino Art Academy, e il gruppo Facebook fondato dai suoi primi allievi ha nel frattempo superato, senza farsi pubblicità alcuna, i cinquemila iscritti. Interpellato sulle ragioni di un simile successo, Olivotto parla di “caso” e lo attribuisce al fatto di essersi trovato “nel momento giusto a dire le cose giuste nella situazione giusta, riempiendo un buco che c’era”.
Si attribuisce tuttavia una novità, quella di aver intuito che occorresse parlare anche di percezione, cioè “di come noi percepiamo il colore”, un fenomeno in gran parte ancora misterioso per le stesse neuroscienze. Mentre lo dice, mi domando in effetti come mai mi piaccia tanto il grigio muschio della t-shirt che ha indosso e su cui campeggia la scritta gialla a caratteri maiuscoli “INFANTE”, che si richiama, mi svela, a un lavoro discografico solista di Fabrizio Tavernelli, ex-cantante degli AFA (acronimo di Acid Folk Alleanza). E mentre al tavolo del suo soggiorno sorseggiamo una birra Hellpecker del birrificio “Birra del bosco” prodotta a San Michele all’Adige, si dilunga a raccontarmi quanto vada perduto in termini di informazione visiva – 24.999 su 25.000 parti – in una foto su un quotidiano cartaceo, eppure noi osservandola continuiamo a coglierne complessivamente la composizione cromatica. “È miracoloso”, commenta, poi aggiunge che persino Darwin ne L’origine della specie avrebbe ammesso la resa del proprio agnosticismo a un sistema, quello visivo appunto, difficilmente spiegabile in termini di “evoluzione cieca”.
Gli chiedo se questa passione visuale abbia costituito, nell’ultima dozzina d’anni, la sua attività primaria a svantaggio di quella musicale, illustrata con tanto entusiasmo nella sua autobiografia. Capisco però subito che la domanda è mal posta. Poiché lui, che quando si mise a studiare il colore lavorava nella musica da ormai quindici anni, all’epoca aveva sì sotto gli occhi i mutamenti in corso in quel mercato che avrebbero presto ridotto drasticamente gli introiti di qualunque operatore del campo, ma soprattutto aveva la sensazione di stare iniziando a ripetersi – una cosa, questa, di cui aveva orrore: “La mia domanda preferita”, dichiara, “non è come posso farlo di nuovo, ma come posso farlo diversamente. C’è sempre un margine per imparare, migliorare e scoprire le cose”. Non fu dunque, il suo, il ragionamento strategico di un mestierante, ma la riflessione di un artista e professionista incline alla ricerca. Così accadde piuttosto che le due attività si ribilanciarono, restando come strade parallele di un unico percorso, parti complementari di un unico “grumo” di cui neppure lui si sa dare spiegazione.
O forse un po’ sì, anche se non direttamente. Fu infatti il lavoro sulle immagini a riavvicinarlo alle origini: nell’aprile 2015 andò a un concerto a Correggio, dove fu ammesso tra i fotografi ufficiali. Ma di nuovo: non ci era andato per lavoro, si era invece offerto di ritrarre gli artisti sul palco gratuitamente, perché erano stati i protagonisti di una stagione musicale che aveva amato molto e verso i quali provava, semplicemente, “un’immensa gratitudine”. Alcuni nomi? Massimo Zamboni, Giorgio Canali, Gianni Maroccolo… Nulla di più familiare per chi sul finire del millennio ha seguito i CSI e altri gruppi, come gli AFA citati più sopra, che con loro facevano capo all’etichetta emiliana I Dischi del Mulo (poi C.P.I), protagonista di un decennio glorioso del rock indipendente italiano, e che quel 25 aprile si erano radunati per celebrare il ventennale di un cd collettivo, “Materiale resistente”, che resta ancora oggi il miglior rispolvero mai realizzato dei canti della Resistenza. Fu così che Olivotto si ritrovò catapultato in un mondo che aveva amato, e con cui da lì in poi avrebbe pure collaborato: grazie alla strada parallela, che lo aveva portato lì sull’onda di un nobile moto dell’animo. E oggi i ritratti in bianco e nero degli ex-CSI sul palco quella sera campeggiano nel corridoio di casa sua.
Mi viene da chiedergli, a questo punto, come mai non ci avesse lavorato prima, negli anni d’oro, con questi musicisti, vista la strada che, stando al suo primo libro, era riuscito ad aprirsi agli esordi. Olivotto su questo non ha dubbi, benché lo esprima con una pacatezza vicina all’esitazione: si attribuisce la “sindrome dell’impostore”, per cui quando era all’apice del suo percorso sonoro (ha lavorato con musicisti del calibro di Stefano Bollani ed Ezio Bosso, nonché con molti artisti d’Oltremanica) stava accuratamente alla larga dai fenomeni maggiori che godevano della sua ammirazione. Di fatto a lui, più che l’approdo alle grandi produzioni o ai grandi numeri degli artisti più popolari, interessava la qualità: adoperarsi per “il lavoro ben fatto” era quasi più forte di lui, e ogni volta che cercò di avvicinarsi a un mondo meno indipendente, più ufficiale, ebbe a pagarne brutte conseguenze, incarichi sottopagati o impicci d’altro tipo. “Questo era un segno del cosmo”, sostiene, “che dovevo stare nascosto”. Un po’ come Epicuro, il cui motto láthe biósas esprimeva l’imperativo di starsene in disparte rispetto a una polis ormai svuotata di senso.
Il paragone, infatti, non si limita alla scelta individuale. È vero che da allora, come accade, si aprirono per Olivotto porte ulteriori, e il rapporto con Giulio Casale è, tra gli approdi successivi, quello che ha più del magico per la catena di passaggi che nel giro di pochi mesi li avrebbero portati a collaborare – senza contare che, per vie analoghe, questo rapporto ha condotto a sua volta a una collaborazione con Talea, al secolo Cecilia Quaranta, giovane cantautrice jesina che, dopo un passaggio a X-Factor, va ora costruendosi una carriera da vera e libera artista. Ma è altrettanto vero che l’industria discografica italiana è diventata nel frattempo tremendamente asfittica, per cui “senza una rete che funzioni e molti compromessi non si arriva da nessuna parte”. Olivotto constata inoltre “appiattimento, confusione e un razzismo culturale che esclude invece di accogliere, proprio nel momento in cui avremmo tutti i mezzi per poter comunicare”, sicché sembra non rimanga davvero altra scelta che quella di coltivare nel proprio piccolo il buono, il bello e il giusto con le persone con cui si è in sintonia umana e artistica.
In Marco Olivotto non ammiro soltanto questa nobiltà di spirito, ma anche il rapporto con il figlio Simone, che ne è una conseguenza pressoché diretta. Nulla di troppo riservato, gli esiti sono pubblici: basta cercare fra i video del suo profilo Facebook le cover che hanno registrato insieme per avere un’idea di cosa possa scaturire da un amore per l’arte musicale e audiovisiva inseparato dalla cura degli affetti (e anche di come nasca un artista, giacché Simone, che ha solo quindici anni, dimostra in quei video doti stupefacenti da cantante e polistrumentista in erba). E siccome ormai di Olivotto mi è chiara l’ostinata attitudine al bene, sapevo che non mi avrebbe congedato con una diagnosi solamente negativa sul presente. Infatti mi ferma quando ci siamo già alzati in piedi, mi prega di ascoltarlo un ultimo istante e dice: “Quello di cui avremmo bisogno è un nuovo rinascimento”.
Di primo acchito mi sembra che stavolta abbia mirato un po’ troppo alto, ma poi si spiega: “Nel Cinquecento abbiamo avuto in Italia personalità che avevano colto tutta l’ampiezza dell’orizzonte delle arti e dei saperi, praticandole in forme poliedriche e sostenute in questo da un sistema orientato all’incontro e al dialogo creativo. Oggi è più complicato, certo, con tutti i nostri compartimenti stagni, le strutture gerarchiche e istituzioni sorde a questo tipo di mecenatismo. Ma è possibile che non sappiamo fare altro che sostituire queste strutture con nuove gerarchie?” Mi cita al volo i trenta secondi iniziali di Universal mother, uno dei dischi meno famosi ma per lui il più bello di Sinéad O’Connor, la grande cantante irlandese mancata di recente e nota per l’emarginazione subita dall’industria musicale: è una voce di donna che in un frammento d’intervista afferma che “l’alternativa al patriarcato non è il matriarcato, ma la fraternità”. È allora che mi sembra di capire cosa intenda Olivotto con l’idea di non sostituire una gerarchia con un’altra.
Lui però prosegue: perché dunque oggi sostituire l’industria musicale con Spotify, che invece di una gerarchia è persino una dittatura? Giacché “se non ci sei, non sei più nella directory mondiale degli artisti attivi” – e mi cita l’esempio di Neil Young. Spotify come l’odierna polis musicale autoritaria, dunque, o di più: come certificato d’esistenza, unico ed esclusivo. Per forza che poi a un puro come Marco Olivotto possa venire voglia di vivere nascosto. Per fortuna, d’altro canto, nel suo giardino insonorizzato di Nogaredo si seguitano a coltivare il suono e il colore, e in forme intergenerazionali: il presente e il futuro della musica, lassù, trovano un nutrimento sano, resistente a qualsiasi compromissione.

 A proposito di Zibaldoni - Claudio Morandini
A proposito di Zibaldoni - Claudio Morandini Il delta - Kurt Lanthaler
Il delta - Kurt Lanthaler «Quel passetto in più».
«Quel passetto in più».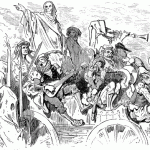 Don Chisciotte disoccupato - Stefano Zangrando
Don Chisciotte disoccupato - Stefano Zangrando La necessità cieca della tragedia
La necessità cieca della tragedia Palle e alghe
Palle e alghe Lettera de genere
Lettera de genere Hermano germano
Hermano germano





















