
Ma, come fu sempre per ogni cosa sua in cui Valmarana avesse ficcato il naso, Sommariva aveva la coscienza sporca.
Un paio di mesi dopo la scenata (ciechi volti di suore paralizzati in un grido afono, miti sacristi che sculettavano un po’ ovunque in preda a panico pollastro, i bambini, noi e voi, attoniti addipanantesi il pandemonio, alcuni in lacrime, e fogli o forse ali di corvi che si sparpagliavano nei corridoi e lungo lo scalone che portava ai piani alti del Pio Istituto, e a momenti credevi vedere un carro di fuoco sotto i piedi di don Giorgio Giorgio che in egregia posa judicans allontanava da sé e l’intruso e le sue fotocopie, e avresti giurato ai piedi calzasse dei biblici sandali di pelle e non le sue scarpe ortopediche, e magari un verde angolino di fazzuolo a occultarne il più bello tacer) che aveva fatto seguito all’incursione di Valmarana nel Pio Istituto di S. Satiro, la dirigenza dell’Istituto era stata raggiunta, come con lei tutti i lettori e gli abbonati al Gazzettino di Briwen, dalla notizia del ritrovamento, nei sotterranei del Pio Istituto medesimo, di alcuni frammenti dispersi da un non ancora identificato manoscritto di Lapin: ma verosimilmente il torturatissimo Cuniculum. Autore della scoperta, Valmarana, che se ne pavoneggiava davanti ai quattro eminentissimi e talora emeriti gatti che allora si occupavano di filologia lapiniana, esibendo (lui, il Valmarana) le inestimabili carte – curando beninteso di mostrarne solo il recto, dato che il verso, originariamente bianco, era occupato per intero da quel che s’è detto, e che per la sua sconcezza Valmarana era stato invitato, dallo stesso don Giorgio Giorgio che ora se ne rimordeva amaramente, a portare via con sé: troppo disgustato, l’ex sacerdote, per anche solo toccare quelle carte, quasi le valmaraniche posterga vi si fossero stampigliate per effetto di un contatto miracoloso (diabolico, anzi!) simile a quello della venerata Veronica. Così Valmarana aveva trafugato sotto gli occhi di tutti i Frammenti extravaganti, come si affrettò a battezzarli per poi altrettanto bravamente pubblicarli. Eccoli.
***
Frammento postumo 1: I morti di Chopin.
Li diresti delle specie di parassiti vegetali, immobili tra gli alberi, la pelle color avorio e i corpi talmente sottili che il lucore nero degli occhi e i loro miseri vestiti si notano solo in un secondo momento, quasi un qualche meccanismo di tipo mimetico li avesse brevemente fatti apparire come una modificazione del fogliame. È il respiro che ad un certo punto li tradisce, l’unico movimento non vegetale cui sono costretti. Il lucore nero e privo di speranza degli occhi di un animale immaginario. La mia bambina mi stringe due dita e mi chiede “Sono quelli i morti?”
Gli altri invitati hanno preso posto nel giardino. Mentre mi avvicino al tavolo noto un terrario in cui sono tenuti dei bonsai senza foglie, rami sottili che culminano in gemme nere e tonde e sembrano dita pietrificate di alieno. I bonsai sono protetti da lastre di vetro e intorno a loro si sta diffondendo una luce rossa e azzurra. Con un effetto che (conoscendo i gusti mandatoriamente raffinati della nostra ospite) si può ragionevolmente ritenere calcolato, poco discosto un’araucaria, in lieve pendenza verso le profondità del giardino, sembra inserirsi com un turgore nella cornice nera del terrario. Resto a fissare l’insieme, incurante dei richiami della mia bambina, indeciso se fotografare il tutto, aspettando che il rosa e l’azzurro e i morti e la piccola mano che stringe le mie dita svaniscano del tutto.
***
[Nota: La numerazione dei frammenti segue semplicemente l’ordine in cui sono stati fotocopiati, che nonostante la concitazione del frangente Valmarana è riuscito a ricostruire sulla base del progressivo disallineamento del solco intergluteo rispetto alla posizione iniziale, che era non centrale sibbene alquanto latearale, a dividere in proporzione aurea il foglio siccome usa tra i più eletti teppisti du bureau. Non pochi sono i dubbi sollevati intorno all’autenticità di questi frammenti, come qui l’apparizione di una non mai vista prima bambina. Considerato però che la grande parte di In cuniculum è in ogni caso perduta, nulla vieta di supporre che tale bambina occupasse uno spazio importante e magari persino decisivo nelle “memorie” di Lapin.]
***
F. p. 2.
Ha il corpo minuto e solido di una acrobata. È magra, vecchia, sorridente. Un corpo il cui tessuto muscolare è stato sistematicamente coltivato e portato al limite. Ora che lei ha più di sessantacinque anni, il corpo funziona al di là della sua (di lei) coscienza, una sorta di ombra muscolare di cui è lei ora la sorridente esecutrice.
– Poiché niente dà gioia quanto l’essere schiavi del proprio corpo.
Sorride e le si illuminano gli occhi mentre il suo corpo si mette a cavalcioni del doppio corrimano di legno che divide in due la scalinata del vecchio hotel. Sorride e io capisco che sta per mostrarmi un numero acrobatico, ed è come se lei stessa stesse a propria volta capendo quello che il corpo farà, lei stessa ubbidendo all’oscura volontà priva di coscienza dei propri nervi, e forse quel sorriso e quegli occhi luccicanti sono in realtà il grido d’aiuto di un’anima condannata a eterno tripudio, e a cavalcioni della ringhiera la vecchia acrobata continua a fissarmi con gioia implorante, finché poi si lascia scivolare all’indietro come il monello di un vecchio film, abbandonandosi all’inclinazione del corrimano tra le sue ginocchia, e giusto un attimo prima di arrivare in fondo alla ringhiera, che è anche il momento di massima accelerazione, dalle mani e dai polsi (ma l’origine del movimento, mi rivelerà più tardi la donna, e solo in quel momento mi renderò conto di quanto sia minuta, quasi una bambina di otto anni, l’origine del movimento è nella punta delle dita, ovvero in una zona imprecisata tra le vertebre – e quelle due origini così distanti tra loro, una così precisa e l’altra indeterminata –– ha detto proprio “imprecisata”, mentre gli occhi le si illuminavano ancora di più –– quelle due origini lasciano una volta di più trapelare le catene di ferro cui la vecchia acrobata è imprigionata, la logica oscura e preterrazionale del vasto, sanguinolento ed erettivo tessuto muscolare –– muscoli come una mattutina insopprimibile erezione adolescenziale – la logica inaccettabile della doppia origine, dell’identità tra vertebre e punte delle dita, Ma piaccia o no è così, mi dice o è costretta a dire più tardi la vecchia acrobata premendo i polpastrelli delle dita dal mignolo all’indice della mano destra sul dorso della sinistra quasi come un violinista che fa il vibrato – come il mio violinista mentre fa il vibrato – , le vertebre e le punte delle dita sono interconnesse attraverso l’oscillazione ovvero il vibrato, e quindi è la giusta frequenza di movimento del polpastrello ad imprimere la corretta curvatura alla schiena così come alla corda di un violino ovvero alla nota emessa dallo strumento, ossia: la curvatura della spina dorsale è esattamente come la nota di un violino, “E solo volessi”, mi dirà più tardi la vecchia acrobata, “potrei accelerare di tanto la frequenza da spezzarmi la schiena da sola, così…”, e le sue dita iniziano a (o sono costrette a) oscillare a tale velocità contro il dorso della mano sinistra che quando la frequenza oscillatoria raggiunge il punto di rottura gli occhi della donna toccano un culmine di luce come in un orgasmo o una scorticazione e la sua spina dorsale, come mi verrà più partitamente dimostrato in una serie di impressionanti diapositive, inizia letteralmente a dibattersi attraverso la sua schiena come un’anguilla caduta sulle piastrelle di una vecchia pescheria, ad ogni nuova spira il rumore sordo e irreparabile di rametti stritolati dalla ruota di un carro, “Come andare in bici su una strada sterrata, vero?” dice la vecchia acrobata tremando e rallentando progressivamente la vibrazione prima che la colonna vertebrale crolli su se stessa come una collana cui si sia rotto il filo, “come il crepitio di un falò o di un giradischi”) o forse da un punto imprecisato tra le vertebre si sprigiona una rotazione che senza il necessario tono muscolare e nervoso spezzerebbe le ossa della donna, e l’acrobata viene catapultata in un salto mortale all’indietro quasi a perpendicolo sopra il punto d’appoggio che al culmine della parabola la porta a sfiorare il soffitto e il rilevatore antiincendio del vecchio hotel prima di cadere a piedi uniti a pochi centimetri dalla fine del corrimano – che arriva quasi allo sterno della piccola acrobata vecchina – le punte dei piedi che sfiorano appena l’alzata del primo gradino, lo sguardo radioso e disperato, le braccia allargate come un robot giapponese pronto per il decollo, un numero acrobatico perfettamente riuscito e altrettanto perfettamente inutile, non fosse per la mia meraviglia.
***
[Nota: se l’acrobata è certo una figura più familiare nel cosmo lapiniano, di nuovo sospetta appare la collisione neanche troppo subliminale tra la vecchietta e, di nuovo, una bambina]
***
F. p. 3.
Appena comparse, le fate o quello che sono (hanno corpi leggermente trasparenti che si compenetrano a vicenda come in un effetto cinematografico dei primordi) fissano con allarme una zona buia alle spalle di mia madre, sulle scale di legno dall’alto delle quali le stiamo guardando, compunti e ridicoli come una famiglia puritana nel cuore della notte. Il demone ronza alle spalle di mia madre. Poi, i loro corpi unica luce della casa, iniziano a parlare tutte insieme (come ho detto credo siano cinque, tre più chiare e due più scure) e anche le loro voci come i loro corpi si compenetrano, e così come i loro corpi sono ora una sorta di fascio luminoso in cui si riconoscono a volte sagome di membra e volti come in una densa foschia e un liquido, anche le loro voci sono come mischiate in un suono che non è fatto di parole umane e può forse essere paragonato a due violini, flauti, organi, o tre soprani e due contralti che cantano insieme a creare una stratificata fascia sonora. I dialoghi delle fate, penso io, finché mia madre esasperata le ferma. Loro si girano verso di lei, di noi, i loro visini rivolti pulcinescamente all’insù. Una mi guarda e poi dice, “Tu!” e tutte le altre ripigolano il tu come undici clavicembali e tre soprani e due contralti. Mia madre crede parlino a lei. “Io?” “No!” pigolano le fate, sfumando nella luce e nei suoni. “Tu!” “Lui?” riilluminandosi, o più propriamente reincarnandosi di luce, “Siamo contente di come difendi la tua famiglia,” cioè mia madre e mia sorella. Annuisco, sorrido. Le fate sanno tutto. “Combatti per loro”. Alla mia sinistra sento la presenza di mia sorella, appoggiata alla povera ma dignitosa ringhiera di legno; più su rispetto a mia madre, praticamente invisibile, è appollaiato, credo, mio padre e forse anche mio fratello.
“Lui!” pigolano con urgenza infantile, ma l’unica cosa che m’hanno detto è che devo combattere, e solo con quello m’han fatto sentire pronto ad ogni nemico.
***
F. p. 4. Tutti i meccanici
Tutti i meccanici di Waltzwaltz hanno la loro officina (capanne di cartone e lamiera in cui i meccanici ciondolano con familiari e amici, ipnotizzati dall’ininterrotto gorgoglio del canale, filo d’acqua color piombo, estremo capillare di un fiume remoto come un sogno; i meccanici ciondolano tra le auto da riparare – veicoli in deposito da mesi, da anni, forse da sempre –– alcune delle officine di Waltzwaltz sono state di fatto costruite attorno alla carcassa di un’automobile trascinata chissà come fino al bordo del fiume, dopo chilometri di granturco ––– le officine di Waltzwaltz sono più quel che una popolazione di bambini chiamerebbe “officina” durante un gioco che officine vere e proprie, e appaiono altrettanto precarie di un gioco pomeridiano, ma sono di fatto altrettanto antiche e indistruttibili che l’idea stessa di gioco).
La famiglia e i conoscenti dei meccanici vanno avanti e indietro dall’officina come formiche dal buco d’ingresso del formicaio, un pulsante e fraterno va e vieni di vecchie chiavi inglesi, cavi elettrici sfilacciati, barattoli e lattine mezzo vuoti o bucherellati dalle fucilate. Come un teatro zingaro – il celebre teatro zingaro di Waltzwaltz, il cui palcoscenico sono gli ondivaghi rioni della città nomade, dove lo spettatore si perde senza nemmeno sapere di essere spettatore, di stare osservando attività fasulle e quinte teatrali – a volte lo spettacolo e il sole accecante del teatro di Waltzwaltz, il canto delle tortore e l’ininterrotto gorgoglio dei canali finiscono per risucchiare ogni residuo di ragione allo “spettatore”, gonfiandosi come zecche metafisiche di gorgogliante materia grigia, pendendo dalla testa innaturale- ovvero teatrale- mente gonfia dello spettatore, una testa da catoblepa che lacrima canali, officine, campi di mais pronti, una volta gonfi di materia grigia, a cadere e deporre nuove migliaia di uova nel terreno infetto del teatro. Allora, febriciante come un marinaio di Stevenson o un viaggiatore di Poe – altrettanti zingari precipitati dal cielo del teatro di Waltzwaltz per finire assorbiti nella carta dei romanzi – lo “spettatore” cade a terra sopraffatto dal peso della propria testa, il cranio ridotto a una tremula cartilagine dal vento irto di sabbia del vicino, imminente deserto – “Viviamo nel deserto” non fanno che dire gli attori di Waltzwaltz, ma anche il deserto è parte del palcoscenico, da qualche parte c’è sempre un rubinetto d’acqua corrente, bottigliette di bibite gassate – e come davanti a loro c’è il deserto, alle loro spalle c’è la città con le sue centrali e i suoi pozzi.
“Viviamo nel deserto” è solo un’altra delle battute del teatro – e come ogni battuta teatrale che si rispetti anch’essa allude ad una verità profonda, in questo caso l’ubiqua imminenza del deserto per ogni città – e che siano forse le città con i loro molli ed enormi occhi luminosi, che siano forse le città i veri spettatori del teatro delle officine di Waltzwaltz?
Come in un’esausta milionesima replica, devo eludere i controlli della caserma in cui sono distaccato in modo da raggiungere qualcuno, forse una donna, camminando lungo l’argine di un fiume ovvero di un canale, ma i meccanici di Waltzwaltz hanno ostruito il cammino con delle minuscole antenne o centraline, non saprei come chiamarle – finti congegni elettrici semplicemente conficcati nel terreno. Fin qui però tutto era filato: non era stato difficile eludere le sentinelle della caserma, seguire la strada bagnata che costeggia in arcate il canale e che forse è a propria volta un braccio di un “labirinto” di Schwarzschwarz ––– ah, che mi trovi nella zona di confine tra le due nazioni nemiche?
Chi è la donna che devo raggiungere, la città che devo visitare? Esiste forse una terza città? Esiste forse, magari nascosto dietro un cumulo di ciarpame secolare, esiste forse un sipario per il teatro di Waltzwaltz? Sempre che sipario non siano le vetrine delle officine – e ora ti chiedi dove mai abbiano trovato intere vetrine in mezzo al deserto, dato che ogni officia è costruita con ciarpame – ma le vetrine sono reali, così come a teatro è il sipario l’unico oggetto reale – non c’è che la membrana, sempre e ovunque, a garantirci che fuori c’è un fuori, se non una realtà – le vetrine cui il sole con la giusta inclinazione inietta colori di intensità tale da cancellare i “meccanici” che ciondolano dietro l’officina, e allora un ultimo attore o forse un inserviente avanza verso la figura accasciata sui campi di granturco, ormai del tutto risucchiata essa stessa dalla propria testa mutatasi per contagio genetico in zecca – e con una chiave inglese o un martello rompe l’ultima membrana ossea, e non si sa nemmeno più chi debba applaudire e chi inchinarsi al ritornare della luce in sala, mentre dai palchi in festa inizia a cadere una pioggia di rose.
***
[Nota: con tipica civetteria filologica, molti hanno sottolineato in questo frammento echi con altre sezioni di In cuniculum, solo per insinuare il dubbio che una tale messe di echi sia da considerarsi come minimo sospetta]
***
F. p. 5.
La prima immagine del video è sfocata e rapida, ma riconosco il dio Phanes, e la voce che mi parla, forse quella di un sacerdote, mi fa capire che lo scopo del rito è trasformare un bambino nel dio, facendo in modo che un serpente gli si attorcigli intorno e lo uccida.
Ora si vede un basamento di roccia naturale con una specie di lacerato accumulo di rossi rilievi precolombiani, calendari maya trasformati in aureole di mostri aztechi. È il kitsch del nuovo Eden. Dovrei distinguere i bambini sacrificati, il bambino e la bambina che ho fatto in modo restassero con la madre. Poi un’intera sequenza del rito, una vera e propria scenografia teatrale per la cui realizzazione è stato a un qualche livello coinvolto anche Fellini (sulla sinistra una gigantesca testa di donna srotola un’ininterrotta lunghissima lingua d’oro, come un vomito). Ci sono forse tre livelli nella scenografia, che ha un carattere festoso e sovrabbondante, a metà fra una fontana monumentale e un carro meccanico rinascimentale.
Si vedono donne impegnate in un qualche tipo di danza. Donne con lunghi capelli neri, gigantesche donne mediterranee che ridono affaccendandosi a piedi nudi sul palco. Cantano inni sacri di un sanguinario e fastoso impero che credevamo sepolto da millenni, ma niente si può mai davvero seppellire, finché anche un solo uomo resterà in vita niente sarà mai davvero sepolto. Sulla parte alta, nella zona scenografica delle metope, dovrei vedere i corpi di due bambini divinizzati. Invece non vedo nulla, se non forse una chiazza di sangue contro la parete d’argilla. Cerco di tornare indietro col video ma sbaglio qualcosa, perché invece lo mando avanti: ora dalla zona delle metope un grappolo di donne mediterranee si lascia cadere srotolando lunghissimi panni in cui si sono avvolte come per un numero di giocoleria zingara, la caduta accompagnata da un ultimo grido di gioia del coro, accordi ormai fossili accompagnati da cembali turchi.
Sopra le metope, dove ci sarebbe dovuto essere il timpano, c’è invece una specie di corridoio o forse un’intera sala (non se ne intuisce la profondità) interrotta da sottili e non troppo alte colonne, dietro cui corrono e giochettano bambine in vestaglia bianca. Delle novizie? Future ulteriori vittime se lo stritolamento non facesse emergere un dio? Mentre finalmente capisco come tornare indietro col video, tutti i contorni della visione perdono fuoco. Devo rifare tutto daccapo.
(Poco prima giocavo su una spiaggia con un gigantesco granchio del Giappone. Mi aveva pinzato vari punti del corpo – ogni zampa terminava con una piccola pinza da aragosta – ma ero a mio agio con la creatura, che ad un certo punto si concentrò su alcuni punti della mia schiena difficili da raggiungere per le mie braccia. Io tiravo le lunghissime zampe, quando potevo il corpo geoidale, ma c’era sempre almeno un paio di tenagliette che restavano attaccate alla pelle come dentini di un gatto che gioca. Non avevo paura: non avevo che da allontanarmi dal mare, e il mostriciattolo al sentire l’aria bruciargli i polmoni avrebbe subito smesso di “giocare”. Per quanto possa giocare un crostaceo.)
***
[Nota: la presenza di figure femminili, tra bambine, vecchie acrobate, fatine e gigantesse è assolutamente insolita rispetto agli altri materiali superstiti di In cuniculum. Ma di nuovo, v. supra]
***
F. p. 6.
È un piccolo appartamento imbiancato da poco. Una cittadina del centro Italia, forse. Ha soffitti singolarmente ampi. Ci sono telecamere di sorveglianza collegate ad uno schermo dentro l’appartamento, e qualcosa effettivamente succede (forse io e gli altri che sono con me siamo delle specie di indagatori dell’incubo, o un altro di quei lavori clowneschi che da un momento all’altro possono rivelarsi l’occasione per una carneficina, non importa se corporale o psichica).
C’è qualcosa di molto sbagliato che sta succedendo proprio nel momento in cui io mi trovo lì, anche se io non me ne rendo conto che in modo vago e inebetito. Sono mezzo nudo, i miei vestiti sono in terra. Fuori le persone sono molto allarmate, anche se forse lo schermo non me le sta mostrando più per come sono ora. Lo schermo è forse parte del maleficio che incombe in questo appartamento in affitto per turisti in quella che ora forse è piuttosto una località della Francia o della Grecia.
Soffitti piuttosto alti, pareti dai contorni irregolari, ad angolo retto ma irregolari, un giroscale o degli scalini esterni… pareti imbiancate da poco (una delle ossessioni di Adra: pareti imbiancate da poco, sotto il bianco coprenti qualcosa di terribile, biancoprenti, veicolo di una rivelazione oscura come certi templi buddisti –– narrano di una religione invisibile i cui templi si mortificano a un livello tale da essere indistinguibili dalle baracche dove si raccoglie la schiuma dell’umanità senza sapere di essere nel cuore della più antica delle proprie cattedrali ––– l’età di un culto si misura con la sua progressiva indifferenza al fasto, col suo essere i suoi riti sempre più coincidenti con i più banali e persino triviali gesti quotidiani); mi gridano attraverso la porta (ha una serratura a vite come una carica a molla (non è vero: come casa mia a Riva); “Prendi i vestiti al volo e esci subito”.
Prima apro la porta, poi inizio a strisciare fuori di lì, mi sveglio e sospiro “Forse rimarrò ancora un po’”. Sono nel mio letto.
***
[Nota: la presenza di questi e altri inserti epiparaperiteologici ha fatto sì che alcuni tra i più tristi tormentatori accademici di Sommariva arrivassero a supporre una congiura, subito battezzata “Dei Tre Giorgi” (don Giorgio Giorgio, Giorgio Sommariva e Giorgio Valmarana), per usare il nome di Lapin onde pubblicare propri personali farnetici]
***
F. p. 7.
Andiamo a trovare il vecchio drammaturgo africano nel suo pied-à-terre ravennate. L’invidia che ho sempre provato per il suo successo scema un po’ nel momento in cui mi rendo conto che non ha in effetti poi scritto così tanto. Attraversando la penombra delle scale e salendo verso il cortile con l’ascensore insensatamente moderno, quasi un multidirezionale ascensore di cristallo à la Willy Wonka, non fosse per il telaio di acciaio nero in cui è ingabbiato, riesco a ricordare forse un paio di opere di questo cosiddetto maestro.
Ma siamo andati a trovarlo perché ci hanno detto che ha appena scritto qualcosa di nuovo… no… ci sembra strano… rivelazione allucinatoria della sua carriera come una pista da bowling chiusa, in fondo alla quale luccica la rara fosforescenza dei suoi scritti…
Poi siamo nella sua cucina. Pavimento in granulato. L’opera, la nuova opera è pronta. Il grande drammaturgo africano la estrae direttamente dal forno. Consiste in un casco nero da motociclista decorato con disegni di fiamme.
– Here it is: it is all yours.
Non è inusuale per lui confezionare le opere in questo modo. Il casco è per lui il corrispettivo contemporaneo della maschera greca. Questo casco in particolare ha incorporata una potente e rarissima radio mini-Giabba.
***
F. p. 8. I concerti di Brahms
…e la donna di cui tutti avevano riso, una vecchietta magrolina come intrappolata in una camicetta a fiori (o forse è un intero vestitino?), è lei la prima a farsi vicino al cadavere: noi non osiamo, sebbene sia il corpo di un amico. Tutti si comportano come se non avessero visto nulla, come per ritardare il più possibile il momento in cui la festa dovrà essere interrotta.
Quando le urla delle donne del paese rinforzeranno oltre la pseudo-non-udibilità? o quando la polizia verrà da noi a chiedere se conoscessimo il morto? Quando sarà? Io poi ho visto tutta la scena: lui che, dopo il terzo giorno di fila di festa, porta una ragazza fuori dalla casa (ninnoli africani costruiti con chiodi arrugginiti e ossa umane, paravento giapponesi attaccati alle pareti e al soffitto per modificarne la forma, frittelle alla crema e fette di roastbeef, il figlio ritardato della padrona di casa che suona una trombetta giocattolo che in qualche modo si sovrappone alla perfezione ai due concerti per pianoforte e orchestra di Brahms, rivelandone e insieme prosciugandone il composto tormento. Brahms scambiato per un fagotto di stracci mentre viaggiava ubriaco fradicio su una barca a remi a Riva del Garda).
Loro due si erano alzati ed erano usciti sotto una pioggia primaverile bagnata di sole. Come in una brutta pubblicità degli anni ’80, avevano iniziato a ridere e a baciarsi sotto la pioggia, fino a che le risate e le effusioni non avevano deragliato dal contesto accettabile di una pubblicità per un gelato alla panna e lui si era abbassato i pantaloni e lei si era alzata la gonna e avevano cominciato a fare l’amore in piedi. Non esistono esercizi di stile nella pornografia? Si erano messi sotto una piccola tettoia che non li riparava per niente, lei in piedi, le gambe non avvinghiate a quelle di lui, una posa diremo quasi medioevale, ovvero carica di quel vago senso di impossibilità che hanno le pose delle persone in certi dipinti medievali, figure sbozzate di fretta e la cui creazione frettolosa e distratta permette, come la trombetta del bambino sopra i concerti di Brahms, di far filtrare altre verità, altre realtà. Insomma scopavano di santa ragione e ridevano sotto la pioggia assolata senza accorgersi che delle persone si stavano avvicinando, indifferenti alle loro effusioni.
Volevano entrare nella baracca col tetto sfondato in cui si erano infilati, così sembrava, e i due bloccavano la porta. Lui si staccò da lei e fece un manieroso inchino, enfatizzato dalla camicia a fiori azzurri di lei, bagnata e illuminata dal sole. Il gruppo lo circondò e iniziarono a picchiarlo. Non ricordo cosa facesse la ragazza, forse era rimasta bloccata contro la porta, paralizzata dalla propria stessa simbolicità, o forse qualcuno degli aggressori l’aveva presa, o forse era fuggita. La porta era quella di un bar o di un ufficio postale. C’era pace nell’aria, e la pioggerella era già svanita quando tutte le persone del gruppo tirarono fuori le pistole e iniziarono a sparare intorno a lui. Miravano davanti ai suoi piedi, intorno al suo corpo, quasi come in un numero di lancio dei coltelli, e forse il suo errore fu proprio quello di mettersi a scappare.
Lo inseguirono per una salita di mattoni molto apprezzata dai fotografi che di quando in quando visitavano il paesino sulle tracce di un primo antedigitale e forse persino antecromatico fotografo che un giorno aveva immortalato quella stessa pendenza di quella strada di mattoni, in qualche modo così paralizzando il villaggio in quella posa per sempre, nessun rimodernamento urbano mai, pur di non tradire l’immagine. L’avevano inseguito camminando e sparando, crivellandolo, e ad occhi chiusi avresti detto che qualcuno giocava con i petardi, ma il suono del proiettile, si sa, è più cupo.
Svoltato l’angolo, era morto. Era il mio chitarrista. Gli uccisori se ne erano andati. Riuscivo a vedere il corpo a metà, nascosto pietosamente dalle case. I jeans, la pancia scoperta, un po’ di pinguedine a stento arginata. Dov’era finita la ragazza?
La vecchia pazza strillava.
***
F. p. 9. Ora la casa
La notte si sente piangere il suo bambino, ma ora la casa è mia e se ne devono andare. È una vecchia signora piuttosto disordinata, cui la padrona di casa precedente aveva affittato una delle stanze della casa che ora è mia.
La stanza è chiusa da una porta blindata ancora posticcia: i lavori sono stati interrotti a metà per via dell’insorgere del virus; la porta è incorniciata da un mero telaio di legno ìm [Nota: non è stato finora possibile capire a quale tipo di legno si riferisca il testo con la parola ìm. Com’è noto, questi brevi lampi a-semantici ossia a-linguistici hanno indotto più di uno studioso nella tentazione di vedervi avanzi sbriciolatissimi della prima lingua umana, quella prima della torre di Babele] e credo potrebbe essere facilmente buttata giù a calci.
Ero talmente abituato alla presenza della vecchia signora da aver dimenticato che ora la casa è mia e se ne deve andare. La incontro e le spiego la cosa, lei ogni volta glissa.
– Ne parleremo.
Ancora una volta cerca di liquidarmi (nel frattempo mi è venuto in mente che per sbatterla fuori forse mi basterà cambiare la serratura della porta di casa) ma io la blocco e le dondolo il dito indice davanti alla faccia in segno di diniego, e le dico che dobbiamo risolvere la questione ora, che l’accordo che lei aveva era con la vecchia padrona di casa, e non con me.
Lei mi fa lo stesso gesto col dito. Tutta la discussione si svolge in modo molto calmo. Alla fine ho la meglio e la vecchia attrice chiama gli altri componenti della compagnia amatoriale di cui fa parte perché la aiutino a portare via il suo scenografico armamentario di bauli, paraventi, vecchi costumi rosicchiati dalle tarme, dalla polvere, dalla luce, dal mero teatro. Un paio di vecchi attori mi guarda in silenzio, piegando sacchi di stracci dentro una valigia. Tolgono vestiti da un vecchio armadio sghembo messo in mezzo alla stanza. Poi tolgono le quattro assi di compensato che usavano come scenografia per le loro prove casalinghe.
– Avevo il permesso di restare senza pagare l’affitto.
– Non da me. Non te l’ho dato io questo permesso.
Dell’acqua cade sul mio barattolo di vitamine effervescenti: ormai sono da buttare. O forse dovrei versare in una bottiglia d’acqua il pappone di pastiglie che deve essersi formato nel tubetto e avere così pronta una bevanda alle vitamine? La casa ora è mia. Una volta rimosse le assi che facevano da precaria parete divisoria, si libera una stanza molto grande, le pareti talmente bianche da essere impossibili da mettere a fuoco, di fatto anzi l’occhio disorientato non riesce a mettere a fuoco nulla. Uno spazio libero, bianco, e ora che gli attori stanno per sloggiare sarà tutto per me.
Qualcuno ride delle mie mutande, della fantasia a ranocchie stampigliata sul tessuto. Forse oltre l’impalcatura della porta blindata c’è ancora uno spazio da abitare. Vecchie assi cigolanti di colore chiaro, da fuori una luce come da una prateria, e tanto è lo spazio che la casa sta rivelando che posso persino correre.
– Altre perperperpersone vivono con me!
Corro, ridendo. Tutti ridono, anche la donna che ho scacciato.
– Questa casa è piena di spazio e di spettri!
Mi sveglio dicendo rauco “Potete restare”.
***
F. p. 10. Il cinema del terrore
Un film del terrore, che guardo e del quale insieme mi ritrovo ad essere un personaggio, un film del terrore legato al ritrovamento di una vecchia bambola africana che fa sì che le persone che ci entrano in contatto vengano possedute da un demone che finisce per distruggerle.
La bambola entra in contatto con la propria vittima attraverso un mezzo che non ricordo, forse il telefono o il computer. Persone che ritrovano la bambola, in qualche modo tutti nello stesso momento (a meno che non sia un’abile costruzione dell’intreccio, volutamente ingarbugliato per farci credere ci siano più bambole, che però poi alla fine si rivelano essere una sola, la contemporaneità apparente una sequenza in fugato di istanti sovrapposti): un gruppetto di amici in campeggio; una donna sola con figli, ricca artista di successo (il suo amante, si scoprirà, è il principale adoratore della bambola; in una scena in cui lei è spaventata dall’oggetto per via di una qualche serie di eventi circostanziali, cerca di gettarlo via dietro una staccionata dove noi osservatori siamo nascosti; già, l’amente di lei, così sensibile, barba cinerina, era quello che per primo aveva raccolto la bambola).
I ragazzi in campeggio sono proprio dietro la staccionata, una serie di tozzi pali – e una siepe, e stanno facendo delle specie di ricerche, per trovare non so cosa. Tra loro c’è un ragazzo che sarà il primo ad essere posseduto dalla bambola. La possessione si manifesta mentre fa sesso con una sua amica. Il corpo di lei è una geografia biblica impregnata di umori: il clitoride una grande spirale babelica su cui il posseduto passa la sua lingua, la vagina un oltremodo pacchiano e insensato plastico del Tigri e dell’Eufrate scavato da dei bambini sul bagnasciuga, il corpo una lunga depressione fangosa e sudata. Quasi ci si dimentica che ci sia una donna in mezzo a quel gratuito guazzabuglio; poi lui inizia a penetrarla, e proprio allo spegnersi della luce lei vede in fosforescenza il demone e si mette a gridare, staccandosi da lui.
Un demone fosforescente che si muove con fare clownesco, nudo e irto di peli crespi, ispidi, grigi, gli occhi gialli o grigio lunare, trapananti. Nella tenebra, sembra quasi un fosfene, diresti che da un momento all’altro possa svanire nel nulla. Lei accende la luce, ed ecco i contorni l’uomo tornare del tutto normali. Vanno in un’altra stanza affatto anonima, ma ora, cioè proprio ora nel momento in cui ora sto scrivendo la stanza mi si impone come la sede, il cuore stesso di questo terrore innominabile e insieme dozzinale.
Nella stanza (uno stanzino da letto degli ospiti con vecchi oggetti di chissà quale adolescenza, scoiattoli impagliati e biografie di musicisti, una collezione di campanelli, moquette verde con chiazze nere di bruciature) lei lo vede di nuovo trasformato guardandolo nel riflesso di un grande specchio a muro, e a quel punto anche lui si vede ossia vede il demone della bambola. Se temi il demone sia entrato in te, devi controllare il tuo riflesso in tutte le superfici riflettenti della casa, in una e solo una delle quali si è certamente annidato.
Lui si vede e si spaventa, poi fa delle facce buffe che per un attimo fanno ridere la ragazza; poi lui cade dentro un armadio a muro e inizia ad avere delle convulsioni: sotto la tuta che indossa gli si stanno formando delle enormi ali da demone.
Corre nel giardino inseguito da lei e forse da familiari spuntati da chissà dove, gridando il “Che cosa mi sta succedendo?” di prammatica, che nella realtà forse nessuno griderebbe mai in una situazione del genere, ma dato che appunto non si tratta della realtà ma di film e romanzi, tocca dirlo, quindi “Che cosa mi sta succedendo? Che cosa mi sta succedendo?” finché le ali gonfiandosi e bislungandosi come rigidi teloni di un mostro di capodanno cinese non si aprono lacerandogli la maglia, e lui viene rapito da sé medesimo in un volo che lo porta a una orribile scorticazione aerea, le carni marcescendo rapidamente nell’azzurro. È forse a quel punto che la donna reale getta la bambola, dove i ragazzini reali la ritroveranno.
Anch’io ho eseguito il gesto che mette il possedendo in irrimediabile contatto con la bambola, ma non ricordo quale gesto sia. Fatto sta che so che lei mi troverà.
Sto scrivendo qualcosa su un post-it ma la penna non funziona, premo con la punta per almeno lasciare il solco di quello che ho scritto, forse è la soluzione, il modo per sfuggire a tutto questo… poi sento la voce di mia moglie attraverso il computer, circondata da folletti perlimplini. Sento solo che dice Non mi piace questo posto, e nel suo tono di voce è implicita una qualche accusa verso di me.
È in quel momento che il demone, attraverso un moto che la visione profetica manifestatasi all’inizio del sogno in forma di trailer (e che altro è il trailer se non la più umile scoria della visione profetica?), entra in contatto con me: le interferenze perlimpline che offuscavano le parole di mia moglie coagulano ora in un linguaggio che si dipana, la voce del demone che con ingannevolmente qualunquista gentilezza mi chiede, “Un cioccolatino, prima di andare a dormire?”
***
F. p. 11.
Mentre svolge generiche faccende casalinghe, una donna US riceve la visita di Lapin.
“Agente Delbert Cooper” dice un ragazzo con sindrome di Down alla sua fidanzatina con sindrome di Down.
Da una casa esce Lapin con la maschera messa al contrario: sembra più un leone o un licantropo, e non si capisce se la sua furia è semplicemente dovuta alla maschera o se è in realtà una creatura completamente diversa. Ha una corporatura più grossa e tozza rispetto al solito Lapin, e esce dalla casa notturna chiedendoci di non entrare.
“Grazie agente Delbert Cooper”, dice il ragazzo down prima di ricevere a propria volta la visita di “Lapin” e cominciare a urlare. Di fronte alla fidanzatina terrorizzata, si tira la pelle della faccia fino a sfilacciarla e strapparsela dal cranio: dal ragazzo così scorticato scaturisce per metamorfosi biantropica da vecchio film dell’orrore un altro Lapin mezzo sorridente che guarda la ragazzina down e fa spallucce come a dire, Non ti vado bene?
Mi sveglio in camera mia. Mi metto a pulire il pavimento con una scopa di paglia. Ricordo quando ho comprato quella scopa, e nello stesso tempo so di non aver mai avuto una scopa di paglia. Il giallo dei suoi fili e l’arancione e il verde dei cordini che li tengono insieme sono l’unico colore nel grigio della penombra. Sotto il calorifero, tra il pavimento e le pareti della stanza corre un distacco di un paio di centimetri, da cui indovino il piano inferiore e ancora più sotto le profondità del palazzo in cui vivo, le sue tubature e i suoi ingranaggi, giù fino al fango rovente del centro della Terra.
Adra è in piedi, appoggiato contro il tavolo. La donna che è con lui si accoccola a terra e comincia ad aiutarmi nelle pulizie, per così dire, ma in realtà non fa altro che spostare da un punto all’altro le carte disseminate sul pavimento: non è di molto aiuto.
Poi c’è qualcosa di nuovo, una biglia forse, un oggetto non mio o appartenente alla più remota e ormai aliena infanzia.
– C’è qualcun altro in casa?
Adra e la donna si spostano, in silenzio, e cominciano a sbiadire come in una dissolvenza incrociata. Alle spalle di Adra, davanti all’ingresso, c’è una bambina con una piccola bicicletta o un monopattino.
– Cosa sta succedendo?
Esco dalla stanza.
– La vedete anche voi?
Sbiadiscono e sbiadiscono, camminando, e dopo che li ho raggiunti in sala sono del tutto spariti. Sulla parete nord ora c’è un nuovo ingresso, e ci sono due donne cinesi. Attraverso il nuovo ingresso arrivo in una cucina con i mobili viola, luminosissima. Le due donne cinesi hanno l’aria indaffarata, vanno e vengono dal loro appartamento al mio.
È una festa del palazzo, o forse del quartiere. Capisco di essere in un sogno, ma reprimo l’orrore, è un sogno importante, che va fatto fino in fondo. Chiedo, sempre più di buonumore, chi sono tutte queste persone: oltre alle donne cinesi e alla bambina (la mia bambina?) ci sono altre persone indaffarate tra il tavolo e i fornelli. Tutti con scherzosa urgenza mi fanno cenno di tacere. Sono sempre più divertito e guardo le cose intorno a me solidificare e ispessire, sempre più indubitabili. Forse dopotutto non è un sogno (e quindi non è nemmeno più importante?).
Una signora inglese, forse Elsa Morante, [Nota: la critica lapiniana ha ben presente la profonda insofferenza che Morante ha sempre manifestato nei confronti di Lapin (gli aneddoti in merito potrebbero riempire almeno una decina di pagine), ed è altrettanto noto l’irresistibile impulso di Lapin a cercare di entrare in contatto, anche coi mezzi più puerili, con chi era meno interessato a lui; non possiamo fare a meno di notare anche noi la persistenza di certe figure femminili e in particolare della bambina: non sappiamo però che significato dare a queste costanti] mi indica, al di là dei tetti bianchi e abbandonati, il mare scuro e immobile, quasi verticale.
– È a pagamento.
Me lo dice sorridendo.
– È bellissimo ma a pagamento.
Poi bisbigliando e complotticchiando furbetta [Nota: lo spettro di Morante si sta mordendo le nocche a sangue]:
– Da noi in Inghilterra, invece…
Sto per risponderle, “Ma anche te ma chi vuoi che ci vada al mare in Inghilterra”, ma la città mi strappa alla conversazione. Esco e dalla parte dell’ingresso nord vedo alberi e case gialle, bianche, grigie, irregolari, e una torretta proprio davanti all’ingresso, poco più alta di dove sono io, ottagonale. Ci si sale per una corta spirale di gradini che le salgono intorno, e da una bassa ringhiera decorata con donne liberty.
– Che bella, ed è mia, è nella mia casa.
Vorrei salirci.
Mi portano fuori, nel grande giardino sul retro, ma se provo a parlare a qualcuno tutti mi fanno urbanamente cenno di tacere. È con me un ragazzo alto e magro, forse lo spettro gentile di ***? Gli chiedo, “Puoi dirmi che succede? sono completamente tranquillo, guarda”.
Ha degli occhi bellissimi, tra il verde e il grigio scuro. *** li aveva diversi, uno marrone e uno verde.
“Stiamo tutti quanti in silenzio,” mi spiega dopo un po’ il ragazzo che mi accompagna, “oggi vogliamo stare insieme senza parlare, tutto qua”.
L’idea mi piace, sorrido e tutti cominciamo a ballare veloci giravolte in coppia. Il ragazzo mi tiene i fianchi e io tenendomi alle sue braccia quasi sotto le ascelle mi sporgo all’indietro, e così balliamo in tondo, roteando veloci, e così fanno tutti gli altri. Quando viene il turno del ragazzo per sporgersi, invece che per i fianchi io lo prendo per le mani, e con le sue lunghe braccia di viaggiatore lui si ritrova quasi a sfiorare il terreno con la schiena.
– Anche l’altra volta hai fatto così!
Ride. Poi nel prato cominciano dalle profondità del cielo cominciano a piovere vecchie automobili, bulloni, tubi e ingranaggi, sollevando all’impatto ovattate esplosioni di terra. Grido, mentre tutti si allontanano.
– Siete miei amici! Siete miei amici!
Sono felicissimo, in pace. Si può vivere anche sotto una tempesta di rottami?
Ma già il giardino sbiadisce, e sento i miei lamenti, la mia voce che mi chiama:
– In pace…

[continua il 9 ottobre]

 La bambola regina - Angelo Angera
La bambola regina - Angelo Angera Monte Torre, sotto la pioggia, 24 o 25 agosto - Marino Magliani
Monte Torre, sotto la pioggia, 24 o 25 agosto - Marino Magliani Cene al veleno - Redazione
Cene al veleno - Redazione La GIPSI/ 3 - Alberto Volpi
La GIPSI/ 3 - Alberto Volpi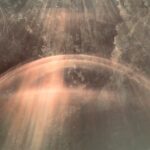 Presiden arsitek/ 42
Presiden arsitek/ 42 Serenata per una costellazione invisibile
Serenata per una costellazione invisibile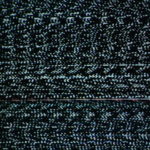 Presiden arsitek/ 21
Presiden arsitek/ 21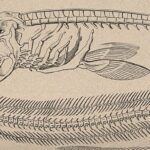 Presiden arsitek/ 58
Presiden arsitek/ 58





















