
Pablo d’Ors l’ho scoperto grazie al consiglio di lettura di un amico scrittore, e non poteva essere altrimenti. Proprio così: con l’estinguersi delle librerie indipendenti – nel 2014 hanno chiuso tutte e tre quelle che frequentavo sulla linea del Brennero – e in assenza di una pubblicistica abbastanza autorevole da opporsi allo smarrimento del senso dello stile, il passaparola è diventato lo strumento più sicuro, il solo ormai cui potersi davvero affidare nell’esplorazione di nuovi mondi poetici. Tanto più se a darti la dritta è un amico che scrive e che stimi: allora non c’è moda che tenga, nessun rischio di compromissione con la propaganda editoriale, solo l’autentica, accorata esortazione a confrontarti anche tu con un fratello comune.
È questo infatti che ho trovato in d’Ors: una specie di fratello maggiore. Quando mi fu consigliato, in italiano erano usciti due soli suoi titoli, Le avventure dello stampatore Zollinger per Quodlibet nel 2010 e Il debutto per una piccola casa editrice cagliaritana, Aìsara, nel 2012. Strano che mi fosse sfuggita la prima pubblicazione nella collana «Compagnia Extra», di solito ne seguo le proposte, ma insomma, anche i libri buoni ormai sono troppi, uno non può mica avanzare nel mare magnum con una rete a strascico appesa agli slip. Iniziai dal Debutto, il libro d’esordio di d’Ors, uscito in castigliano nel 2000, e a metà del primo racconto facevo salti di gioia.
Ogni racconto del Debutto, tradotto molto bene da Ileana M. Pop, è dedicato a uno o più autori che d’Ors evidentemente considera importanti per la sua formazione, ed è condotto sul doppio binario dell’omaggio parodico e del superamento del modello. Il primo racconto, L’amante slovacca, è dedicato a Milan Kundera, che ho amato a lungo anch’io, e a Günter Grass; assieme a quello dedicato a Ferdinando Pessoa (Il monaco secolare), sono gli unici due racconti in cui i dedicatari sono anche protagonisti. Kundera è invitato a un convegno di letteratura in un convento domenicano alla periferia di Bratislava: ha il compiacimento dongiovannesco, la riflessività e l’insicurezza dei suoi personaggi maschili più tipici, e la prosa di d’Ors lo accompagna verso lo scacco intellettuale ed erotico con una mimesi stilistica priva di cedimenti che non è mera imitazione, ma vero controcanto beffardo. La scena in cui lo sciame di nonnine intente a lusingarlo è improvvisamente distratto dalla fragorosa entrata in scena di Grass con il tamburo di latta in grembo è solo uno dei picchi comici della narrazione. Del resto anche a Grass toccherà la sua dose di umiliazione. Niente del genere nel Monaco secolare, dove l’ironia si stempera in un calco più delicato della sensibilità saturnina dell’impiegato–poeta di Lisbona. Gli altri dedicatari, vittime care di un trattamento intertestuale sempre differente, sono Thomas Bernhard (Il nipote di Bernhard, dove il sorvegliante di un laboratorio scientifico incolpa il suo autore prediletto dei propri mali psicofisici), Dante e Boccaccio (L’inesistenza, dove la giovane dottoranda Beatriz va rimpicciolendo durante un soggiorno di ricerca a Firenze sulla Commedia, assistita inutilmente da un collega decameronista di nome Pierpaolo), J. W. Goethe (Lo schiavo di Goethe, un’impietoso ritratto di Eckermann e, con lui, di ogni servo della grandezza altrui), Italo Calvino (La logica dei piedi, un antidoto iper-corporale alla razionalità astratta di tutti gli Agilulfo che ci circondano) e Charles Dickens (Il debutto, dove d’Ors si prende infine gioco di se stesso all’epoca in cui mise in scena, per davvero, il Canto di Natale). C’è modo e modo di ripercorrere le orme dei maestri, e di solito si tratta di imbarazzanti brutte copie o nel migliore dei casi di esperimenti epigonali, che uno comunque preferisce tenere per sé. D’Ors invece è riuscito, mi sembra, ad elevarsi al di sopra della propria condizione di discepolo proprio mentre perfezionava, com’è inscritto nella parola, la propria disciplina; e ha così scritto un libro d’esordio fedele e libero ad un tempo, forse non sempre all’altezza della propria ambizione, ma che dichiara a testa alta, senza prendersi troppo sul serio, la famiglia letteraria del suo autore.
Le avventure dello stampatore Zollinger, invece, è già un libro compiutamente autonomo, maturo, e ha la grazia costante di un gesto ispirato. Le vicende picaresche ma non troppo, spesso raffrenate dal gusto della sospensione, di questo giovane pseudo-tedesco in un’Austria ancora indefinitamente asburgica – nomi e toponimi sono fittizi – mi hanno cullato attraverso un mondo che riconoscevo a ogni passo, nonostante vi entrassi per la prima volta: Zollinger che s’innamora disperatamente delle poche parole della telefonista che ogni mattina lo chiama al suo compito di ferroviere in un casotto al centro dell’impero, Zollinger che si arruola nell’esercito, diventa campione di resistenza alcolica e impara l’amicizia, Zollinger che diserta e si rifugia nel bosco dove imparerà ad ascoltare la voce degli alberi (e ad abbracciarli!), Zollinger che rientra nel consorzio civile fino a ritrovare le fila del proprio destino: da dove usciva mai questo alato prosatore spagnolo, così centro-europeo, così solido nello stile e delicato nel tradurre in racconto le sempiterne passioni dell’uomo – così capace di toccare le mie corde più intime?
Quello che non diceva il risvolto del Debutto, lo rivelava quello dello Zollinger, e viceversa: figlio d’arte, formazione cosmopolita, studi giuridici e teologici, questo allievo zelante e dispettoso della miglior letteratura europea era sacerdote dal 1991. Sacerdote? Mi venne subito in mente Rabelais, ma faticavo, lo confesso, a immaginare come ai giorni nostri si potesse conciliare il disincanto del romanziere con la pratica confessionale. Confondevo, in effetti, la fede con il dogma. Tuttavia il caso, pur convincente su tutta la linea, restava perlomeno desueto. Bisognava approfondire. Così ne discussi con i miei sodali del Seminario Internazionale sul Romanzo e decidemmo di invitare Pablo d’Ors a Trento.
Capii poco dell’uomo durante lo scambio di e-mail che partì con l’invito in Trentino e si concluse mezz’anno dopo con l’invio delle indicazioni per arrivare da Malpensa a Verona, dove andai a prendere d’Ors in macchina un lunedì sera d’inizio marzo. Nei giorni precedenti, tuttavia, avevo letto e molto sottolineato il suo terzo libro tradotto in italiano – il quale, più che a Rabelais, mi aveva fatto pensare, con le giuste proporzioni, a Montaigne o Pascal, se non addirittura ad Agostino. Ma perché bisogna ogni volta temere di chiamare in causa i grandi del passato quando si vuol rendere semplicemente l’impronta ispiratrice di un contemporaneo? Cos’è quest’attitudine spocchiosa all’understatement? Come se in noi non covasse ancora, al lumicino, la fiamma nostalgica della grandezza… Fra l’altro, nel frattempo, d’Ors era stato nominato da Papa Francesco «consultore» nel Pontificio Consiglio della Cultura: chi diavolo stavo per incontrare?
Biografia del silenzio, apparso nell’ottobre 2014 per Vita e Pensiero, è un saggio nel senso più autoriale, classico e antiaccademico del termine: padre d’Ors vi racconta ed illustra il proprio percorso verso la meditazione con un’apertura spirituale che accoglie apporti secolari e orientali senza mai divenire eclettismo – e senza mai rinunciare allo sguardo esistenziale del romanziere: «L’esaltazione dell’amore romantico nella nostra società ha causato e continua a causare insondabili abissi di sventura. L’attuale mitizzazione della coppia è una deleteria stupidaggine. Naturalmente credo nella possibilità dell’amore di coppia, ma sono convinto che richiede una straordinaria e infrequente maturità. Nessun partner ci può dare mai la sicurezza totale che cerchiamo; non può né deve darla. L’essere amato non è lì perché uno non si perda, ma per perdersi insieme; per vivere in compagnia l’avventura liberatoria della perdizione».
Poco prima che conoscessi d’Ors di persona, questo libriccino di novanta pagine, divenuto un best seller in Spagna senza che in precedenza la critica e il pubblico spagnoli si fossero troppo degnati di apprezzare il romanziere d’Ors, mi aveva portato, oltre che a una salutare disamina interiore, ad alcune osservazioni: a) il bisogno di spiritualità che c’è in giro se ne frega dell’identità di un autore e conferma la regola che il successo si basa in gran parte sulla coincidenza spuria, quando non sul malinteso; b) essere al tempo stesso romanziere e sacerdote ti può portare, in traduzione italiana, a un bizzarro sdoppiamento editoriale: mentre i tuoi scritti più religiosi finiscono nei cataloghi cattolici, gli altri restano agli editori di letteratura, rendendo meno agevole a un lettore comune seguire le tue pubblicazioni; c) pur nello sdoppiamento, è pur sempre una bella fortuna, su tre libri tradotti, aver avuto tre bravi traduttori: dopo Ileana M. Pop, Marco Straquadaini per Quodlibet e Danilo Manera per Vita e Pensiero avevano fatto davvero un buon lavoro.
Tutto questo fu confermato dal libro che ricevetti in anteprima il giorno stesso in cui d’Ors, dopo il tramonto, sarebbe salito sulla mia Golf: grazie alla premura di Ermanno Cavazzoni, Quodlibet mi aveva inviato L’amico del deserto: romanzo, ben tradotto da Marino Magliani, apparso in Spagna nel 2009 e primo capitolo di una «Trilogia del silenzio» che comprende anche, oltre alla Biografia del silenzio, una specie di romanzo biografico dal titolo L’oblio di sé, che ripercorre la vita del monaco ed eremita Charles De Foucauld e verrà pubblicato in Italia, guarda un po’, da Vita e Pensiero. (Mentre la piccola Aìsara, che aveva acquisito i diritti di tutte le opere pubblicate da d’Ors fino a quel momento, ha chiuso alla fine del 2012: peccato.)
L’amico del deserto è la storia del quarantenne Pavel, che abita nella provincia ceca e un giorno scopre che a Brno è attiva un’associazione, gli «Amici del deserto», che visita e studia i deserti del mondo. Li contatta, attratto dall’idea di conoscere anche lui, «naturalmente», il deserto, e anche se la fatalità di questa attrazione è data forse un po’ troppo a priori, d’Ors evita di farne un richiamo a senso unico: mosso forse più dalla matrice ironicamente kunderiana del suo personaggio che da un’idea romanzesca e anti-romantica, girardiana, mimetica del desiderio, l’autore fa sì che il progressivo, non facile avvicinamento di Pavel ai membri dell’associazione e alla loro indomabile passione sia segnato dalle inattese mediazioni di alcune “amiche del deserto” particolarmente insinuanti. Perché parlo tanto dell’autore e della sua intenzione? Perché in questo libro si ha la sensazione che d’Ors abbia voluto unire le sue due anime, quella del romanziere e quella del cercatore spirituale, in una forma narrativa originale, che nessun altro avrebbe potuto perseguire. Lasciatosi alle spalle la tentazione erotica e il sospetto di avere a che fare con una specie di setta, ma non la sensazione di percorrere un cammino costellato di misteriose corrispondenze – il che rende il racconto un tantino allegorico –, Pavel vive finalmente un frangente iniziatico: la tempesta di sabbia che lo coglie nel Sahara, e dalla quale è tratto in salvo da un bellissimo adolescente arabo, è il punto di svolta del racconto – e il capitolo cui giunsi poco prima di incontrare d’Ors.
Parlammo anche di questo in autostrada fra Verona e Trento. D’Ors era stanco, reduce da un turno di ventiquattro ore all’ospedale madrileno dove da qualche anno assiste malati e moribondi, ma abbastanza sveglio per parlarmi di sé e del suo amore per la letteratura: fu solo l’inizio di un dialogo durato tre giorni che, se in privato mi ha fatto trovare, come ho detto, una specie di fratello maggiore, in cui non riuscivo a distinguere l’alleato estetico dall’amico con cui confidarsi e scherzare, pubblicamente si è tradotto in una specie di conferenza in cui, benché si parlasse di poetica del romanzo, non era possibile distinguere lo scrittore dal religioso.
«Il romanzo è nostalgia dell’unità, la stessa unità cui aspiriamo in quanto esseri umani. Il romanziere», ha affermato d’Ors davanti a un pubblico letteralmente assorto, «si muove nella frattura, nelle tenebre in cui viviamo e, con attitudine sapienziale, si dispone ad accogliere la realtà, dando voce alla nostra aspirazione di ritrovare l’unità perduta, la luce». Non è un caso che le tre parole che d’Ors considera fondamentali per la pratica artistica, la «fonte», la «sete» e la «notte», accomunino l’esperienza estetica a quella estatica: «Tutti cerchiamo una fonte, la si chiami Dio o pienezza, e anche ogni artista cerca sempre, in qualche modo, di avvicinarsi a questa fonte. E il nostro cammino attraverso le tenebre ci può portare alla fonte soltanto se abbiamo sete: più sete abbiamo, più ci avvicineremo alla fonte». Il romanziere, dal canto suo – come gli amati Hesse e Kafka che d’Ors ha affiancato a Kundera nella sua personale trinità formativa –, persegue questo obiettivo con gli strumenti che gli sono propri, ossia «l’immaginazione e la fantasia», e secondo d’Ors – come dargli torto? – ciò che il poeta può dirci sulla vita umana non è meno importante di quello che ci può dire uno scienziato. Richiamandosi a Thomas Mann, ha poi sostenuto che l’«ammirazione» è il più nobile e fecondo fra i sentimenti che l’arte può suscitare, poiché è la nostra ammirazione di lettori che ci può spingere a proseguire nel solco di quelli che eleggiamo nostri maestri. È così che, attraverso l’imitazione, ci facciamo discepoli in un modo non troppo diverso da chi persegue una ricerca interiore attraverso la religiosità. Del resto, come sostiene d’Ors, «un buon romanzo è tale solo se chi l’ha scritto ha una vita interiore», la stessa che coltiva chi vive con passione e autenticità il proprio cammino spirituale.
Gli ultimi capitoli de L’amico del deserto, che ho letto in quei giorni, sono una graduale iniziazione al nulla e, al tempo stesso, a una sorta di pienezza creaturale. Dopo la svolta della tempesta di sabbia e l’enigmatico dono amoroso di una delle sorelle della sua giovane guida, Pavel deciderà di intraprendere un viaggio da solo nel Sahara algerino, si farà guida di se stesso, soggiornerà ai margini del deserto e qui il suo apprendistato sapienziale, a suon di coincidenze fra opposti, sfocerà in vuoto interiore e pura rappresentazione: delle linee mutevoli delle dune prima, specchio del nulla che va facendosi strada dentro di lui, poi di una parola sempre più dilatata, rarefatta e priva di finalità: quella che il narratore chiama «scrittura scomposta» e che lo porterà ad affermare: «Voglio essere come il deserto. Prima, gli uomini potevano cercare di capirmi; adesso no. Sono più misterioso. Sono più simile a Dio, se esiste…».
Non finisce qui, ma io qui mi fermo. Il punto di convergenza di un percorso poetico con uno spirituale è in un’aspirazione di condivisione che ogni lettore, o cercatore, recepisce a proprio modo. C’è una polisemia anche nelle faccende dello spirito, per così dire, una plurivocità naturale che nessuno, da solo, può intonare senza dissolverla. Bisognerebbe chiedere a Pablo d’Ors come facciano, lui e i suoi «Amigos del Desierto», quelli veri, che da un paio d’anni approfondiscono e promuovono la pratica della meditazione, a spiegare ogni volta, a tutti quelli che si rivolgono a loro, che ognuno in fondo è in balia di se stesso e perciò, come si legge nella Biografia del silenzio, «credere di poter essere d’aiuto è quasi sempre una presunzione». Anche quando si scrive, certo, per cui un finale di romanzo che ammicca al lettore corre sempre il rischio di mancare il bersaglio.
Un po’ meno, forse, quando si legge: amici di Zibaldoni, passo parola.

 Una macchina per raccontare tutti i futuri. Macedonio Fernández nel XXI secolo - Miguel Gallego Roca
Una macchina per raccontare tutti i futuri. Macedonio Fernández nel XXI secolo - Miguel Gallego Roca A proposito di Zibaldoni - Claudio Morandini
A proposito di Zibaldoni - Claudio Morandini È arrivato Godot! - Marion Brasch
È arrivato Godot! - Marion Brasch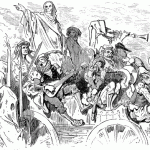 Don Chisciotte disoccupato
Don Chisciotte disoccupato La necessità cieca della tragedia
La necessità cieca della tragedia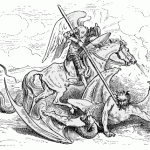 Hermann Broch e il romanzo polistorico
Hermann Broch e il romanzo polistorico Immàginati un canto
Immàginati un canto





















