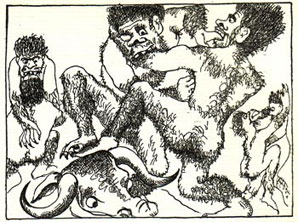
Si dice che non si può più parlare di popoli, e nemmeno di genti, ma solo di gente. La gente non appartiene a nessun popolo, la gente condivide solo l’estraneità. Mentre i popoli fantasticano, la gente pensa. E si dice anche che non si può più fantasticare, cioè cercare spiegazioni con la fantasia, ma solo riflettere, calcolare, macchinare, come il pensatore di Rodin. In quel mostruoso accartocciarsi delle rughe, in quella postura vile e scomposta, c’è tutta la deriva logica di una civiltà impoverita e impaurita, del tutto incapace di utilizzare la persistenza e la forza del mistero.
Per fantasticare è necessario trovare la giusta posizione, la postura adatta.
Tutti i popoli antichi hanno praticato per millenni la coltivazione sistematica della coscienza, producendo molte scienze tradizionali di sviluppo mentale, le cui origini si perdono nel primo albeggiare della consapevolezza umana. Eredi delle tradizioni sciamaniche, queste scienze vertevano su un diverso modo di disporsi verso le cause che agiscono sull’uomo, provando ad interagire con esse, piuttosto che allontanarle e poi vanamente cercare di controllarle.
Essenzialmente queste scienze consistevano nell’assunzione di posture fisiche e mentali, attraverso le quali accettare transitorietà e impermanenza come la nostra vera natura. In tali posizioni, credevano, esistere e fantasticare non erano più momenti separati. Unica legge che si riconosceva alla natura era l’impermanenza, la transitorietà dei fenomeni e la loro insostanzialità, ma l’acquisire l’impermanenza come legge non aveva nessuna pretesa di verità assoluta, era coscientemente inteso solo come espediente per aderire agli avvenimenti. Sebbene per noi sia difficile pensarlo, in queste scienze, ciò che viene detto ‘naturale’ o ‘originario’, non ha a che fare con un ritorno allo stato primigenio, ma l’accenno alla primordialità serve soltanto a sviluppare un’abilità, un potere che, con tutta evidenza, ci appartiene da sempre. Dato che non poteva trattarsi di uno stato mentale al quale tendere, da desiderare e al quale giungere dopo un apprendistato, il che avrebbe reiterato la separazione, allora ci si allenava a considerarlo come lo stato naturale, che in quanto tale non poteva essere cercato né desiderato.
Uno degli aspetti più evidenti del potere che si andava sviluppando, era la capacità di abbracciare simultaneamente punti di vista differenti, anche opposti, con il riconoscimento che gli opposti non sono contrari, ma polari o interdipendenti, e che vi è qualcosa che può venire alla luce da una consapevolezza più piena di quella tracciata dalla linearità logica. In termini moderni, potremmo dire che il labirinto del sistema nervoso può integrare più variabili che non il procedimento indagatore dell’attenzione conscia.
Quindi il fine degli esercizi era quello di liberare la mente dai limiti arbitrari che le sono imposti dalla fissazione abituale sui propri contenuti. Liberato in tal modo, dicevano, l’individuo cosciente, anziché essere prigioniero della creazione, diviene un ‘collaboratore’ della creazione. E’ un procedimento che a volte viene chiamato ‘sedere dimenticando’ ‘siedo e dimentico’, e che noi potremmo finalmente chiamare ‘fantasticare’, o anche meglio ‘divagare’, nel senso di ‘vagare fra le apparizioni’, ma anche di ‘cercare con la fantasia una spiegazione’, al posto del mal solubile ‘meditare’.
Sentiamo la descrizione di questo fantasticare o divagare in un antico testo: “Dobbiamo imparare a prendere posto nella vasta distesa del cielo. Dopo possiamo vedere le affascinanti nuvole, tempestose o brillanti, scorrere in questo cielo bellissimo e sconfinato” (Wen Tzu, I sec. a. C.).
E ancora in un altro: “La capacità della mente è ampia e vasta, come l’ampio cielo. Non startene a sedere con la mente fissa sulla vacuità. Se lo fai cadrai in un neutro genere di vuoto. La vacuità include il sole, la luna, le stelle, e i pianeti, la grande terra, montagne e fiumi, tutti gli alberi e le erbe, uomini cattivi e uomini buoni, cose cattive e cose buone, paradiso e inferno; tutti sono nel mezzo della vacuità. Anche la vacuità della natura umana è come questo” (Tan ching, VII sec. d. C.).
E un altro: “La saggezza degli uomini completi consiste nel far fluttuare le loro menti nello spazio infinito” (Tai i chih hua tsung chih, XVIII sec.) .
Il dispiegarsi di queste citazioni nel tempo, e la loro provenienza cinese, dimostrano soltanto che in Cina l’attenzione per tali scienze non è mai venuta meno, ha preso alloggio in innumerevoli scritture e ne ha preservato la laicità. Ricca è pure la tradizione Sufi, tuttora vivente quella degli indiani messicani, per esempio. Ma dappertutto i cardini fondamentali dell’insegnamento sono gli stessi, simili le tecniche e uguali le posture, a dimostrazione di un tentativo comune, sebbene lontano nel tempo e nello spazio.
Nella divagazione degli antichi popoli, non è la realtà impermanente la fonte continua delle nostre sofferenze, ma la concezione illusoria che inafferrabilità, transitorietà, evanescenza siano penose. Non è l’impermanenza la causa della sofferenza, ma il nostro modo di concepirla come elemento negativo, ed è proprio l’insicurezza a scatenare la nostra reazione ostile. L’impermanenza non è altro che il modo normale di funzionare della natura, è il vagare naturale del pensiero.
Ciò è evidentemente in contrasto con l’idea convenzionale del fantasticare, nella quale l’evasione frivola e parziale già presuppone un duro ritorno alla galera. Non un pensiero sapientemente utilizzato per abbandonare l’illusione di essere noi, separati da noi stessi e dal resto, bensì una pausa, più o meno legale, un gigante dai piedi fittili.
Il pensiero ha bisogno di afferrare, aggrapparsi, ottenere, e l’attaccamento all’idea di permanenza coincide con la volontà perversa di aggrapparsi alle cose, di avere sostegni stabili. Solo nell’autoaffermazione l’io si può nutrire dell’illusione della sua esistenza. Se per gli antichi popoli, e dal punto di vista pratico, alla radice della follia umana sta la paura della sofferenza e il desiderio di evitarla, la sofferenza stessa ha radici nell’illusione di permanenza, mentre nell’impermanenza non accettiamo alcun punto di riferimento definitivo e ci affidiamo senza remore alla nostra vera natura, che è la transitorietà. Lasciar cadere, abbandonare questo attaccamento è rendersi indipendenti, è andare in giro senza bisogno d’appoggi. Un uomo capace di tanto viene definito negli antichi testi semplicemente come ‘un uomo vero’.
Poi tutto questo è stato azzerato, e fantasticare è diventato prerogativa della triste consapevolezza personale, fatta di giustapposizioni cadenzate e ripiegamenti stantii. Ma la ricostruzione ‘archeologica’ di queste scienze è tuttora possibile, partendo da quanto di ‘tecnico’ si sono impadronite alcune tradizioni e dottrine, religiose e no, scritte e non, scremandolo e facendo continuamente la tara nella loro verifica pratica, ed è quello che ci rimane da fare, se vogliamo riunirci al mondo che fantastica.

 Noi siamo al passo con i tempi - Paolo Morelli
Noi siamo al passo con i tempi - Paolo Morelli Ritorti e Sarchioni - Paolo Morelli
Ritorti e Sarchioni - Paolo Morelli Incontro con Gianni Celati - Gianluca Virgilio
Incontro con Gianni Celati - Gianluca Virgilio Eccolo là il dottor Casino - Paolo Morelli
Eccolo là il dottor Casino - Paolo Morelli L’arte della viva voce
L’arte della viva voce Er Ciuanghezzú
Er Ciuanghezzú Gli italiani non sono fascisti, gli italiani sono vigliacchi
Gli italiani non sono fascisti, gli italiani sono vigliacchi Sono rimasto me stesso
Sono rimasto me stesso





















