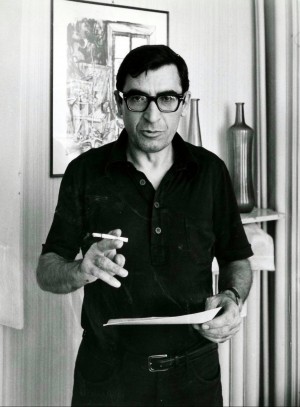
Giuseppe D’Agata ha scritto diversi romanzi, tra i quali il più famoso è Il medico della mutua (1964) soprattutto grazie al grande successo della trasposizione cinematografica con Sordi protagonista; ben tre di essi sono di argomento resistenziale: La cornetta d’argento (1956, rivisto per l’edizione Bompiani 1973), L’esercito di Scipione (1960, ripubblicato dalla stessa casa editrice nel 1972), I ragazzi del coprifuoco (2005). Il primo romanzo, ambientato nella Bologna degli ultimi anni del secondo conflitto mondiale, racconta di tre ragazzi appassionati di jazz, che ascoltano e suonano i dischi della musica proibita dal fascismo nella cantina allestita da Mario, il protagonista. Tale l’interesse prevalente di un’opera piuttosto esangue nella trama e nei personaggi. La cantina è innanzitutto un luogo altro, che serve a sottrarsi all’orrore della guerra riassunto fin dalle prime pagine nei partigiani impiccati in piazza, una “camera dei giochi”, un “mondo completo”. A Mario, studente di musica attratto dalla libera interpretazione del jazz e figlio di musicista, un partigiano incontrato per caso dice: “Musica? Anche a me piace. Verdi, Puccini, ma chi può ascoltarla più? Adesso ce n’è altra in giro”.
Certo questa musica, messa al bando dal Regime, s’identifica con il mito degi Stati Uniti, potenza militare (“L’America arriverà a far fuori i fascisti. Gli impiccati suscitano pena, ma non risolvono nulla col farsi ammazzare a quel modo. L’America, Carlo, l’America li vendicherà.”) ed economica (“Sigarette, caramelle, qualche volta piccoli saggi di liquori, matite cioccolata […] Chesterfield. È un nome che suona bene, ricco. […] Sfido che vinceranno. Con queste vincerei anch’io”). Simboleggiata, causa la scarsa dimestichezza dei ragazzi con la lingua inglese, nelle “parole magiche di suoni del tutto insoliti e suggestivi” delle etichette rosse, nere della Parlophon e della Odeon. D’Agata, ottimo suonatore di batteria, rievoca qui con piacere i suoi amori giovanili: i brani Saint Louis Blues, Tiger Rag, Star Dust, West End Blues, gli autori Tommy Dorsey, Dodds, Lang, Singleton, Nichols, Hines, Teagarden. Su tutti Louis Armstrong, la cui grande foto campeggia nella cantina come nume tutelare, per altro descritto con un lessico che suona oggi non molto emancipato dagli stereotipi razziali (“Una guancia lucida, con enorme occhio bianco i capelli crespi; coi labbroni pallidi il negro imbocca una tromba.”), e il bianco Bix Beiderbecke, “nato per la musica”, “suonatore formidabile” di cornetta, alcolista “innocente” morto giovane e povero. A paragonarlo a Mario è la sedicenne Elisabetta (ribattezzatasi Bessie), molto più matura di lui, padrona dell’inglese, cantante di blues, che gli spiega come il jazz non sia musica indifferente da studiare, ma “storia e politica”, legata all’antifascismo, perché nero, americano e “perché è di gente sfruttata, di schiavi che vogliono la libertà.”).
Tra i due ragazzi scocca prevedibilmente l’amore e in modo ugualmente prevedibile lei morirà a causa della sua attività clandestina. Ciò trascina Mario al febbrile sogno nel quale immagina di giungere nella piazza degli impiccati piangendo e suonando la cornetta (“è come impugnare un’arma”) alla testa della folla risvegliata e pronta al combattimento: “La folla è oramai a venti, quindici metri. Con una nota lunga, vibrata, finisce la musica. Poi, dopo una pausa, urla si levano, un uragano, e la gente si mette a correre verso le forche. I militi, quelli che possono, scappano, senza sparare.”). Ripresa coscienza il giovane si trova in casa di un operaio che ha diretto lo sciopero riuscito e a cui aveva partecipato anche il padre resistente all’insaputa del figlio, prefigurazione dell’iniziazione personale e della vittoria collettiva contro i nazifascisti.
Il secondo romanzo, anch’esso ambientato in gran parte a Bologna negli anni della Resistenza, e parzialmente autobiografico per l’esperienza partigiana del giovane D’Agata, figlio di un tipografo molisano immigrato, appare più riuscito nella delineazione dei caratteri, attraverso una trama meglio strutturata, attente notazioni sul centro città e i quartieri periferici; soprattutto quel realismo convincente che farà dell’autore uno sceneggiatore di successo. Si tratta di un gruppo di soldati meridionali, reduci da uno scontro post 8 settembre contro i Tedeschi, che non potendo superare la linea del fronte e tornare così a casa, seguono l’unico bolognese del gruppetto che promette di sistemarli.
Il primo tema d’interesse scaturito probabilmente dalle osservazioni sulla coeva migrazione interna base del boom, sta proprio nel confronto tra i sette meridionali ed il contesto per loro nuovo in cui si inseriscono. Cesare, la guida verso il Bengodi (“L’Emilia è una regione ricca” anche in rapporto al Veneto appena attraversato), è portatore di un cumulo di stereotipi, secondo cui chi non capisce il suo italiano bolognesizzato è “un marocchino e dei più africani”, e tutti miranti a sottolineare la superiorità padana nella cultura (“I nostri contadini leggono, la sera. Non è gente che vive sotto la terra.”), nell’economia (“Da voi o artigiani o contadini. Non avete mica industria voi.”) dovuta al saper fare mentre “i meridionali hanno poca voglia di lavorare”, nella bellezza architettonica e nei costumi, specie quanto alle relazioni con le donne, non così sottomesse e con le quali è possibile amoreggiare. Proprio su questo il punto di vista sclerotizzato è dall’altra parte ben riflesso: “Tutte le donne qui facilmente erano delle puttane”; “i settentrionali sono tutti cornuti. Loro ci guardano poco a queste cose.”
D’Agata si premura comunque di distribuire bene e male con equanimità. L’aiuto fattivo del popolo di Riva di Reno e quello un po’ peloso della Chiesa con le sue benefattrici, lo sfruttamento della mano d’opera, in cambio di vitto e alloggio da parte dell’astuto proprietario della segheria nel periodo in cui arrivano copiosi i carichi del legname. Tra i meridionali ecco gente di cuore e sacrificio come i contadini Capellupo e Milleto, un paio pronti a sistemarsi con donne del luogo (uno regolarmente uno anche come pappone), infine Sgrizzi, acre, ribelle e scansafatiche, incline al furto e a mettere tutto in verità atrabiliare: “Caro fesso, tu quelli dell’alta Italia non li conosci. Sono tutti per loro, così sono. Ti danno qualcosa per farti sentire più pezzente di loro, e dietro parlano male e ti sfottono”. Tra tutti loro spicca Toto, il più giovane e orgoglioso, che cerca disperatamente la vera integrazione ma senza venir meno a se stesso; ci riuscirà nel modo canonico dei romanzi impegnati del dopo guerra, ovvero con la lenta e meditata adesione al socialismo, grazie a un vecchio operaio che gli farà da mentore, lo farà entrare in fabbrica e presumibilmente tra i Gap, nonché a un vero amore con una ragazza del popolo umile e costumata. Tutto quanto con un andamento psico-sociologico che supera però lo scontato esito pedagogico.
L’altra figura che emerge dal gruppo e incarna il secondo polo d’interesse del romanzo è il Maggiore siciliano e quarantenne leader degli sbandati. Spregiatore della “stupidità fascista”, aveva gridato il 25 luglio per le piazze “Viva l’esercito”, trovando nella volontà di resistenza ai Tedeschi del generale Pivato, sostenuto dalla decisione assembleare dei soldati, un motivo di speranza: “l’aria degli ultimi cinque o sei giorni era un’aria nuova ch’era penetrata nelle file del nostro esercito. La sconfitta inevitabile sembra interrompere la corrente di rinascita (“sospirava, sbigottito per la sua carriera improvvisamente spezzata proprio quando aveva cominciato a credere a una causa degna”); tuttavia la discesa verso sud con “l’esercito che gli era rimasto” gli restituisce fiducia. È uno tra gli altri, che chiama spontaneamente amici, ma sono proprio loro ad affidarsi alla sua abitudine di comando: “Non era possibile annullare la distanza che era fra essi e lui: poteva essersi attenuata, sì, ma tacitamente rimaneva, ed era accettata, naturale anzi che vi fosse, tanto non era più come quella di prima”; significative le parole di Capellupo: “Per me, siamo nelle vostre mani, signor Maggiore. Voi lo sapete meglio di noi quello che dobbiamo fare.”
Già qui si manifesta la personalità ambivalente del comandante, che alterna l’ostentata sicurezza sulla strada da intraprendere ai dubbi nascosti (“Era ancora Maggiore? Sì e no: difficile rispondere”), risolti dalla convinzione che ora finalmente i gradi saranno determinati dal merito personale. Ciò che di fatto avverrà durante la Resistenza. In effetti il Maggiore salva i compagni da un intercetto di due tedeschi, sbucando da dietro i cespugli, dove – circostanza che fa da controcanto all’eroismo – s’era appartato per i suoi bisogni, e freddando i nemici: “Capacità ne aveva: i giorni adatti per dimostrarlo erano proprio questi”.
Tale il momento epico del gruppo, continuamente ricordato e narrato una volta arrivati in salvo a Bologna e ricoverati da Cesare in segheria. La solidarietà e il cameratismo paiono rinfrescare e inverare lo spirito migliore (“in quei pochi giorni gli pareva di aver trovato la fierezza della nazionalità e il sentimento della patria”), ma nel Maggiore resta sempre qualche ombra di non detto, dei pensieri celati anche a se stesso, quali la scarsa voglia di tornare da sconfitto ed in abiti civili al paese da cui mancava da vent’anni, di sentirsi ormai vecchio e forse deriso. Così roso dai dubbi al momento della prova fallirà, mentre riaffiora la vecchia albagia del militare che non si fida della politica ed è insidiato dal comodo collocamento presso una donna della sua classe sociale con il marito prigioniero. Prima attende tutto l’autunno e l’inverno per “organizzare”, pur temendo che il suo gruppo possa sgretolarsi: “Aveva fatto bene ad aiutarli, altrimenti cosa sarebbe avvenuto di loro? Curioso che sotto sotto quasi gli dispiacesse di aver contribuito a trovare un lavoro per i suoi uomini… Lavorare voleva dire vita indipendente, vita borghese… Non c’erano più ordini da ricevere, ordini da dare. Poi, venuto a conoscenza dell’attivismo partigiano, si vuole inserire soprattutto per ambizione personale, come fosse quello “un prolungamento di quei giorni avventurosi” del post 8 settembre. Altro punto dirimente è il non voler sottostare ad altri: si decide all’attacchinaggio di manifestini con qualche schizzinosità (“Solo questa roba c’è?”) e dopo un’attenta quanto parziale riflessione: “Trovava faticosa quella lettura: parlava di problemi che erano lontani dai suoi. Operai, contadini, popolo, cui gli scritti di quei giornali si rivolgevano, erano per lui pressoché astrazioni. Poteva solo avvertire una coincidenza di interessi, di scopi immediati, con quelli suoi personali.” Lo stesso discorso, fatto ai suoi pochi uomini richiesti di continuare il rischio, è nobile quanto autocompiaciuto (“Nessuna cartolina vi richiama. Voi dovete solo scegliere, come vi sentite, come ho fatto io. […] È la guerriglia, che si deve fare senza divisa, uomo contro uomo.” Tuttavia non rinuncia mai all’idea di primeggiare, pensando e realizzando altri manifestini, tutti suoi, firmati con il nome di battaglia Scipione, e attaccati vicino alle case dei fascisti, dove si proclama che essi sono tenuti d’occhio da “Quelli dell’8 settembre”. Allorché Radio Londra non menziona la sua geniale impresa, ricade nell’apatia e nell’insicurezza: “Ho scritto la storia che ho scritto. E lì ho messo tutto di me per fare la parte che potevo fare, per essere qualcuno, sì, qualcuno. E c’ero riuscito. Ma ora non faccio che domandarmi: chi sono?” Sarà Toto a chiarirgli l’occasione perduta che la sua rigidità militaresca e di classe non gli ha permesso di cogliere fino in fondo: “l’8 settembre ha cancellato tutto, ha fatto cosa nuova. Questo non l’avete capito. È morto un esercito e ne è nato un altro […] Capellupo, se muore, muore per questo esercito. Non per quello di Scipione.” Tradito dai suoi, chi accasato, chi catturato durante l’attacchinaggio e giustiziato, chi acceso da nuova consapevolezza, e soprattutto da se stesso, lascerà Bologna prolungando la discesa verso sud, casa o esercito regio non è dato sapere.
Il tema dei gruppi e dei capi indipendenti, con tutte le peculiarità dei casi, è stato studiato dagli storici, testimoniato dai memorialisti e raccontato a partire dal “badogliano” Fenoglio. Viceversa la specifica presenza meridionale nelle bande del nord ha stentato a ricevere altrettanta attenzione. Anche in letteratura ricordo soltanto Il sentiero di Calvino, con la presenza appartata nella scalcinata brigata del Dritto dei quattro cognati calabresi, ridotta per altro agli scherzi che subiscono da Pin, centrati soprattutto sulla diversità linguistica; la figura del Pantelleria, nel bel racconto di Questi Il tuffo, la cui peculiarità perturbante si manifesta nella sua confidenza con l’acqua di un lago montano; oppure in La prima neve di Tutino su Luigi Gallo: “Battitsti era nato sul mare. Aveva l’accento meridionale, cosa che lo rendeva diverso e, in certo senso, lo portava lontano dagli altri”. Toto, il personaggio più cosciente, è colpito dalle riflessioni “decise e concrete” degli operai bolognesi, ed osserva la grande differenza con le chiacchiere rimasticate al sole nella piazza di Sant’Onofrio, il suo paese: “laggiù gli uomini rimanevano le ore senza parlare, e quando parlavano più che altro era di malasorte e disgrazia, o del modo di trovare un meglio al di fuori, contro la legge”. D’altra parte i suoi racconti sulla Sicilia alla ben disposta moglie del suo futuro padre adottivo parevano “favole”; ancora la lente dell’esotismo e del mito attraverso cui, quasi cent’anni prima, un Cesare Abba guardava gli strani spettacoli offerti dalla terra dov’era sbarcato con i Mille di Garibaldi. Insomma gli Italiani, dopo il Risorgimento, la Grande Guerra e la Resistenza, erano tuttora da farsi come nazione davvero unitaria.
Il terzo, più tardo, romanzo resistenziale di D’Agata, I ragazzi del coprifuoco, riprende, attraverso un narratore interno ancor più legato all’autobiografia (se ne traccia le origini familiari, la professione medica abbandonata, la vita a Roma da scrittore), alcuni dei motivi visti in precedenza. Sul jazz per esempio si ricalcano pari pari le pagine della prima opera, facendo coincidere la crisi del protagonista, stufo della Resistenza limitata all’attacchinaggio del periodico socialista «Nuovo Risorgimento», con l’immersione nelle sessioni musicali (“Uscivo stordito e appagato, con un senso di pienezza che durava ore e ore. Così mi figuravo gli effetti dell’oppio, e c’era anche il disco che ci voleva, China Boy”), che diventano invece allegra partecipazione alle sarabande notturne del dopoguerra: “Molto in voga era un arrangiamento di Bandiera Rossa che a un certo punto diventava How High’s the Moon.”
Qui la fase principale dell’attività partigiana per il narratore nasce quasi per caso il primo settembre 1944, grazie a una chiacchierata al caffè con un padrone di tipografia amico del padre: “mi ritrovai arruolato nell’esercito favoloso e misterioso dei partigiani. Appartenevo – anche se in quel momento non lo sapevo – alla Brigata Matteotti Sap della Divisione Bologna.” Seguirà la spiegazione del comandante (“Dobbiamo dare l’idea di essere in tanti, molti di più di quelli che siamo. Così, chi è dalla nostra parte si fa coraggio e chi è contro si spaventa. Alla popolazione dobbiamo dire perché combattiamo e perché la nostra è la parte giusta. Spiegargli che non andiamo allo sbaraglio e che per forza vinciamo.”) e le prime spedizioni adrenaliniche in cui anche il linguaggio di solito piuttosto sbiadito si anima: “Il coprifuoco me lo figuravo come un nebbione calato sulla città, come un velo scuro che copriva le strade e le case. Trovai invece una luna sfacciata: si vedevano i colori, anche se falsati da una tonalità verdognola, mentre il buio non era diffuso, avvolgente, ma si staccava dalla luce con dei tagli netti.” Tra tali azioni anche la partecipazione ha una grottesca nottata con degli indipendenti guidati da un pittore vanesio che, come il Maggiore di cui sopra, diffondeva dei suoi artistici proclami; segue l’assuefazione, la delusione per la scarsa visibilità tra i tanti “più grandi e prepotenti manifesti delle autorità” e la scarsa attenzione dei passanti. Infine la speranza di fare di più, specie dopo la visione dei sei impiccati esibiti il 20 dicembre 1944 su un lato di Palazzo D’Accursio. Esaudita gli ultimi due mesi di guerra, quando lo stesso comandante, già salito da un po’ in montagna, lo chiama con sé; di quel periodo, al di là del “profumo della fine” che è “talmente forte che dà la smania e non fa dormire. Lo sentiamo tutti: noi e i contadini. Anche i tedeschi lo sentono, e difatti non sembrano più gli stessi”, l’autore nulla ci dice, saltando direttamente alla liberazione di Bologna del 21 aprile ’45.
I ricordi stanno dentro una parentesi contemporanea, che vede il fortuito re-incontro in ospedale a Bologna con Mistico, il comandante d’allora, riconosciuto subito nel letto per la faccia da “indio della bassa padana”, rimasta impressa nella memoria nonostante le offese sella malattia. Non si tratta più ovviamente del ventenne entusiasta e maturo campione di boccette dalla “pronta e infallibile visione di gioco” che sfruttava la carta da lavoro Todt per muoversi in città: ora è interessato solo a medici e medicine, pur non avendo capito che la sua ulcera è in realtà un tumore e che non gli resta più molto da vivere. Ma la vita stessa di tornitore, marito senza figli di una donna più giovane, pensionato da bar senza veri amici, conferisce il tono crepuscolare al (non)rapporto con il narratore. Tre mesi dopo l’ultimo incontro in montagna lo rivede acchittato ed energico, si salutano e incontrano per caso quarantasei anni dopo, nei giorni di Natale: promesse di telefonate e niente più fino al reparto di gastroenterologia, ancora un 26 dicembre. In mezzo la notizia del conferimento della medaglia d’argento, il pensiero di contattarlo per le felicitazioni:
Ho pensato di rintracciarlo, di scrivere o telefonare per dirgli che ero contento. Felice. Lieto. O qualcosa di più. Che, come facilmente dicono gli americani, ero fiero di lui. Di averlo avuto come comandante.
Ma non era troppo, visto che ci conoscevamo appena? Ho lasciato perdere. Quanti affetti ho perduto così, pur rimpiangendoli, per inerzia e silenzio, per non aver saputo trovare una frase giusta nel momento giusto.
Del resto anche alla fine non tornano mai sui tempi andati, forse gelosi o pudichi dei propri ricordi, e anche la moglie di Mistico rivela al narratore: “non mi ha mai parlato di quello che ha fatto allora. Quando stavamo da poco insieme, e io ero curiosa, sa come mi rispondeva? Le cose che ho fatto, le ho fatte quando era giusto. A raccontarle dopo perdono, sembrano inventate.” Insomma il tenace scorrere del tempo e il grigiore della quotidianità sembrano erodere, prima della morte e di una di quelle commemorazioni a cui il narratore non ha mai voluto partecipare, il legame ormai lontano, l’esperienza che pure viene rievocata in tutta la narrazione. Nessuna riflessione profonda, riconsiderazione storica o personale, soltanto il più terribile, perché vero, senso di perdita si insinua allora su questa tarda autobiografia, che però chiude con il lampo della frase finale, un brillio di riconoscenza sulla propria vita: “Hai fatto bene a mandarmi qui. Mi ha fatto provare il sapore, il piacere impagabile di essere al mondo.”; “Hai fatto vincere anche uno come me.”

 Il paesaggio dell’avventura partigiana - Alberto Volpi
Il paesaggio dell’avventura partigiana - Alberto Volpi Comincia un altro giorno. Sarà il 25 di aprile? - Alberto Volpi
Comincia un altro giorno. Sarà il 25 di aprile? - Alberto Volpi La memoria oltre sé stessa.
La memoria oltre sé stessa.  Il resistente uomo. La proposta di David Maria Turoldo - Alberto Volpi
Il resistente uomo. La proposta di David Maria Turoldo - Alberto Volpi La GIPSI/ 2
La GIPSI/ 2 Mari critico
Mari critico Tempi tokieniani/ 2
Tempi tokieniani/ 2 La Gipsi/ 4
La Gipsi/ 4





















