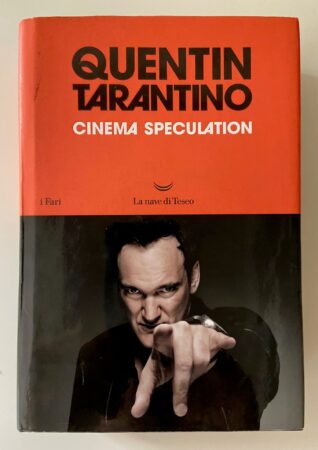
Nelle quattrocentoventi pagine di Cinema Speculation (la Nave di Teseo, 2023), Quentin Tarantino racconta le sue esperienze di spettatore precoce e appassionato nel periodo che corre dalla fine degli anni Sessanta all’intero decennio successivo. Sono gli anni della sua infanzia e adolescenza, trascorsi per un gran numero di ore fra una sala cinematografica e l’altra, dove la madre (e, prima il suo patrigno, poi altri compagni, amici e amiche), lo portano con sé purché tenga la bocca chiusa, cosa non sempre facile. Colta l’opportunità – le domande possono aspettare il ritorno in macchina – Quentin si immerge nel buio della sala e partecipa a decine di spettacoli. Benché non possa capire tutto ciò che accade sullo schermo, comincia a vedere non solo i film da grandi, ma anche il modo in cui gli adulti vivono la sera: ciò che piace loro, di cosa parlano, come stanno insieme, cosa li diverte. La sala in sé è già uno spettacolo. Nel frattempo, ciò che si proietta è decisivo: sono gli anni della Nuova Hollywood, che comincia nel 1967 (Quentin ha quattro anni). In quegli anni si mostrano cose che in precedenza non erano rappresentate: da M.A.S.H. di Altman alla Trilogia del dollaro di Leone, da Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo al Braccio violento della legge a Piccolo grande uomo. E così un gran numero di film di serie minore (a quattordici anni vede il suo primo film pornografico, Miss Jones, uno dei migliori del genere).
Nel modo in cui gli adulti reagivano ai film […] c’era qualcosa che all’epoca non avrei saputo individuare, ma che capisco adesso. Se i bambini vedono un film dove ci sono parolacce usate in modo comico e gag su cacca e scoregge, di solido ridacchiano. Quando sono un po’ più grandi, sono le battute sul sesso a farli ridere. Ma la loro è una risata al tempo stesso maliziosa e spavalda. Sanno che sono cose che forse sarebbe meglio non vedessero e non sentissero. E il tipo di risata rivela la consapevolezza della trasgressione. (p. 20)
Tarantino racconta la sua esperienza con un registro popolare – e con prevedibile competenza enciclopedica – facendo emergere man mano intuizioni che ne confermano la voce, che non perde mai forza persuasiva: l’entusiasmo, che è il tratto dominante e quasi il timbro di questa voce, non contrasta con la precisione del dettaglio, anzi la richiede proprio perché esprime una passione decisamente sensibile alla sciatteria. Che si tratti di film di serie A o di serie B, ciò che conta è che il regista del caso non arretri davanti al compito di definire la propria storia nel modo più coerente con le difficoltà che la narrazione comporta. Ovviamente, non è il tema a fare la differenza, ma il modo in cu lo si racconta. Per lui Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo di Siegel è un film perfetto, come lo sono Lo squalo, Carrie – lo sguardo di Satana, Io e Annie e L’esorcista, ciascuno compiuto all’interno del proprio mondo narrativo.
Negli anni Settanta del Novecento si consuma anche un altro passaggio decisivo, quello fra gli «autori anti-sistema» della Nuova Hollywood e i Movie Brats, i giovani registi cinefili, ugualmente agguerriti, che si esprimono però con modalità profondamente diverse. Prima dell’avvento di questi, alcuni film come La guerra del cittadino Joe, Il giustiziere della notte, e il già citato primo film della serie di Callaghan (il capolavoro di Don Siegel) parlavano a una generazione che aveva fatto la guerra (forse anche la guerra di Corea), si era sistemata e che ora trovava davanti a sé un’America che non capiva e che non somigliava per niente a quella che aveva desiderato. La cultura giovanile aveva preso il sopravvento, i nuovi problemi sociali sembravano incomprensibili: «il fenomeno dei serial killer, la cultura della droga e del libero amore, le nudità, la violenza e il turpiloquio dei film della New Hollywood, Woodstock, Altamont, Stonewall, Cielo Drive» (p. 72). Il film di Siegel era reazionario, ma soprattutto disturbante, mentre i successivi della serie tentarono di normalizzare il personaggio di Harry, interpretato da Eastwood. Non che la violenza non si fosse già vista prima, ma questa, come quella di Packimpah, era brutale, giungeva improvvisa, senza una pur discutibile preparazione; e colpiva senza ritegno. I film della serie di Callaghan sono decisivi nel passaggio dal western al poliziesco che avviene proprio negli anni Settanta, quando il paesaggio urbano diventa sede di conflitti più di quanto non lo fosse l’epica della frontiera.
Gli autori antisistema volevano girare remake dei film di John Ford, ma non come Scorsese e Schrader avrebbero fatto con Taxi Driver e Hardcore. Volevano rifare Il massacro di Fort Apache dal punto di vista degli indiani. E lo fecero: Arthur Penn in Piccolo grande uomo, Ralph Nelson in Soldato blu e Robert Aldrich (che non era un figlio degli anni Settanta, di certo non era un hippie ma era assolutamente contro il sistema) in Nessuna pietà per Ulzana.
Il motivo di girare, in questo nuovo clima, tanti film sul passato americano era la volontà di analizzare e finalmente di mostrare una lunga storia fatta di fascismo, razzismo e ipocrisia. Tutti gli elementi che per mezzo secolo la vecchia Hollywood aveva rimosso o edulcorato. (pp. 190-191)
Dunque gli autori antisistema, e oltre a quelli citati vanno aggiunti anche Altman, Packimpah, Dennis Hopper, contestavano politicamente la storia americana, con una veemenza e una perentorietà che oggi sembra ritornare. Eppure questo smascheramento per cui all’«O.K. Corral, più che un duello, c’era stata l’esecuzione a sangue freddo dei Clanton da parte di Wyatt Erp e dei suoi fratelli» in nome dei soldi e del potere, perdeva qualcosa per strada (p. 191). E forse la perdeva anche Penn, che nel Piccolo grande uomo scelse un’attrice asiatica per interpretare la moglie di Dustin Hoffman, poi trucidata dai soldati blu a cavallo, per parlare della guerra del Vietnam. Questi autori rifacevano il passato guardando ai maestri del cinema, ma non erano cinefili e non riformulavano il genere: il risultato è che gli spettatori spesso non capivano le influenze del cinema europeo che questi autori avevano assorbito. Potremmo dire che la limitazione o la sistematica esclusione della possibilità dello spettatore comune di identificarsi nel protagonista lo portava progressivamente a estraniarsi. E Tarantino pone l’interrogativo centrale:
Come scrisse Pauline Kael all’inizio del decennio, i film migliori stavano suggerendo che l’unica soluzione ragionevole, per gli americani, fosse quella di assumere qualche droga?
Possibile che tutti i film dovessero essere deprimenti?
O Noiosi?
Possibile che tutti i film parlassero di gente con qualche problema? (p. 196)
Per la controcultura il lieto fine era diventato volgare, sintomo di un conformismo che ribadiva i rapporti di produzione; ma si tratta pur sempre di una convenzione narrativa. Un finale sospeso con la morte insensata del protagonista conferma la critica della normalità solo finché non diventa a sua volta norma: se troppi film di fatto si concludono interrompendosi enigmaticamente, l’effetto diminuisce. E così oggi potremmo dire che il conformismo di una serie tv che nei primi cinque minuti mette in gioco la parvenza di un conflitto e (attraverso un personaggio secondario) la necessità di difendere una minoranza, qualunque essa sia, solo per mostrare allo spettatore che la produzione è sensibile alle minoranze (senza poi sviluppare il tema), comincia già a stufare, come stanca in letteratura un formalismo modernista giunto fuori tempo massimo.
Uno dei punti centrali nel libro di Tarantino è perciò l’affermazione dei Movie Brats: Bogdanovich, Milius, Lucas, Spielberg, De Palma, Schrader, Scorsese, con Coppola e in parte Corman in funzione di mentori. Un gruppo di registi cinefili che riescono ad affrontare generi e temi già noti con un approccio nuovo, pensando al pubblico più che all’indulgenza per la loro concezione dell’arte e rinnovando di fatto il linguaggio cinematografico. E infatti L’ultimo spettacolo, Il padrino, American Graffiti, Paper Moon, Lo squalo, Carrie – lo sguardo di Satana, Guerre stellari, Incontri ravvicinati del terzo tipo sono invecchiati meglio dei film degli autori antisistema.
Nei film di questo gruppo di registi, il posto d’onore spetta a Taxi Driver, diretto da Scorsese e scritto da Schrader. E Taxi Driver è appunto, dichiaratamente, il remake di Sentieri selvaggi di John Ford, o meglio, non propriamente un remake, più una ripresa in epoca contemporanea del protagonista, Ethan Edwards (nel film di Ford interpretato da John Wayne) e del suo tema, la ricerca e il salvataggio di una giovane catturata anni prima dagli indiani(il titolo originale del film di Ford era infatti The Searchers). Lì gli avversari erano i Comanche, qui diventano il tenutario di un bordello fra i più malmessi e i suoi clienti; lì la giovane da salvare era Nathalie Wood, in Taxi Driver è la giovanissima Jodie Foster. Ethan Edwards era, nelle parole di Scorsese, un uomo che «non appartiene a nessun luogo, perché ha combattuto una guerra nella quale credeva e che ha perso; ma porta dentro di sé una potenzialità di amore che è stata soffocata» (p. 248). Il taxista Travis Bickle, interpretato da Robert De Niro, è ugualmente un solitario nella New York degli anni Settanta, un isolato incapace di normali interazioni sociali, che perde progressivamente la sua innocenza e cerca un riscatto. Potrebbe essere un reduce, ma il film non è chiaro a riguardo. Invitando per la prima volta Betsy al cinema (Cybill Sheperd, che corrisponde a Martha, la donna che John Wayne ama e non può avere) Travis – secondo la sua abitudine – la porta a vedere un film porno, suscitando una reazione immaginabile. Sia in Sentieri selvaggi, sia in Taxi Driver lo spettatore è invitato a seguire il punto di vista di un razzista, un razzista nel comportamento più che nel linguaggio, che segue nel tentativo di comprensione della realtà. Lo spaesamento del protagonista nelle strade newyorkesi fa del film una storia ben diversa da Il giustiziere della notte, con cui pure condivide più di un elemento. E qui non si può non condividere l’analisi di Tarantino: il film funziona così bene perché nella prima parte Travis sembra un disperato che sta per impazzire; nella seconda, qualcuno – sempre privo di equilibrio – che ha capito qualcosa e che cerca di rimediare a un danno. L’assunzione del suo punto di vista da parte del pubblico porta con sé l’ansia del riscatto.
Tarantino dà questa conoscenza per scontata, ma si ricorderà che al termine di Sentieri Selvaggi John Wayne, incorniciato nella famosa inquadratura nera con la silhouette che si staglia in controluce sulla porta, se ne va perché non ha un posto dove stare. Schrader aveva pensato che, dopo la violenta sparatoria per liberare Iris, il taxista Travis si sarebbe ucciso. Ma Scorsese lo salva: dopo l’esplosione di violenza, lo lascia sul divano a fingere di spararsi alla tempia con le dita. E infatti, nell’inquadratura finale all’esterno del bordello, si vedono arrivare due infermieri.
Questa libertà, il rinnovamento stilistico compiuto dai Movie Brats incontrò negli anni Ottanta una fase di avvilente conformismo. Se per Tarantino gli anni Cinquanta furono pesanti, gli Ottanta andarono ancora peggio perché le restrizioni non furono imposte da una società spaventata e repressa, ma dalla stessa Hollywood. Il libro non ne parla, ma qui chi ha buona memoria potrebbe ricordare che il decennio si aprì con il disastro finanziario e critico dei Cancelli del cielo di Cimino (1980), che segnò la fine della United Artists come studio indipendente (anche se nella versione 2012 Director’s cut il film è stato giustamente rivalutato). La prudenza e il controllo dei produttori intervenuti dopo questa vicenda limitò fortemente la libertà espressiva: e la maggior parte di registi si adeguò. Fra chi negli anni Ottanta seppe resistere, Tarantino menziona Lynch, Cronenberg, Terry Gilliam, Abel Ferrara, Verhooven e pochi altri.
In termini generali, andò spesso perduta l’esigenza di mantenere l’ambiguità, l’imprevedibilità del personaggio e della sua storia, a favore di una visione semplificata e artificiosa del contesto. Molti film di allora risultano depotenziati. Qui Tarantino, fra gli esempi negativi, «insipidi», include La mia Africa, Gandhi, Il grande freddo, Stand by me, Gente comune.
Ma il libro non si sviluppa solo attraverso l’analisi dei film che apre lo sguardo a un affresco sulle sorti di Hollywood. Due dei momenti migliori riguardano infatti figure meno conosciute: il critico Kevin Thomas e Floyd Roy Wilson, un amico del regista.
Kevin Thomas era il critico in seconda – «il samurai in seconda» come lo chiama Tarantino – del «Los Angeles Times». Fu decisivo nello spingere verso l’affermazione registi come Jonathan Demme, che allora lavorava per La New World Pictures di Roger Corman in film di serie B. Più preparato dei critici titolari, personale e acuto, Thomas seguiva i titoli che gli altri non vedevano, e soprattutto i film indipendenti, o il cinema d’essai.
Kevin Thomas scriveva dei film di exploitation così come un appassionato giornalista sportivo potrebbe scrivere delle squadre migliori dei campionati delle superiori: andando alla ricerca dei giocatori che sembravano avere il talento per emergere; seguendoli quando esordivano nel campionato del college, e notando se avevano realizzato il loro potenziale; continuando a seguirli quando diventavano professionisti e giocavano nelle minor leagues, finché esordivano nella major league. Kevin Thomas era sempre a bordo campo, a fare il tifo per loro. (p. 172)
Così fece appunto per Demme, ancora lontano dal successo del Silenzio degli innocenti. Nell’elenco degli estratti degli articoli di Kevin Thomas riprodotti nel libro si ritrova la stessa passione del regista, concentrata e priva delle distrazioni indotte dalla necessità di rispondere alle mode poetiche o accademiche del momento. Un’indipendenza di giudizio che Tarantino apprezza anche quando non ne condivide le conclusioni, ad esempio sulla rappresentazione della violenza non giustificata dal contesto narrativo, che il critico non amava. Il lungo lavoro quotidiano retto da un solido buon senso, lo scrupolo del particolare, la dedizione, l’attenzione alla coerenza della storia (non all’arco di trasformazione del personaggio: il plot non è sempre già-dato) rendevano il critico un interlocutore, seguendo il quale, o contestandolo, il lettore poteva trovare la sua voce. Del resto, al di là di ogni frettolosa considerazione di ordine sociale, la funzione del critico resta in primo luogo quella di uno scrittore che mette a disposizione le proprie scoperte e intuizioni a partire da un’esperienza di spettatore o di lettore. In fondo è uno scrittore che parla di film, o di libri, come lo è un autore che parla di personaggi. L’altra parte singolare del libro è la nota dedicata a Floyd Roy Wilson, il trentasettenne afroamericano che per un anno e mezzo fu coinquilino della madre del regista (usciva con la sua migliore amica) e del giovane Quentin. Un perdigiorno idiosincratico, inaffidabile, grande esperto di cinema e aspirante sceneggiatore senza troppa convinzione. Nel 1978, il sedicenne Quentin vide un gran numero di film con Floyd, pregato di tenerlo d’occhio mentre la madre lavorava. Dal Cacciatore a I giorni del cielo, da Assassinio sul Nilo ai Ragazzi venuti dal Brasile, da Apocalypse Now a Rocky II alla miniserie Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Amava Il padrino di Coppola, ma anche Fra le tue braccia di Lubitsch, il che dava l’impronta di un’esperienza di spettatore molto articolata. Anche in questo caso – che altrimenti correrebbe il rischio di rientrare in un sottogenere, quello del racconto di un fallimento da parte da chi ce l’ha fatta – il libro si conferma l’autobiografia della propensione che Tarantino esalta limitandosi a incarnarla. L’entusiasmo, inteso come commozione e perfino come invasamento, non è altro che il nome della propensione narrativa che nel libro risuona autenticamente popolare, al contrario di ciò che succede ad esempio nei pur ammirevoli libri di Truffaut (eccetto l’intervista a Hitchcock), nei quali non emerge mai slegata da una trasparente esigenza letteraria.

 Poco spazio per gli alibi.
Poco spazio per gli alibi. L’evidenza è un’illusione? L’avventura e il romanzo. Conversazione con Walter Nardon - Enrico De Vivo
L’evidenza è un’illusione? L’avventura e il romanzo. Conversazione con Walter Nardon - Enrico De Vivo Media e mediatori - Carla Benedetti
Media e mediatori - Carla Benedetti Le rêve, l’après-midi: sognare con Éric Rohmer/ 1 - Daniele Ruini
Le rêve, l’après-midi: sognare con Éric Rohmer/ 1 - Daniele Ruini Forse sognare. Su Angera e il progetto Infinite Jest – serie tv
Forse sognare. Su Angera e il progetto Infinite Jest – serie tv Incontri domenicali
Incontri domenicali Il resto
Il resto Un impiegato del bene
Un impiegato del bene





















