
Chi avesse voluto risalire fino al momento in cui per la prima volta un essere umano aveva messo piede e fissato il cammino verso quella che oggi è Saint-Jude, avrebbe probabilmente trovato il sangue dei Rivres, arrivato lì da chissà quali ancor più remote paludi: poiché non erano re, e nessuno aveva o avrebbe mai scritto la loro storia.
Il grigio carnevale della civiltà aveva rivestito gli antichi Rivres di tutte le pelli e gli stracci dei servi di ogni tempo. Il più indietro che i genitori di Leon riuscivano andare era ai nonni dei nonni, e per i nonni dei nonni il vestito era quello del mare. Un secolo prima o diecimila anni prima, per Leon non faceva differenza, i Rivres di Saint-Jude erano una famigliola di pescatori che tiravano le loro reti lungo i fondali della baia di Saint-Jude insieme ad altre altrettanto rabberciate barchette: talvolta anche avventurandosi al largo, quando la febbre dell’oceano sembrava tendere le corde e le assi mezzo marcite della barchetta e contagiarli come vecchi violini trascinati dal vento.
Nemmeno avevano dato un nome, alla barca.
Finché un giorno il nonno del nonno di Leon, secondo volevano le oscure leggende di famiglia (nessuno nemmeno il nome di quel vecchio… forse Luis?), un giorno si era ritrovato con altri pescatori in una bonaccia asfissiante durante una di quelle spedizioni nella nebbia azzurra di là dalla baia, e dopo due giornate alla deriva nella nebbia e nella notte, per ingannare il tempo, quando ormai pensavano che sarebbero morti in mare consumati dalla sete e divorati dalle conchiglie, i pescatori avevano iniziato come in un’allucinazione a giocare a un qualche gioco simile alla morra, scommettendo tra loro le cose più preziose, sicuri di essere comunque tutti sul punto di perdere l’unica importante, sicuri che nessuna di quelle folli scommesse sarebbe mai stata pagata.
Ma il vento era arrivato a salvarli, e gli uomini avevano riguadagnato la terra, il nonno del nonno di Leon con la barca perduta a quella morra ustionata dal cielo abbacinante del nord. I figli da allora avevano dovuto lavorare sotto padrone. Arthur, il nonno di Leon, un moccioso in cui già balenavano lo sguardo e la smorfia scaltra del vecchio pazzo, sorrideva sempre, perso nella pace al di là della disperazione, gli occhi celesti e vecchi come l’orizzonte poco prima dell’aurora invernale.
Il nonno bambino sorrideva anche quando aveva salutato per la prima volta Sophie, lei poco più di una fila di denti circondata da una massa di ricci nerissimi, gli occhi due feroci puntini di luce. La pelle del colore quasi dorato della sabbia bagnata, Sophie si arrampicava sulle strane piante da frutto del giardino della sua famiglia, e Arthur la guardava da lontano, tornando dal lavoro ma i due bambini si sarebbero innamorati solo molti anni dopo, dopo il ritorno di Arthur dalla guerra e dopo essersi dimenticati l’uno dell’altra.
Arthur vedeva Sophie sugli alberi perché il giardino della sua famiglia era chiuso da muri e cancellate troppo alte per sbirciarvi attraverso, ma la prima volta che l’aveva vista lei era a cavalcioni di una vacca. Il nonno di Sophie teneva la bestia per la cavezza, e aveva colpito un po’ per scherzo un po’ per disprezzo quel ragazzino imbambolato davanti a loro, puzzolente di pesce e di silenzio. Gli occhi di Sophie accoccolata sulla schiena della vacca e quelli del nonno bambino di Leon acquattato nel fosso erboso dove si era cacciato dopo che il nonno di Sophie lo aveva colpito, gli occhi dei due avevano inghiottito l’un l’altro gli orizzonti, fagocitando ogni cosa intorno. L’amore insensato dei bambini, come una tenebra nella tenebra. Pochi giorni dopo, quasi senza parlarsi, quasi senza mai toccarsi se non durante le loro liti, Sophie e Arthur erano diventati inseparabili come un albero e la propria ombra.
L’indifferenza e la guerra erano ancora lontane, e con loro quell’altro amore che gli adulti chiamano amore.
Correvano sulla spiaggia di ciottoli minuti fino a farsi sanguinare i piedi. Era la spiaggia oltre la baia, dopo un bosco di rovi e agavi che oggi è stato catturato da una delle ville sul promontorio occidentale. A volte la testa di un cavallo sbucava sopra la vegetazione che copriva la discesa. Lo inseguivano tra le ortiche e i flabelli del farfaraccio, ma il cavallo si dileguava senza lasciare traccia, quasi al di sotto della testa non ci fosse che un corpo di serpente. Correvano fino sul crinale della collina, dove cominciava la sabbia e più in là l’oceano. Sophie strillava, atterrita dalla sparizione del cavalloserpente e dal vento del nord. Correvano e gridavano e non parlavano quasi mai. Fuggivano dalle onde che fuori dalla baia si srotolavano verso le nuvole precipitando sopra gli scogli, massacrando a volte i gabbiani; correndo si calpestavano l’ombra a vicenda, sempre più nervosi e silenziosi nella vicenda febbrile di nuvole e luce e pianeti, quasi anche il cielo come loro non fosse che un bambino senza pietà né ordine, e certi giorni Sophie si lasciava cadere infilando i suoi stinchi tra i piedi di Arthur e facendolo ruzzolare in terra, e allora lei subito gli era sopra e lo spingeva contro i sassi e gli bisbigliava cose che lo facevano piangere, gli tirava i capelli e gli chiedeva come voleva morire. Le tue ossa, gli bisbigliava.
Anche da grandi, le mani di Sophie avrebbero continuato ad essere più forti di Arthur, una presa d’acciaio che sembrava voler stringere fino a rompergli i polsi. Leon non ricorda della nonna che quelle mani, il corpo consumato sepolto nella penombra e nella carta da parati della stanza dove sarebbe morta, ormai del tutto priva di senno, dell’antica bambina ormai nient’altro che la luce terrificante degli occhi e la morsa d’acciaio delle sue mani, con le quali la vecchia negli ultimi giorni cercava di catturare Leon quando il bambino per sfida si intrufolava sotto il suo letto e le spingeva il materasso con i piedi finché le urla della vecchia o del bambino quando veniva catturato da quelle tenaglie che la pazzia aveva reso implacabili non richiamavano gli adulti ancora sani di mente della casa.
Si chinavano sulle conchiglie, camminando sulla distesa di sabbia della bassa marea, Sophie strappava dai muretti dei piccoli fiori impolverati e li metteva dietro le orecchie di Arthur. Arthur raccoglieva dei sassolini colorati e li tirava addosso a Sophie. Non passava un giorno che uno dei due non facesse piangere l’altra.
Li seguiva sempre Caos, il cane della famiglia di Sophie, un grosso pastore arlecchino che da seduto era alto come loro. Si acquattava tra i sassi e la sabbia, quasi indistinguibile da un mucchio di terra smossa con quel marasma di chiazze grigie e nere che gli colorava il pelo e che probabilmente era anche l’origine del suo nome. Caos restava appiattito nella sabbia, in attesa che i due bambini si avvicinassero abbastanza per terrorizzarli con un salto verso il cielo, ora la bestia al di sopra di loro, un puzzolente e festoso straccio di sabbia bagnata e scatti scomposti. Se per caso in uno di quegli agguati Sophie cadeva in terra, subito Caos si afflosciava e avvicinava il naso di pece contro la bambina.
– Quando ero piccola mi portava a cavallo. Guarda.
Sophie provava a mettersi in sella al cane, e Caos aspettava giusto l’istante in cui lei sollevasse i piedi prima di scattare in avanti verso il mare, disarcionando la bambina.
Ma in qualche cassetto della casa di Sophie, nelle stanze di sua madre, c’era una vecchia foto mezzo sfocata in cui un cane – non Caos però, dato che quello nella foto era completamente nero – era cavalcato da una bambina – non Sophie, anche se sembrava una versione in miniatura di Sophie: forse una nonna di Sophie, e le colline di sabbia alle spalle del gruppo di persone erano troppo grandi per essere le dune di Saint-Jude – una bambina talmente piccola da sembrare una bambola, tenuta in equilibrio sull’animale dalla mano di un adulto,
Sophie spingeva Arthur contro la sabbia, crocifiggendolo con la presa di ferro delle sue mani. Era più forte di lui.
Caos abbaiava e saltava intorno ai bambini in lotta, eccitato dal trionfo della padroncina.
– Sbranalo, sbranagli le gambe, sbranagli la pancia, attacca!
Il cane si avvicinava, furibondo e felice e senza certezza che quello fosse o no un gioco. Arthur si dimenava disperato, in lacrime, i denti di Caos appoggiati contro la sua gola.
– Non vedi che non capisce, se continui a dirglielo alla fine lo fa!
– Lo farà! Lo farà!
Non sembrava più nemmeno una bambina quando era così, quasi perdeva la parola e ridiventava uno di quegli uomini delle caverne i cui dipinti e graffi sulla roccia ancora sopravvivevano sulle pareti di alcune grotte a qualche chilometro da Saint-Jude. Avreste detto, anche voi catturati nella presa di ferro delle mani di Sophie, i suoi occhi come fori attraverso cui il sole le perforasse il cranio per colpirvi, il resto nient’altro che una minuscola e crudele massa nera resistente come un ramo di corniolo, avreste detto e anche voi come Arthur avreste per lungo tempo ricordato negli anni a venire, un’impossibile lama di selce appesa ai suoi fianchi sottili come un foglio di carta.
Ma Caos non gli aveva mai fatto niente, e il fatto di non essere stato sbranato era per Arthur la più indiscutibile prova della celebrata intelligenza di quel cane, venerato invece da tutta la famiglia di Sophie per il fatto di aver salvato la vita alla bambina.
Quella volta c’era anche Arthur. Era lui che aveva raccontato quello che era successo, anche se Sophie, in lacrime, gli aveva fatto giurare di non raccontare mai niente a nessuno. Ma era stato impossibile, perché tutti avevano creduto che i bambini fossero stati risucchiati dalla mareggiata, e dato che Sophie non faceva che strillare e nascondere la faccia dietro l’ammasso scompigliato di ricci neri Arthur aveva dovuto spiegare come si erano salvati. Stavano giocando, torturandosi e ridendo sulla spiaggia ancora disabitata di Saint-Jude, quando Caos aveva cominciato a ringhiare contro Sophie. Latrava con gli occhi con gli occhi che parevano volergli uscire dalla testa come antenne di granchio, e tirandola con i denti aveva trascinato Sophie via dalla spiaggia, Arthur che cercava di fermarlo colpendolo con uno stecco, altre persone sulla riva che non capivano se avvicinarsi o no per aiutare la bambina. Graffiandoli con le zampe e urtandoli, Caos aveva spinto i bambini fino in cima al promontorio occidentale, dandosi pace solo quando erano arrivati in cima, stremati. Ora Caos scodinzolava e abbaiava al cielo. Poi sotto di loro era arrivata l’onda. Aveva sommerso la costa fino a lambire le prime case del paese; una linea disegnata con la vernice nera su un muretto accanto a quello che sarebbe diventato il primo bar di Saint-Jude, dopo la guerra, ancora oggi indica il punto più alto di quella memorabile catastrofe.
Abbarbicati sopra uno scoglio, il cane che urlava esilarato, Sophie e Arthur avevano visto delle figure sotto di loro, forse uomini o animali o tutt’e due, raggiunte dal bordo dell’oceano e risucchiate come le briciole di segatura quando la servitù lavava il patio con secchi d’acqua a casa di Sophie. Sophie e Arthur vevano fissato i puntolini farsi sempre più piccoli mentre il contorno irriconoscibile dell’orizzonte li risucchiava.
– Li vedi ancora?
– Ne vedo uno. Due.
– Non li vedo più. Dov’è l’altro?
– Lì.
– Dove. Sono troppo lontani.
– Dove ci sono quelle onde più grandi.
– Quelle?
– Ormai sono passate.
– Dove.
– Non c’è più nessuno.
– Guarda!
Erano tornati ad abbassare gli occhi sulla costa. Proprio sotto di loro, una fila di suore era stata catturata dal mare. Fissavano il cielo esterrefatte, quasi comiche con quelle smorfie da martire, tante chiazze nere a mollo tra i gorghi che imploravano un qualche pittore, non importa quanto oscuro, che si provasse a eternare il loro martirio. Sempre che di martirio si potesse parlare. Affondarono quasi subito, senza arrivare lontano come le altre figure, e furono tra i primi corpi ad essere trovati, miglia più a est, e nacque anzi la leggenda che fossero state trascinate fino agli attracchi del monastero di Menez Mikael ar Mor, e ritrovati tra le sabbie mobili della bassa marea, quasi i cadaveri avessero voluto con un ultimo pellegrinaggio raggiungere insieme le braccia dell’angelo, la grazia, . Ma a Saint Jude tutti sapevano che le suore erano arrivate giusto all’isolotto di Lyshn, e il vecchio Jerome che aveva la sua capanna in cima all’isolotto e solo per questo si era salvato il giorno della mareggiata, aveva detto che quando le aveva trovate, seguendo il loro fetore marcio, ci aveva messo un po’ a capire cosa fossero, tanto erano gonfie, pallide, e ricoperte di granchi.
Dopo aver salvato Sophie dalla mareggiata (Arthur già risucchiato nello sfondo semiinvisibile in cui si perdono i cronisti di ogni tempo), Caos cominciò ad essere idolatrato come una specie di oracolo. Insuperbita oltre ogni più furibondo e innamorato sogno canino, la bestia divenne un guardiano implacabile di qualsiasi luogo dove Sophie posasse i piedi, per l’estasi della sua ramificatissima e invassallata famiglia. La tomba di Caos sarebbe rimasta nel cortile di casa della famiglia di Sophie fino a molti anni dopo la morte di Sophie stessa, una specie di altare paleolitico fatto di un cumulo di terra e del totem dei giocattoli preferiti del cane.
Cupe leggende di suore fantasma che sbucano dalle sabbie mobili intorno al monastero tidale di san Michele, nonché di una singola suora che più di una persona sostiene di aver intravisto nella vegetazione dell’isolotto di Lyshn che chiude la baia di Saint-Jude costituiscono ormai uno degli elementi dell’inferno locale–– “Ad ogni oltretomba il proprio presepe”, borbotta con disdegno il padre di Leon: lui poi, quello dei fenici! Meglio sarebbe dire, non c’è mente umana tanto grande che non possa immaginarsi un manicomio ancora più grande in cui imprigionarla.
***
E adesso cosa succede? Arthur e Sophie sono sempre bambini, ma ora la città è completamente deserta. Dove sono tutti? I due bambini, accompagnati dal cane, passeggiano per vie completamente vuote, come in un deposito di case di bambole. Dall’oceano arrivano ininterrotti cumuli di nubi, come una gigantesca pulsazione atmosferica. Caos annusa ogni angolo della città fantasma. Entrano in una panetteria, entrano in una libreria, in una scuola, in più di una casa: nessuno. Tutte le porte sono aperte. Riescono a raggiungere il tetto di uno dei decrepiti palazzi del centro. Guardano il cielo e la baia. Ecco uno stormo di gabbiani. Lontano, laggiù, un cavallo che sembra abbandonato in mezzo a uno spiazzo, vicino a un ostacolo. Appare così lontano e piccolo da sembrare finto, e potrebbe essere una bambola. Non accade nulla, i due bambini guardano la città vuota sotto di loro, muti, senza paura. Qualcuno sta cantando da una delle finestre più in basso. La finestra, se è quella, è aperta, ma i due bambini non riescono a vedere niente.
– Non c’è più nessuno!
La bambina guardava la città deserta, trionfante. I suoi occhi ora erano duri, una minuscola imperatrice di ossidiana sotto il cielo in tempesta.
Si era voltata verso Arthur.
– Non succede più niente!
Arthur sentiva il panico solleticargli la gola.
– Ci hanno abbandonato.
Ma gli occhi di Sophie lacrimavano di gioia. Era la primissima volta che Arthur vedeva qualcuno piangere di felicità, e all’inizio era stato sul punto di scoppiare in lacrime anche lui.
– Se non c’è nessuno non succede più niente!
Forse fu solo per una specie di contagio vedendo l’incontrollabile felicità di Sophie che Arthur sentì di comprenderne l’estasi. Erano solo loro nella città vuota, e niente sarebbe mai più accaduto, e loro non avrebbero fatto altro che guardare insieme questo niente, ma guardare non è qualcosa che accade, insieme non è qualcosa che accade. La gioia incontrollabile della salvezza e dell’apocalisse. Chi guarda non accade, così come chi legge non fa parte del libro.
Infine, come pulcini che rompono il guscio azzurro del cielo, gli abitanti erano ricomparsi sotto di loro, le macchine si erano rimesse in moto ed era tornato il lamento ininterrotto, da cicale marcite, della vita umana.
***
Anni dopo, nel mezzo della guerra, intrappolato in non so più che pantano di sangue in una infinita pianura dell’est, riverso tra i compagni morti e fingendosi morto anche lui perché non lo mandassero di nuovo a correre attraverso la palude scarlatta, Arthur sarebbe tornato a chiedersi cosa mai fosse successo quel giorno con quella bambina che, così gli sembrava di ricordare, veniva da un’isola italiana in mezzo a un mare nascosto alle spalle della Francia; Arthur sarebbe tornato a chiedersi, le schegge di fango e di ossa che gli graffiavano il viso disperatamente impassibile per continuare a sembrare morto – ma del resto chi poteva sperare di ingannare ormai se non la morte stessa dato che tutti intorno a lui erano morti, o forse, o forse ecco qua, forse tutti fingevano di essere morti, non sarebbe quello il modo migliore per finire ogni guerra, fingersi tutti morti finché non ci fosse più nessuno da mandare da nessuna parte, i generali che camminano confusi tra i cadaveri, i soldati che si devono tenere per non scoppiare a ridere e rivelare l’inganno,
non ridere Franz, non ridere Jacques,
o ci faranno tornare a morire –
Arthur sarebbe tornato a ricordare quel giorno con quella bambina così cattiva, e ancora una volta si sarebbe chiesto se non fosse stato tutto un sogno, o una coincidenza impossibile quella per cui l’intero paesino di Saint-Jude per interi minuti era apparso completamente vuoto ai due bambini che lo guardavano dall’alto. Forse, avrebbe delirato Arthur appiattendosi tra i cadaveri come faceva Caos sulla spiaggia di Saint-Jude, forse tutta la gente di Saint-Jude che quel giorno per alcuni minuti era sparita era ora lì con lui, in quel momento acquattata con lui sotto la pioggia di fuoco, fingendosi morta per poter fuggire alla battaglia. Quel capitano cui un proiettile aveva maciullato parte della faccia, non era forse identico al giardiniere del collegio Le plus que saint sang de Marie, proprio dietro la piazza del mercato?
I discendenti futuri sono infiniti, così come i nostri antenati: una linea infinita: ma allora come è possibile che noi siamo proprio qui? Come è possibile fissare un punto sopra una sequenza infinita? Come sarebbe mai possibile, per un altro anche solo trovare quel punto? Dovresti cercare all’infinito. Come è mai possibile che qualcosa esista davvero? Eppure eccolo qui.
***
E Sophie? La terra mangia come noi, le diceva suo nonno, e per dimostrarglielo le aveva fatto sotterrare gli avanzi del pranzo, e dopo una settimana era tutto sparito. Mangia più lenta di noi, ma mangia, le aveva detto il nonno, i suoi denti sono i grani di terra. Si metteva più vicina che poteva per vedere se sarebbe riuscita a vedere la terra masticare o inghiottire come noi, e forse se avesse visto la sua bocca avrebe potuto anche parlarle e chiederle di mordere o anche sbranare tutti i suoi nemici, come Caos. Ma quando la terra mangia semi le viene una malattia, le diceva il nonno— per la terra è una malattia, ma per noi è una pianta. Anche a noi può succedere la stessa cosa, anche da noi possono uscire delle piante, le diceva, però per farlo bisogna tenere i semi in bocca senza inghiottirli e stare ben fermi, molto ben fermi, e nessuno ce la fa, prima o poi tutti si addormentano, solo i morti ce la fanno. Si sdraiava con un seme di mela in bocca e guardava il cielo aspettando che venisse l’ombra della pianta con i suoi rami, ma far finta di essere morti non vale. Ogni volta invece si addormentava, e quando si svegliava il seme non c’era più. La terra non è né viva né morta, ecco perché l’unica cosa che non riesce a mangiare sono i semi. Si sotterrava le mani e aspettava che la terra le venisse a mangiare, metteva le mani per essere sicura di non perdere il momento in cui iniziava a masticare, così sarebbe riuscita a parlarle, ma “La terra mica capisce il francese, le aveva detto il nonno. Sophie aveva riso, il nonno che la teneva per mano come l’ombra di un uccellino.
***
Un altro giorno Caos aveva ucciso una capra. Sbucando dalle foglie del promontorio, la capra si si era avvicinato ai due bambini e per un qualche motivo Caos aveva stabilito che l’animale poteva rappresentare un pericolo per Sophie. Si era avventato sulla capra spingendola verso il mare e, una volta che si era ritrovata così in là da dover quasi nuotare per allontanarsi da lui, Caos le si era buttato addosso e, premendola con le zampe contro il fondale, l’aveva annegata.


 Fetish/ 1 - Omar Viel
Fetish/ 1 - Omar Viel Presiden arsitek/ 6 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 6 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 25 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 25 - Angelo Angera Come si ride nei romanzi - Lakis Proguidis
Come si ride nei romanzi - Lakis Proguidis Presiden arsitek/ 36
Presiden arsitek/ 36 Presiden arsitek/ 44
Presiden arsitek/ 44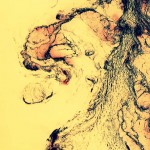 Presiden arsitek/ 13
Presiden arsitek/ 13 Presiden arsitek/ 29
Presiden arsitek/ 29





















