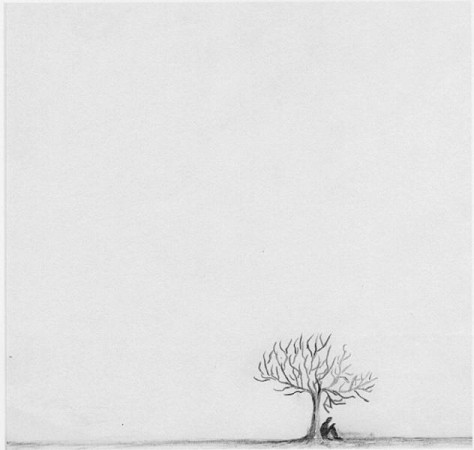
… je n’ai jamais fait d’ouvrage, j’ai fait
seulement des essais en comptant toujours
préluder…”
(G. Leopardi, Lettera a Charles Lebreton, da Napoli, fine giugno 1836)“En ce qui concerne la ‘pensée’ les
oeuvres sont des falsifications, puisqu’elles
éliminent le provisoire et le non-réitérable,
l’instantané, et le mélange pur et
impur, désordre et ordre”
(P. Valéry, Cahiers, I)
Il tempo che abita lo Zibaldone è come custodito da due confini. Da una parte c’è il silenzio, un silenzio che separa un pensiero dall’altro: sospensione e discontinuità in cui si può cogliere il riverbero dei giorni, delle letture nei giorni, il trascorrere delle stagioni, delle festività, degli anniversari, si può ascoltare insomma il rumore del tempo esteriore e forse intravedere quel punto segreto dove l’occasione (nel senso forte dato da Hölderlin: “was geschiehet, es sei alles gelegen dir”) si annoda alla scrittura, si fa scrittura. Dall’altra parte c’è il comporsi e il ricomporsi – per riprese, rimbalzi, ritorni, riflessi – di una trama del pensiero che via via disegna una genealogia dei saperi, una cartografia delle passioni, una drammaturgia dell’uomo sensibile, una teorica delle arti, una mappa dei poteri e micropoteri, con i loro miraggi, le loro connaturali sopraffazioni e crudeltà e miserie. In questo ordito prende spazio e figura la filologia, l’amore della lingua, che mostra tutte le sue implicazioni: il gioco della lettera, le corrispondenze tra gli etimi, le sequenze delle derivazioni, le modificazioni degli usi, il “frivolo sogno” di chi indaga sulla prima lingua e sull’origine, le configurazioni e i caratteri delle lingue nazionali, l’arte e la tecnica del tradurre, le grandi questioni dell’esegesi.
Questi due momenti – il silenzio e la trama, la frattura del discorso e la costruzione del sapere, la discontinuità e il processo – danno al tempo dello “smisurato manoscritto” il ritmo suo proprio. Che consiste in una straordinaria attiva esitazione. Esitazione tra frammento e sistema, tra frantumazione del dire e disegno del libro possibile, tra margine e costruzione. Questa esitazione ha, sul piano della prosa, la stessa feconda necessità di un’altra esitazione: la “hésitation prolongée”, per dirla con Valéry, tra suono e senso, un’esitazione che da Poe a Baudelaire a Mallarmé è servita a definire la poesia stessa.
Quel che davvero è messo in questione nella scrittura dello Zibaldone è l’idea compiuta, omogenea, restaurativa di opera. Appunto: “je n’ai jamais fait d’ouvrage”. Nella sospensione del dire, nel bianco che separa un pensiero dall’altro, si rappresenta, in figura, il limite del pensiero, il suo incavo, il suo confine. Si mostra, insomma, la finitudine come orizzonte e limite della conoscenza. Ed è qui – in questa esposizione del limite, in questo pensiero che sa guardare il suo stesso confine, la sua impotenza, il suo vuoto – la soglia in cui poesia e filosofia si incontrano. Si potrebbe dire che la scrittura dello Zibaldone è essa stessa – nei suoi modi, nei suoi procedimenti, nel suo ritmo – figura del pensiero leopardiano. Del resto il pensiero poetante – espressione con la quale intitolai un mio libro sullo Zibaldone – definisce allo stesso tempo un modo della conoscenza e un modo della scrittura.
“… demeurer en repos dans une chambre” (Pascal, Pensée, 39): ci sono modi della scrittura che non tanto la forma-libro quanto lo spazio di una stanza possono raccogliere e definire. La severa torre-biblioteca di Montaigne, con le sentenze scritte sulle travi, la stanza di Pascal, schermo contro il divertissement della mente, la stanza di Valéry, visitata dalla prima luce dell’alba, la stanza – le stanze – dello Zibaldone leopardiano: sui fogli si allineano pensieri, dalla biblioteca degli antichi e dei moderni giungono idee, versi, storie, una “conversation souveraine” – per usare l’espressione di René Char – prende voce e segno grafico, facendosi intrattenimento e studio, margine e meditazione. In queste stanze i pensieri sfuggono ai sistemi da cui pure sono estratti, le letture si trasmutano in un’esegesi che è insieme commento e invenzione, filologia e racconto, i saperi si mostrano come liberati dal loro disciplinamento, dalle loro classificazioni, si contaminano e interrogano e sovrappongono, la teoresi si curva verso la narrazione, un ricordo va a posarsi nel lucente tableau di una definizione. Sul succedersi dei giorni e delle stagioni si accampa l’interiorità del soggetto scrivente, teatro mobilissimo, esposto a mille variazioni di luce. La vita non bussa da fuori, perché è già tutta dispiegata tra le pareti della stanza, e ha in sé tutte le sue spine e i suoi fantasmi. La scrittura quotidiana diventa esercizio (“exercice spirituel”, dirà Valéry), esplorazione di se stessi: “je suis moy-mesmes la matiere de mon livre”, dice Montagne sulla soglia degli Essais, rivolto al lettore. L’avventurosa peripezia tra le esperienze e i saperi e le teorie e i sistemi e le filosofie non ha che un approdo: se stesso (“car c’est moy que je peins”, dice Montagne). Le stesse forme dell’interlocuzione – in Montagne come in Leopardi come in Valéry – si rivolgono a parvenze di lettori che spesso hanno le stesse postille di colui che scrive. “La solitudine è il suo elemento vitale”, dirà Auerbach a proposito di Montaigne, ed è in questa solitudine che l’autore degli Essais, per usare ancora un’immagine di Auerbach, apprende a guidare il suo cavallo “fino all’orlo dell’abisso”.
In questo esercizio quotidiano di scrittura l’interrogazione della biblioteca, l’escursione teorica, la stessa narrazione non nascondono il disegno sotteso: attraverso lo sguardo su di sé leggere l’altro e la maglia dei rapporti che lo vincolano; e ancora, reciprocamente, attraverso lo sguardo sulla “condition humaine” – l’espressione da Montaigne arriva a Pascal e da lui a Leopardi, con in più una dilatazione dolente: “l’universale miseria della condizione umana” – attraverso lo sguardo sulla “condition humaine”, mettere a nudo se stessi. Qui, in questo disvelamento della nudità, si congiunge la cura di sé degli antichi con l’esplorazione della interiorità dei moderni. Marco Aurelio e Montaigne appartengono alla stessa disciplina. Appunto, Mon coeur mis à nu: Baudelaire prenderà da un passo di Marginalia di Poe l’insegna sotto la quale raccogliere l’aspra e amara e abbagliante meditazione per frammenti (“mes Confessions”, dirà il poeta in una lettera alla madre del 1 aprile 1861, delineando il progetto del libro).
Nello Zibaldone leopardiano la ricerca di questa nudità interiore ha una sua particolare tessitura: si accosta al romanzesco e se ne ritrae, spinge l’aneddoto verso la narrazione distesa, innesta il ricordo nella considerazione di costume, dà alle immagini dell’infanzia, alla loro ricordanza, l’attenuazione dell’exemplum, sapendo tuttavia quanto amara e irreversibile sia la loro lontananza. Memorie della mia vita: l’intestazione, che accompagna molti pensieri e apre una delle polizzine non richiamate, convoca sotto di sé nell’estate del 1827 i tanti frammenti disseminati nello Zibaldone. Il campo, così delimitato, di uno dei libri possibili, – possibili e mai compiuti – mostra come narrazione di sé e meditazione filosofica, attraversamento delle stanze della memoria e disegno di una filosofia – o antifilosofia – della vita quotidiana siano operazioni assai prossime e persino talvolta intrecciate. Sottratta agli statuti dell’autobiografia e dei Memoires, questa narrazione dell’esperienza si posa negli interstizi di escursioni teoriche e linguistiche, portando nella scrittura quel vento della vita che distingue l’essai dal trattato. In certo senso, l’autore di essais fa sempre “théorie de soi-même”, per dirla con Valéry, con il poeta, cioè, che fa risalire alla prima educazione dello sguardo, sul porto di Sète, la sua avventura intellettuale: “Mon premier amour fut l’architecture et celle des vaisseaux comme celle des édifices terrestres…”.
Ma non è solo della propria vita che l’autore di essais vuol dare la rappresentazione. E’ la vita dei viventi, di tutti i viventi – la lingua della physis senziente e sofferente – che nell’essai si fa scrittura, fino a mostrare la vanità della scrittura stessa, si fa pensiero fino a far percepire il confine del pensiero, il suo sporgersi sul nulla. E’ questo, poi, il cammino dello Zibaldone leopardiano: forma della scrittura e forma del pensiero hanno lo stesso ritmo. E’ questa pulsazione di vita la “verità” dell’essai, la sua intima tensione, la sua forma: così come il giovane Lukacs l’aveva descritta nel suo Die Seele und die Formen, così come l’avevano interpretata scrittori che sapevano ascoltare il suono della vita nel cuore della forma: Hofmannsthal, Benjamin. Quell’esperienza della vita che nella lingua della poesia si fa forma e ritmo, nella lingua dell’essai è ricerca, cammino, interrogazione. Per questo l’essai appare sospeso tra scienza e poesia. Nello Zibaldone leopardiano questo è vero anche nel senso che la lingua della poesia ha un suo alveo, dei punti di insorgenza, dei luoghi di rifrangenza. E questo non solo per il movimento che va dal notturno di Palazzo bello che apre la prima pagina (“Era la luna nel cortile, un lato / Tutto ne illuminava, e discendea / Sopra il contiguo lato obliquo un raggio…”) alla meditazione teorica sulla lingua della poesia, sui suoi statuti, sulla sua storia, sulla sua traduzione. Ma anche per il dialogo e per le corrispondenze che corrono tra lo Zibaldone e i Canti. La forma poi dell’aforisma, del “pensiero isolato” – come sono definiti alcuni lemmi delle polizzine per gli Indici del 1827 – si accentua nell’ultima parte dell’”immenso scartafaccio”: per sancire, si potrebbe dire, la definitiva frammentarietà, da che è abbandonato ormai sia il progetto del Dizionario filosofico sia forse anche il progetto dei trattati; e la forma-libro dei Pensieri si annuncia come la più propria, così come più irrinunciabile appare l’esercizio della poesia. Nel dilatarsi contemporaneo del ventaglio di temi e della distanza temporale frapposta tra pensiero e pensiero, nell’accentuarsi del salto concettuale e insieme della forma breve, del margine, dell’aforisma, dell’annotazione veloce e quasi improvvisa, è come se si annunciasse la fine della scrittura: non si tratta tanto di un’implosione della scrittura nel silenzio, quanto piuttosto dell’attesa di una forma che sottragga la scrittura al tempo del discorso, del di-scorrere, lasciandole tutta la profondità e lo spavento e il limite del conoscere. E’ la poesia questa forma del linguaggio, della conoscenza del linguaggio? Anche se quest’attesa può evocare il cammino di poeti-filosofi come Novalis o come Hölderlin, di natura diversa è la tensione e reciproca interrogazione che nel pensiero leopardiano corre tra poesia e filosofia. E tuttavia è proprio la poesia, nel pensiero leopardiano, a compiere l’ultimo balzo, per così dire. E’ la poesia a sporgersi, nel cuore della finitudine, sul nulla che delimita e anima e insidia il linguaggio.
La forma-essai, così come traspare nelle pagine dello Zibaldone – con il suo movimento che unisce narrazione e critica, esegesi e indagine morale, curiositas e ironia, journal intime e teoresi, erudizione e meditazione, saveur e savoir, direbbe Barthes – evoca, tra altri modelli più prossimi a Leopardi (da Madame De Lambert a Madame de Staël), Montaigne e i suoi Essais. Il rapporto di Leopardi con Montaigne appartiene all’ordine delle corrispondenze nascoste e tuttavia attive. Certo, nello Zibaldone Montaigne ha poche presenze: nominato due volte in un giudizio sui tempi di formazione della lingua francese, ritorna in un passo del 23 ottobre 1828 (Zib. 4416) per una frase del primo libro degli Essais che Leopardi riporta mostrando come poi essa sia ripresa in Pascal. La stessa frase, priva del riferimento all’autore, era stata già usata da Leopardi in un passo del ’21 (su questo si vedano le note dell’edizione Pacella, vol. III, p. 744 e p. 1086). Ma, al di là delle corrispondenze visibili – lo stesso accade per un’altra grande presenza, Vico – una raggiera di altre sostanziali corrispondenze si mostra, come in una sinopia: lo sguardo critico sulla civiltà europea e sulle sue forme di autocelebrazione, l’attenzione ad un’antropologia che si misura con la traccia animale e guarda a se stessa da punti di osservazione straniati, la conversazione con gli antichi e la filosofia della vita quotidiana, la natura per così dire esistenziale dell’esegesi del classico, lo studio accurato dei movimenti dell’io, il pensiero della finitudine e della vanitas, il sapere della morte, l’intreccio tra memoria soggettiva e discorso morale. “… en comptant toujours préluder…” dice Leopardi nel passo citato della lettera a Lebreton. Di che natura è questo preludio? Gli è davvero estranea la referenza musicale? Che cosa annuncia una scrittura costantemente occupata a fare slittare un genere nell’altro, una scrittura intenta, poeticamente e teoreticamente, a praticare lo scarto formale insieme con l’interrogazione ultima, mai acquietata nella definizione? In quale senso è preludio un’esperienza che ha portato il pensare sulla vertigine del suo confine e ha fatto della poesia l’estremo impalpabile profumo nel deserto della vita e nel sapere della mortalità? E’ forse a un modo della conoscenza e, nello stesso tempo, a un modo della scrittura che Leopardi accenna. Restare sulla soglia, in quella parzialità che secondo Baudelaire “ouvre le plus d’horizons”, accettare il non-compimento, fermarsi al di qua dell’opera, della sua pienezza, dei suoi convenzionali statuti: e in questa discrezione e grazia del sottrarsi che la conoscenza può evitare la superficie logocentrica del discorso e ascoltare quel che trascorre al di sotto e al di qua e oltre la geografia dei saperi. Già Montaigne aveva dichiarato il non compimento come proposito e metodo della sua scrittura (Essais, cap. L del primo libro).
Nello stesso spirito Valéry dirà di volersi sottrarre ad ogni “achévement”, perché esso è proprio del sistema, e dunque è ben lontano dal metodo che egli intende seguire, con “ostinato rigore”, nei suoi Cahiers. I quali egli definisce come
«Essais, Esquisses, Etudes, Ebauches, Brouillons, Exercices, Tâtonnements». E ancora, “travail… de Penelope”, “Broderie”. Tutte voci che ben si adatterebbero a una definizione dello Zibaldone (Del resto molte analogie corrono tra i tentativi di classificazione della materia compiuti da Leopardi nel 1827 e quelli fatti da Valéry sulle 6900 pagine dei suoi 261 quaderni: non a caso sia per l’uno che per l’altro è in gioco, a un certo punto, la prospettiva di un Dizionario filosofico, modello Voltaire).
Il preludio invita a guardare dalla soglia della parzialità e del non compimento le sconfinate regioni dell’inconoscibile: una relazione corre tra questa soglia e la “mesta landa” del notturno partenopeo, da cui lo sguardo del poeta muove, nella Ginestra, verso un’abissale fiammeggiante cosmologia.
Nel preludio si dischiude l’interrogazione del sapere, non il dominio sul sapere: la biblioteca mostra l’ombra della vanitas, la conoscenza il patto con il non-sapere, l’enciclopedia la fragilità della sua pretesa universalistica.
L’annotazione filologica, l’appunto al margine, la sequenza etimologica, l’aforisma, il margine esegetico, lo spunto polemico, il ricordo vanno a disporsi in un orizzonte senza definizione, in un teatro vuoto di scena: così nel bianco che separa un pensiero dall’altro traspare il mosaico impossibile, la tela interminabile. I rinvii che l’autore dello Zibaldone appone alle sue osservazioni, ai suoi appunti (rinvii al passato e al futuro di una scrittura) restano sospesi e anche le sequenze e i campi discorsivi scrupolosamente previsti nel lavoro sugli Indici, se disegnano la mappa di alcuni libri possibili – libri tuttavia di frammenti – danno a questa possibilità tutta l’energia e la grazia di un’esitazione: la verità di ciò che è sospeso, splendidamente, nella sua incompiutezza. Anche la dislocazione del proprio pensiero nell’anamorfosi di un altro sguardo – con l’acquisto di un punto di osservazione folgorante – permette all’autore di sottrarsi alla compiutezza della trattazione, restando per così dire sul limitare di una riflessione che per dirsi cerca uno schermo, una lontananza, uno straniamento. Questo accade, ad esempio, nella pagina 4175, dove la meditazione sul male come respiro ed essenza dell’universo si apre con la proposizione: “Si potrebbe esporre e sviluppare questo sistema in qualche frammento che si supponesse di un filosofo antico, indiano ec.”. Un pensiero che si sporge sull’estremo e che abita i confini si affida dichiaratamente alla forma del frammento e alla finzione di una lontananza – storica e culturale – che è come uno sguardo nello sguardo.
La vertiginosa meditazione è seguita, lo stesso giorno, prima dalla registrazione dell’uso di avisé per accorto e di être per osé (in Voltaire), poi dall’osservazione su come le Odi di Anacreonte comunichino un piacere “tanto fuggitivo, e così ribelle ad ogni analisi, che per gustarlo, bisogna espressamente leggerle con una certa rapidità e con poca o ben leggera attenzione”. Così, la considerazione sull’esistenza come male e lo sguardo sulla sofferenza della physis vivente (“Entrate in un giardino…”), l’osservazione linguistica e la sottile percezione esegetica si allineano, con i loro balzi di teoresi e di pathos, di invenzione e di gusto, sui fogli, stringendo nel loro cerchio di conoscenza il tempo esteriore, consegnando i giorni (dal 17 al 22 aprile 1822) e l’orizzonte della città (Bologna) ad una trasmutazione che la scrittura custodisce per un altro tempo, il tempo del lettore. Di questi movimenti vive la scrittura leopardiana dello Zibaldone. Nessun genere può, per questo, raccoglierla, nessuna classificazione la può davvero comprendere e ordinare. Ma proprio in questa ostinata sottrazione alle forme definite sta la sua splendente necessità.
(Da Lo Zibaldone 100 anni dopo. Composizione, edizioni, temi. Atti del X Convegno internazionale di studi leopardiani, Recanati-Porto Recanati, 14-19 settembre 1998, Leo-Olschki Editore)

 Calvino, la passione del visibile - Antonio Prete
Calvino, la passione del visibile - Antonio Prete L’Esordio - Enrico De Vivo
L’Esordio - Enrico De Vivo Prestare parola al desiderio.
Prestare parola al desiderio. Lettere a un giovane del XXI secolo - Enrico De Vivo
Lettere a un giovane del XXI secolo - Enrico De Vivo Letteratura e democrazia
Letteratura e democrazia Giardino, sera
Giardino, sera Antropologia del doppio
Antropologia del doppio Chirografie
Chirografie





















