
«La borghesia ha spogliato delle loro sacre apparenze tutte le attività fino ad allora onorevoli e considerate con pia umiltà. Essa ha trasformato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l’uomo di scienza in suoi salariati».
(Karl Marx, Manifesto del Partito Comunista)
Io insegno e scrivo. Mi hanno chiesto di aprire la Partita Iva. Ma io non sono un’imprenditrice, non intraprendo, non produco. Devo mettermi a produrre, ma che cosa? Io ho delle idee – ma non è che le produco. Non sono neanche del tutto mie, le raccolgo. Non è che le lancio sul mercato, al miglior offerente.
Non so nemmeno che cosa vuol dire Partita IVA. Guardo sul dizionario online:
partita: quantità di merce all’ingrosso (venduta o ricevuta); quantità numerica di entrate/uscite, in denaro dalle merci, di cui si prende nota.
Dallo spagnolo partida: che fa parte dei libri d’amministrazione.
Dal verbo partire: ripartire, dividere; le registrazioni del dare/avere riportate nel libro mastro.
IVA vuol dire: imposta sul valore aggiunto. Cioè c’è un valore che si aggiunge a quello ‘reale’ di una merce, e su quell’aggiunta io devo pagare un’imposta. Ma qual è il valore reale della mia produzione? Quanto vale un’ora di pensieri e di parole? Di comunicazioni preparate e anche improvvisate sulla filosofia?
Luca Pacioli nel 1494 scrive il trattato De computis et scripturis in cui perfeziona il conteggio di dare/avere, in modo da controllare quello che si prende e se valga la pena di dare per prendere.
Da quel momento in poi si contano le risorse che si spostano. La proporzione del vantaggio è sotto gli occhi del lettore di numeri. I numeri tornano ad essere il principio di tutte le cose, dopo che da tempo ci si era dimenticati di Pitagora.
Un modo semplice anche di fare la storia delle risorse, di non perderne di vista il percorso fino alla situazione presente. Vivere vuol dire fare i conti, fare di conto, tenere da conto, contare, computare.Vittoria di Leibniz che penserà, l’hanno capita che per pensare bene si deve calcolare…. Se si fa da conto non si litiga. Era ora forse che il pensiero fosse quantificabile e che si cominciasse a dargli un peso, cioè un contrappeso; sulla bilancia a due bracci, da una parte il pensiero dall’altra un suo valore di riscontro, lo scontrino della sua scambievolezza, o valore aggiunto. Si scambia pensiero con qualcosa. I pensatori devono ora contare sulla propria capacità di contare e dare riscontro, cioè scrutare gli effetti pratici del pensiero. Già intanto al computer computano il numero di parole, di caratteri. Non si esclude che inventeranno un libro mastro virtuale che in tempo reale, mentre scrivi, ti dice quanto vale quello che stai scrivendo, il suo valore effettivo e il suo valore aggiunto. Così potrai decidere mentre scrivi se prendere la strada assoluta della scrittura e del pensiero che sono scopo, non strumento, o quella sofistica della loro commerciabilità.
La prima strada, così parmenidea, è una follia, irrelata a ogni altra cosa, auto-referenziale, narcisistica; la seconda è infida, mercifica il pensiero. L’una pretende autorità, l’altra utilità.
Non si sa che cosa è peggio.
Prima di Pacioli e del sistema dare/avere, il patto veniva stipulato con una stretta di mano garantita dalla parola d’onore. Per vivere bisognava tenere alla parola d’onore come un marchio invisibile nel documento vivente del proprio corpo.
Ora il corpo si smarca, è un coadiuvante del calcolo scritto.
Osservo la mia vita a numeri, a proporzione di perdita e guadagno. Non è buona o cattiva, sbagliata o giusta, ma ha il suo giusto prezzo.
Tutto ha un prezzo, si dice. Non si può farla franca senza pagare. Le metafore accolgono la mutazione, senza residuo del qualitativo. Era troppo facile per il pensiero credere di essere gratis. Rischiava di essere fuori da ogni senso della realtà. Ora il pensiero fa il bilancio: è attivo e passivo. Fa una chiusura di bilancio (mensile e annuale). Fa la contabilità industriale del suo percorso: la contabilità industriale (leggo) è interna a un’azienda dove si descrive il passaggio e la destinazione di beni e materiali usati per la produzione. Cioè vorrebbe dire che le parole che dico e scrivo le posso seguire nei lettori e negli ascoltatori. Hanno una specie di braccialetto identificativo, come gli uccelli migratori, che ora sappiamo dove vanno e quando tornano. Le cose sono voci contabili. La voce si può calcolare nel suo passaggio di bocca in bocca.
La parola è l’elemento di una lista (di debito/credito).
Imparerò a vivere nella proporzione di debito/credito. O forse lo facevo già ma non lo sapevo? Felicità è andare in credito, serenità è andare in pari, angoscia è essere in debito. E malinconia è sentirsi in debito o in credito ingiusti?
Il prezzo della vita ora lo potrò riscontrare, grazie a una serie di scontrini; cioè lo scontro tra servizio o prodotto ricevuto e il pezzetto di carta che andrà a trasferirsi nella doppia partita, provoca la mutazione da un essere aleatorio esistenziale tutto proiettato verso un’indeterminazione elastica e illusa, in un essere finito, pieno di energia e senza dubbi, che sa quanto costa cosa, e userà l’energia di ritorno per una proiezione di sé statistica e fattiva. Faccio in base al calcolo, calcolo in base alle cose che riesco a fare. Restano fuori il superfluo del pensiero, la pigrizia indispensabile per l’errare mentale, l’inutilità della conoscenza suprema, come Aristotele chiamava la filosofia.
Ma se sono pagata per pensare e guadagno col pensiero, allora come si mette la cosa con la storia? Come quantifico il dare/avere delle filosofie di cui sono debitrice, dei pensieri antichi di secoli, anche più, che sostano per un attimo nella mia testa e nelle mie parole? Quanto pesano? Dove li metto? Nel dare? Nell’avere? Chi mi dà lo scontrino?
Il pensiero costa. Giusto. Il pensiero è gratuito. Giusto. Il pensiero è contraddittorio. Giusto. Un ologramma che appare e scompare dal computer che computa la sua presenza fluttuante temporanea. E’ una voce, una vocetta, che non pesa niente.
Leggo: Voce: da indoeuropeo: vak: chiamare, gridare. Suono che esce dalla gola.

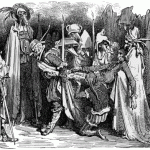 Filosofia della badante - Brunella Antomarini
Filosofia della badante - Brunella Antomarini Dialogo sul probabile automatesimo imminente (ovvero, tentativo automatico di assecondare la propensione delle cose in atto) - Brunella Antomarini
Dialogo sul probabile automatesimo imminente (ovvero, tentativo automatico di assecondare la propensione delle cose in atto) - Brunella Antomarini La barbona, o la dolce vita tra i morti - Brunella Antomarini
La barbona, o la dolce vita tra i morti - Brunella Antomarini Pensare in ascensore - Brunella Antomarini
Pensare in ascensore - Brunella Antomarini Il dio dei miei figli
Il dio dei miei figli





















