Prima parte
Roma, notte. Una via di traverso a via Merulana. Incrocio una vecchia barbona, elegante di modi e sorridente, valigia con rotelle e cappello di lana. Le ricambio il sorriso. Prima che io possa pensare qualsiasi cosa, mi viene una certezza: se questa donna vive, se esiste, se sta in una città, senza casa, allora è così che bisogna vivere. Non so che senso avesse questa impressione, che era meno di un pensiero, meno di un sentimento, più come una cosa che mi investiva, una statistica istantanea, una legge dei piccolissimi numeri, o della minoranza, dove conta non il valore medio, ma quello estremo, improbabile e irrilevante, il margine di errore di una curva gaussiana, utile solo al picco. È questo il modello, dice il mio calcolo d’improbabilità. Se questo è possibile, allora è anche vero. Non che mi si formulassero queste parole in mente, è solo che cerco di spiegare. È come se il sorriso di questa donna piena di dignità – perché è per dignità che sorride – cercasse di dirmi cose di quel genere, dice: nella città nei secoli distrutta e ricostruita, io sono quell’avvicendarsi. E dico che se io posso vivere, ti mostro quanto sia poca la tua vita presa nel comprare e guadagnare per comprare, nel vivere per comprare. Tu sei quello che compri, io sono io con quello che scarti dopo averlo comprato. Guardami, sono il tuo scarto, sono la prova che sei le merci che hai comprato e scartato. Sono te in seconda battuta, sono te come diventi, ogni volta che ri-compri, nella circolarità di buttare e ricomprare.
La barbona è inefficiente, non guadagna e non compra, è come lo Stato, quando vuole sostituirsi alle imprese. È morta all’efficienza, soprattutto se è una donna, che non ha nemmeno la forza fisica, che è la forma primordiale di efficienza. Cammina da sola di notte e sorride, per dire che neanche lo stupro potrà trasformarla in venditrice-compratrice. Non produce, nemmeno quando aveva una casa produceva, faceva il lavoro improduttivo di pulire e cucinare e accudire. Finito il marito, o la famiglia, o i figli, si trova in strada, al massimo dell’inefficienza. Non ha la fantasia di costruire, o inventare. Eppure è un bisogno fortissimo, che produce meraviglie e crea benessere, dall’acqua corrente, all’energia elettrica, alle auto e all’elettronica. Siamo queste cose, che ci fanno stare bene. Se non vuoi essere queste cose, sei la barbona. Non fare della critica naturalista, ambientalista, vegetariana, esistenzialista, anti-tecnologica, perché se lo fai, hai il dovere di essere una barbona. Una barbona donna. Ce l’hai questo coraggio?
L’invenzione è andata insieme alla competizione e chi non ha inventato niente o non ha i soldi per comprare le invenzioni, viene sacrificato alla città, diventa barbone.
Non abbiamo neanche lo sguardo adatto per il barbone, diceva Simone Weil. Facciamo finta di non vederlo, ci vergogniamo che la città l’abbia ucciso, la città mandante e noi cittadini esecutori.
In Italia, che è la terra degli inventori, si ride molto, ogni risata è un attestazione inconsapevole dell’inutilità di ogni intento di giustizia. Gli inventori inventano per gioco, non per utilità, e poi il gioco diventa utile nelle mani degli investitori. Distribuire il beneficio delle invenzioni, perché, se era un gioco? Perché, se era questione di investire soldi per farne altri? Non è mai stato un affare di Stato. E quando lo Stato vuole usare le invenzioni per scopi comuni, fallisce, per inefficienza, per sua inclinazione impiegatizia, anti-intraprendente. Non si salva nessuno e ogni ribellione è un suicidio. I giovani non si ribellano perché lo sanno.
La barbona è invisibile. Allo Stato, ai cittadini, agli imprenditori. Ma se la barbona sono io, quello che resta di me se mi si toglie di dosso quello che ho comprato, cioè tutto di me, allora sono invisibile anch’io.
È stato Adam Smith il genio che rendeva il dolore presente invisibile sfumandolo sempre di più nel futuro, lasciandolo sparire nel futuro. Eppure uno sguardo sull’abbandonato è tutto quello che basta a destrutturarci. Se lo guardo mentre gli do i soldi, gli rivelo che mi fa pena, e la pena è il peggiore dei sentimenti. Se lo guardo senza dargli soldi, lo insulto. Se mi fermo a chiacchierare, mi racconterà un sacco di balle per convincermi che il suo valore c’è, ma è stato calpestato. Dovrà costruirsi una storia che nasconda la sconfitta volgare, perché lì si aprirebbe una colpa che mi farebbe indietreggiare.
Seconda parte
Invece la barbona sorride: non serve, dice, che mi guardi. Dice che non è vero. Che se sorride, è per il carattere allucinatorio della realtà.
Abbiamo prodotto una civiltà grandiosa, da tutto il mediterraneo si è installata qui in Italia soprattutto, e l’abbiamo sparsa da qui nel resto dell’Occidente. Abbiamo sparso le menti di inventori ovunque – anzi li abbiamo mandati via e cacciati, cioè produciamo energia senza poi trarne profitto. Il profitto ci fa un po’ schifo. L’invenzione è un’arte, di cui vogliamo essere riconosciuti e ammirati, ma ci basta il riconoscimento. La macchina economica, amministrativa, politica, non ci interessa. Luca Pacioli inventava la doppia contabilità per il gusto di escogitare. Espediente è la parola dell’intelligenza dei peninsulari, costruttori per il piacere, non per il lavoro, gran lavoratori all’estero, dove la comunità è piccola e più facile. Costruttori senza mito della produzione. Barboni potenziali. Ma perché bisogna produrre? Qual è lo scopo del lavoro se non il piacere? La grande anomalia italiana dentro l’Europa è che siamo i soli a difendere questa formadi vita. I discepoli di Cristo avevano lasciato il lavoro e nessuno li accusava. E poi i monaci, o le congregazioni di scienziati, come i Gesuiti o i Minimi. Carismatici ambulanti. Poi emigranti, esuli, esiliati; e le donne poi, grandi madri e grandi mogli, pronte a emigrare anche loro, a inventare la buona vita in casa. Inventare stratagemmi per cucinare e vestirsi con pochi soldi. Fare e guardare quello che si è fatto, incantarsi a guardare. È per questo che si vive.
Roma poi.
Roma è un fermarsi, uno stare in verticale.
Non dover andare da nessun’altra parte. In ogni angolo ci ferma il resto di uno strato, tra innumerevoli strati di vita cittadina, vita funzionale una volta, ma che sopravvive come cosa inutile, bella e morta. Guardare in alto i monumenti che non sappiamo a chi furono eretti, le manifestazioni della superiorità del bello sul funzionale. Rovine riportate in superficie solo per dire che cosa c’era nascosto là sotto, solo per vedere quanti strati ancora di civiltà nasconde la terra.
In qualunque altro posto, troveremo funzioni. A Roma troviamo l’essenza della funzione, che è quello che resta quando non serve più.
Guardare e passeggiare, come morti tra i morti, la liberazione dal fare con scopo. Colori stinti d’atmosfera, forme deformate o dimezzate, stare fermi a guardare il processo entropico e quello contrario, in un’unica cosa. Roma ateleologica, città di barboni in fieri.
La città dei turisti, guardata soltanto.
La città dei mendicanti, usata, come una tregua in un ambiente nemico.
La città dei barboni, una città annusata, toccata, ascoltata, sentita e sofferta. La guardano da ogni punto. La loro città è un punto qualsiasi in ogni momento. Lei gli entra dentro e loro le esibiscono le loro storie, che portano sulle spalle; le hanno vissute solo per esibirle. Hannoun teatro assoluto dentro: attori e spettatori e scena. La quarta parete, il muro invisibile, un taglio con tutto l’ambiente. Un’indifferenza, un modo per rigettare quello che li ha rigettati. Ma un organismo non sopravvive senza ambiente. I barboni riducono l’ambiente agli odori, i suoni, le immagini, i sapori, i contatti della pelle. La città gli entra dentro con la pressione del marciapiede, col fritto e la benzina,col traffico, clacson e vocii, musica e luci dai negozi, umidità, smog, freddo e caldo. Non devono comprare niente, non guardano da una finestra, non hanno punto di vista, ma solo passaggi sfuggenti, pavimento, vetrina, muro, gambe di passanti, cartoni per la notte, roba da mangiare, cassonetto. Guardano per lo più in basso, non disperdono energia e non scambiano sguardi. La loro metropoli è piccolissima, l’immediato circondario del corpo, con il posto per dormire sempre quello, possibilmente, per il resto senza carattere né mappa. Non si lasciano schiacciare dai monumenti e dalle facciate, dalle cupole e dai grattacieli e le architetture nuove, aspettano che sia la città a chiamarli. E la città li chiama sempre, gli dà sempre qualcosa da mangiare e da dormire. Si incantano, per uccidere il dolore.
Terza parte
Vivere è incantarsi. È il diritto di incantarsi. Il diritto di mangiare (la giustizia) per incantarsi (la libertà). Adam Smith scambiava lo scopo (la libertà) per il mezzo (il lavoro). Karl Marx scambiava il mezzo con lo scopo (mangiare tutti non può essere lo scopo. Uscire dal disagio non dice niente sul valore del vivere).
Incantarsi è la superiorità dell’automatico sull’umano, sull’intenzione, sull’affanno dell’ottenere, della liberazione dei morti alla città.
Incantarsi è una lieve allucinazione, una libertà da se stessi, dimenticarsi di sé, di ogni sé ipertrofico che è la malattia dell’Occidente, di ogni fare preso per scopo, della mania dell’avere senza limiti, del prendere il massimo che si può, che è poi un comprare e vendere. Incantarsi è una sospensione del fare, o un fare inutile.

 Dialogo sul probabile automatesimo imminente (ovvero, tentativo automatico di assecondare la propensione delle cose in atto) - Brunella Antomarini
Dialogo sul probabile automatesimo imminente (ovvero, tentativo automatico di assecondare la propensione delle cose in atto) - Brunella Antomarini Requiem per la lingua italiana - Brunella Antomarini
Requiem per la lingua italiana - Brunella Antomarini La Partita IVA, ovvero del pensiero mutante - Brunella Antomarini
La Partita IVA, ovvero del pensiero mutante - Brunella Antomarini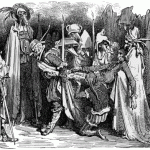 Filosofia della badante - Brunella Antomarini
Filosofia della badante - Brunella Antomarini Treno ad alta velocità
Treno ad alta velocità Il dio dei miei figli
Il dio dei miei figli Pensare in ascensore
Pensare in ascensore





















