
Gianni Celati ad Angri (casa De Vivo) nel 2009
Milan Kundera ha scritto una volta:
Oggi abbiamo imparato a sottomettere l’amicizia a ciò che chiamiamo le nostre convinzioni. E lo facciamo addirittura andando fieri della nostra rettitudine morale. Ci vuole in effetti una grande maturità per comprendere che l’opinione che difendiamo non è che un’ipotesi privilegiata, necessariamente imperfetta, probabilmente transitoria, che soltanto i veri ottusi possono far passare per certezza o verità. Al contrario della puerile fedeltà a una convinzione, la fedeltà a un amico è una virtù, forse l’unica, l’ultima.
Posso tranquillamente affermare che il poco che ho scritto, letto, tradotto fin qui, l’ho fatto per amicizia.
Credo che coloro che spendono buona parte della loro vita dedicandosi a quello che chiamiamo “letteratura” – qualcosa che letteralmente non esiste, esistendo di fatto solo le singole arti: la poesia, il romanzo, la novella, il saggio, il teatro, etc. – sospettino il significato di questa «virtù» che, secondo Kundera, è la sola a cui possiamo aggrapparci quando ci coglie il presentimento o la presunzione di possedere sane convinzioni.
Si scrive per qualche amico defunto che abbiamo conosciuto (Celati) o, in molti casi, per qualche amico defunto (Calvino) che non abbiamo mai conosciuto, ma da cui ci sarebbe impossibile separarci. Questo libro smisuratamente piccolo, scritto e rivisto per un periodo smisuratamente lungo, è alla fine un libro su un’amicizia, quella tra Calvino e Celati. Ma anche sull’amicizia come forma, forse «l’ultima», in grado di renderci meno scontenti e più in dialogo con il mondo, ovvero meno sentimentali e più sensibili.
Dopo tanto peregrinare sono giunto a convincermi che il «geografo» Calvino e il «viaggiatore» Celati, per quanto diversi, siano accomunati da quella vena che, nata all’inizio dei Tempi Moderni, ha segnato un po’ controcorrente fino al XX secolo la nostra civiltà letteraria fondata sulla dura legge della mimesis.
Parlo dello humor che Thomas Carlyle, parlando di Ariosto (caso pressoché unico tra i classici italiani), di Cervantes, di Sterne e di Jean Paul definisce: «il prodotto non del disprezzo ma dell’a-more, non della deformazione superficiale delle forme naturali, ma di una profonda quanto piacevole simpatia nei confronti di tutte le forme della Natura».
Entrambi, ciascuno a suo modo, «il viaggiatore» con cambi umorali serpentini ed estrosi, il «geografo» con cambi di passo lineari ma ogni volta sorprendenti, non hanno mai imboccato la via del novel; non hanno fatto finta che il lettore non esistesse né che l’autore fosse escluso dal gioco; non si sono arresi al vizio della trama; hanno mostrato senza pedanteria i loro procedimenti; hanno riflettuto sulla loro opera e su quella altrui diffidando sempre delle definizioni; hanno conservato quello «spiritus phantasticus», senza il quale l’esplorazione del mondo si priva del suo grembo immaginativo: Nihil potest homo intelligere sine phantasmate.
Entrambi tipi malinconici nati sotto l’influenza di Saturno, sono stati figli dello humor, di quello cervantino come di quello ariostesco, di quello che traspare in alcune opere di Giordano Bruno, nella Scienza nuova di Giambattista Vico o nella prosa di Leonardo e Galilei, di quello del Leopardi delle Operette morali e dello Zibaldone, come di quello che si incontra nelle passeggiate di Robert Walser e Raymond Queneau o nei quaderni di Paul Valéry.
Da sempre penso che l’amicizia sia preferibile alla verità.
Mentre la fedeltà a un amico si trasforma nel tempo in un’avventura, quella alla verità ci rende alla lunga arroganti, «ottusi», dei moralisti da quattro soldi. Chi, del resto, in tutta onestà può affermare che quello che sta scrivendo oggi, in questo momento, domani alla stessa ora non sarà già diventato carta straccia? Credo nessuno. Quanto a me sono la prova vivente di ciò che Pascal predicava: non c’è uomo che anche in un breve arco di tempo «differisca più da un altro che da se stesso».
Nel caso di Celati, forse ancor di più che in quello di Calvino, l’amicizia non designa soltanto una relazione umana, ma il suo stare al mondo e, di conseguenza, la forma del suo narrare.
Quando dico che in Celati l’amicizia è la forma del suo narrare non intendo utilizzare nessuna categoria teologica, filosofica, estetica della parola amicizia. Non voglio dire, cioè, che i suoi racconti, i suoi saggi, le sue traduzioni, i suoi documentari riflettono un’idea del mondo fondata sul principio dell’amicizia. Voglio dire un’altra cosa. Celati, quando scrive, si ispira all’amicizia, intesa come «profonda quanto piacevole simpatia verso tutte le forme della Natura». Cerca, in altri termini, di dare voce al suo nucleo affettivo, di essere amico dei luoghi e dell’umanità che lo circondano, senza distinzioni né gerarchie. Di più: cerca di mantenere un legame di simpatia con ciò che rende possibile questo stesso legame.
Ecco, qui forse emerge una differenza con Calvino.
Sebbene entrambi siano consapevoli che non c’è racconto se questo non trova risonanza in un altro essere umano, che nessun racconto diventa un’autentica scoperta se non ha le sue radici in una civiltà, in una comunità di lettori, in una compagnia di amici, in Calvino, innamorato del cosmo e maestro della via breve, la relazione con quel che c’è produce raramente un atteggiamento di incanto. Se per Celati, prima di colui che narra e prima del racconto, esiste un luogo dove un essere umano incontra altri esseri umani, per Calvino questo luogo, così apparentemente vicino e reale, è inaccessibile. Basta mettere a confronto qualche pagina di Verso la foce e i capitoli di Palomar dedicati alle vacanze del protagonista per rendersene conto. Calvino, detto un po’ rapidamente, non crede alle apparenze. E se è vero, come riporta Celati al capezzale dell’amico, che le sue ultime parole sono state «Vanni di Marsio, fenomenologo… le rette… le parallele», solo verso la fine dei suoi giorni Calvino avrebbe cominciato a studiare la fenomenologia. Salvo inventarsi il nome di un fenomenologo. Salvo aggiungere «le rette… le parallele». Non credo che lo studio di Husserl gli avrebbe fatto mutare il suo rapporto con il mondo. Il «geografo» umorista avrebbe continuato a preferire l’invisibile al visibile, il potenziale all’effettuale, la trasparenza alla nudità.
Se Celati, per me, è il poeta dei luoghi nelle cui opere il racconto diventa una «pratica di vita», Calvino è il poeta dei luoghi possibili nelle cui opere ogni racconto aspira a diventare «un’immagine del mondo». In altri termini, se per Calvino la letteratura ha il compito infinito di approssimarsi a quel che c’è, per Celati è un mezzo per aiutarci a contemplarlo. Cosa che comporta uno stupore davanti all’apparire fenomenico, davanti cioè al suo spectaculum. Tale stupore per l’infinita varietas del visibile non è estraneo a Calvino, solo che per lui non è sufficiente. Calvino guarda il mondo e, fino alla fine, vede «rette… parallele».
Un’ultima considerazione.
Nel corso del XX secolo, e in modo ancora più infantile in questo primo scorcio di XXI, due atteggiamenti artistici hanno continuato a coesistere: la ricerca del nuovo e il dialogo con il passato.
Per il primo la novità è diventata un imperativo non solo artistico, ma morale, politico. Per il secondo, il mai visto è frutto del già visto (Montaigne ha scritto: «Nous ne faisons que nous entregloser»), la novità è qualcosa che nasce dalla relazione incessante con le forme del passato.
Il primo, di conquista in conquista, ha raggiunto la sua tomba: ha trasformato l’arte in decoro dell’essere, in Kitsch. Il secondo non avrebbe nulla da temere – in fondo sopravvive dalle nostre parti dai tempi di Omero – se non fosse che deve costantemente giustificarsi di fronte alle pretese del primo: deve dimostrare la necessità del costante ritorno, mentre colonie di neoumani di prima, seconda, terza, quarta generazione vorrebbero continuare la loro corsa in avanti.
Il problema è che troppo spesso consideriamo il passato come qualcosa che ha generato il presente. Invece, il passato, e soprattutto il passato dell’arte, è fatto di possibilità compiute e incompiute, tanto che il presente artistico che viviamo è solo una possibilità fra molte.
La mia grande stima per Calvino e per Celati nasce anche da questo: non hanno mai smesso di conversare né con Lucrezio né con Giordano Bruno. Non si sono mai fatti contagiare da quel virus che riduce il presente ad attualità, che separa il presente dal passato con lo scopo di rendere quest’ultimo qualcosa di morto affinché noi, gli uomini di oggi, possiamo credere di essere qualcosa di nuovo, di diverso, di meglio, come se l’essere qui ora ci desse una patente di superiorità su quelli che ci hanno preceduto.
Celati e Calvino hanno seguito quella che Carlos Fuentes ha definito una volta «la buona lezione delle pietre»: il presente diventa incomprensibile senza la sua relazione di amicizia, di «profonda quanto piacevole simpatia», con il passato.
Tuttavia, in arte, essere amici del passato non significa rispetto assoluto per ciò che è stato. Non si può, in altre parole, dialogare autenticamente con il passato senza che la nostra operazione non provochi una qualche forma ludica. Da qui, l’irriverenza del narrare di Celati, i suoi numeri da saltimbanco dell’anima, da qui l’ironia di Calvino, la sua inesauribile carica fantastica.
Con Celati e Calvino si ride. Ma anche questo riso è un’eco.
*
Brighton, 26 aprile 1995
Caro Massimo Rizzante,
grazie per la lettera. Mi dispiace di sentirla un po’ desolato e forse in un vicolo chiuso. Le cose si fanno per noi stessi, perché se scrivendo non si sbattesse la testa contro il muro delle difficoltà, chi mai potrebbe aiutarci? Spero dunque che i suoi studi su Calvino trovino un canale di navigazione. Qualcosa succederà. Non dico come fatto editoriale, ma come suo percorso di vita a ostacoli. Benedetti ostacoli!
Quando, nell’ultima lettera, le dicevo che non me la sentivo di “fare lo scrittore” né mi sentivo di esserlo, volevo dirle che ci sono tante altre vie nella vita, oltre a quelle più strombazzate. La letteratura come fatto istituzionale, come campo di privilegio sociale, come gara di reputazioni critiche tra “scrittori”, per me non conta niente. Non per disprezzo, ma per lo stesso motivo per cui non conta niente, ad esempio, una squadra di baseball in Nuova Zelanda.
Non si deprima con tutte queste faccende che, viste un po’ a distanza, sono ridicole. Continui a leggere, a scrivere, a studiare, perché quando si legge e si studia (senza questioni di affermazione di mezzo) grazie a Dio si diventa almeno un po’ UOMINI PACIFICI.
Suo, con saluti – Gianni Celati

 Racconti e altre sorprese letterarie - Redazione
Racconti e altre sorprese letterarie - Redazione Idee per un Almanacco del viaggiatore - Gianni Celati
Idee per un Almanacco del viaggiatore - Gianni Celati Swift, profetico trattato sull’epoca moderna - Gianni Celati
Swift, profetico trattato sull’epoca moderna - Gianni Celati Note sulla novella “I lettori di libri sono sempre più falsi” - Gianluca Gigliozzi
Note sulla novella “I lettori di libri sono sempre più falsi” - Gianluca Gigliozzi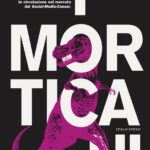 Francesco Maino, o la lingua impossibile
Francesco Maino, o la lingua impossibile «Smettere di lavorare per gli uomini»?
«Smettere di lavorare per gli uomini»? Prosa, poesia, maschio, femmina
Prosa, poesia, maschio, femmina L’onore dei poeti
L’onore dei poeti






















Vi ringrazio.
Un grazie a Gianni Celati pe il bene che ha fatto con il suo passaggio qui.
È vero: la personalità e l’idea di scrittura di Gianni Celati pervadono da sempre “Zibaldoni”. Grazie per aver voluto ricordare in questo modo un Maestro come lui.