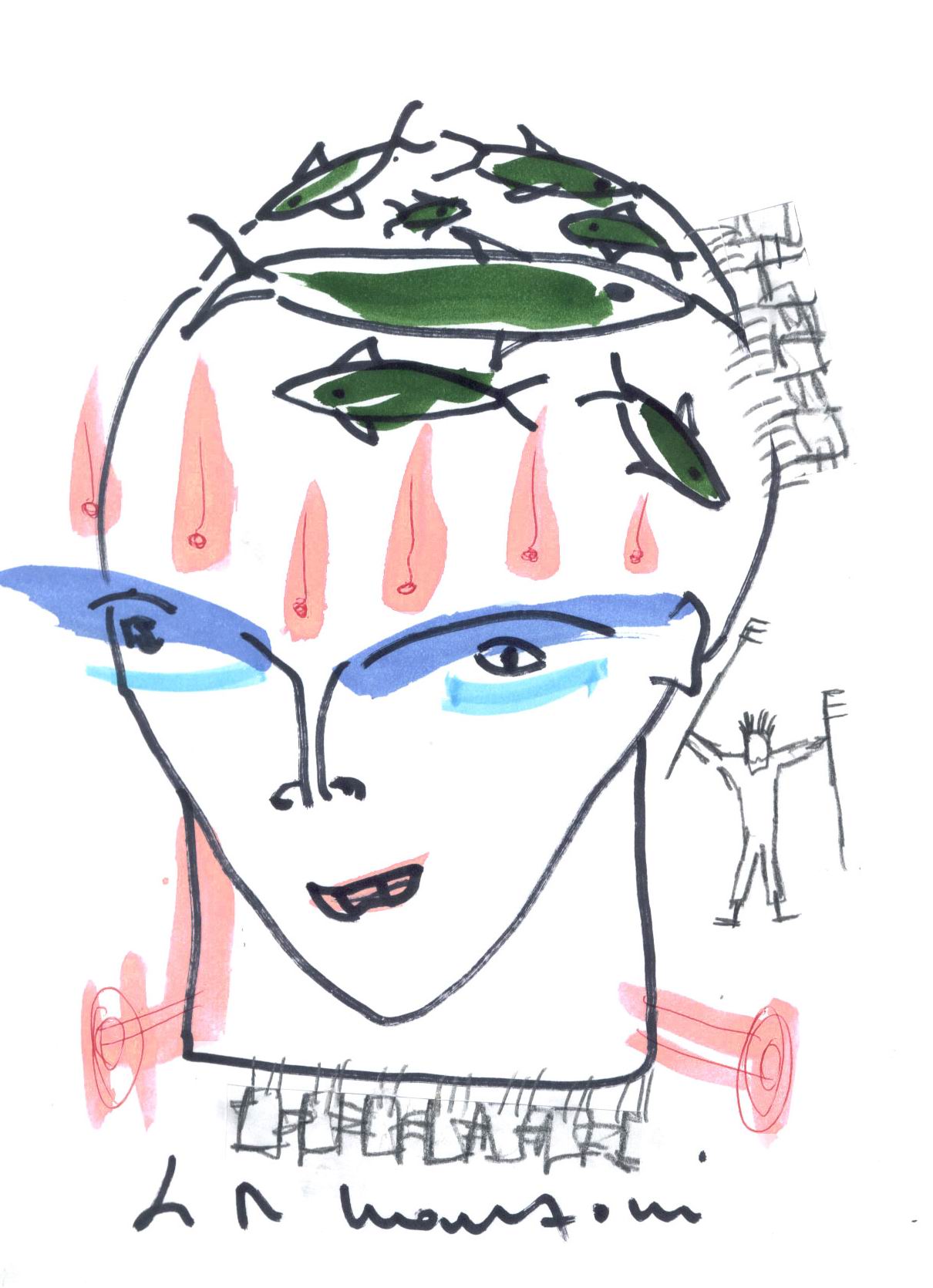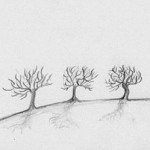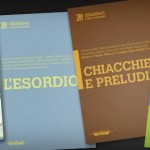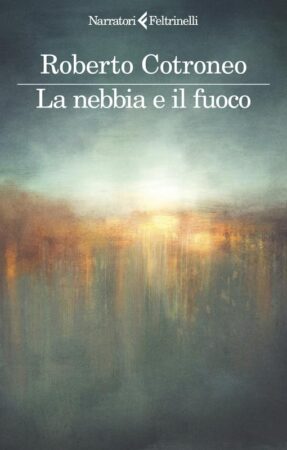
“Ci sono molti modi per rileggere quel tempo e poi scriverne. Quello di tutti è di trasformarsi in un investigatore letterario”. Effettivamente, se si volesse fare una ricognizione sulla letteratura della post-Resistenza (di chi cioè non l’ha vissuta direttamente), si potrebbe iniziare con la presunta rivelazione di crimini occultati nei (non) romanzi di Pansa, constatando poi quanto il giallo sia stata una modalità ampiamente usata dagli anni Novanta con Lucarelli (Un’estate torbida, 1991) fino ad oggi, comprese le narrazioni dove la dominante è un’altra (si pensi a Wu Ming 1 Gli uomini pesce). Perfino uno scrittore eccentrico e raffinato come Michele Mari in Verderame (2007) ne fa uso; e in fondo anche la biografia (solo di quest’anno Iris di Veltroni e La ribelle di Van Straten) rientra in quel “paradigma indiziario”, teorizzato da Carlo Ginzburg, di una ricostruzione letteraria a base storica. È pur vero che, saltando la programmatica indicazione dei temi da parte dell’autore che viene prima anche delle epigrafi, l’inizio de La nebbia e il fuoco (Feltrinelli, 2025) sembra condurre il lettore proprio in quella direzione. Roberto Cotroneo, tornato alla natia Alessandria, si sente dire en passant dall’amico libraio Gepi sul loro professore Aldo: “Ah, lui era una testa calda. Si dice che partecipò a una spedizione dove venne ucciso un colonnello. Anche se doveva essere soltanto un’azione dimostrativa.” Si tratta appunto di un attentato, che doveva dissuadere il tenente colonnello Salvatore Ruggeri, troppo zelante nel convincere ex-ufficiali ad entrare nell’esercito di Graziani: alle 19.30 del 13 dicembre 1943 in piazza Biffi, sul lungofiume di Alessandria, ci sono tre gappisti armati di bombe SRMC, le cosiddette Balilla: una va fuori bersaglio, una non viene proprio lanciata, un’altra colpisce alla schiena il fascista, uccidendolo. Bene, Aldo era tra loro: ha centrato il bersaglio, portandosene per sempre con sé il peso, l’“orrore” del Kurtz conradiano, gli incubi notturni di Jim Hawkins, che per nulla al mondo tornerebbe sull’isola del tesoro; o invece è quel terzo che si è rifiutato al lancio e che il giovane storico della Resistenza Giampaolo Pansa ha lasciato anonimo in una nota a piè di pagina?
L’autore legge la testimonianza del gappista Carlo Gilardenghi, consulta il fondo Pansa dell’Istituto storico della Resistenza in città e i libri dei memorialisti locali, all’insegna del “timore di restituire un dramma”, scruta una foto del dopoguerra in cui, tra gli ex-compagni partigiani Aldo “sorride ma in modo discreto. Non è a disagio e neppure a suo agio. Sembra arrivato da un altro mondo […] dentro storie che non sono più le sue”. Dunque il meccanismo dell’indagine sembra in verità innescato, eppure fa cilecca; il libro scivola verso un’inconsistenza di salde tracce sempre più rivendicata:
Mi sono illuso, o credo di essermi voluto illudere che questa storia potesse stendersi su un tavolo come fosse una mappa, una carta geografica con i nomi delle persone, le loro posizioni, i luoghi. E anche la giusta percezione delle cose, del modo in cui avvennero. Per poi rimettere in ordine e raccontare. Ho mandato delle lettere, ho fatto delle domande. Mi è stato risposto. Ma più diradavo la nebbia di queste storie e meno rimanevo ad Alessandria, più provavo a chiarire e più le verità si allontanavano.
Qui Cotroneo pare arrendersi ad un’impossibilità, altrove sembra invece una sua propria deliberazione non molestare i familiari, evitare l’arroganza dell’inquisizione. Sostanzialmente in linea con la forma sfuggente del libro, che quasi si crea da sé: “non un racconto, non un romanzo, non un saggio, ma un testo che si compie dentro uno spazio di pagine e di legature, con una copertina, un titolo, delle note, un ordine ancora tutto da stabilire”. E allora il lettore passa ad un’indagine di secondo grado: perché l’autore non vuole concludere, perché non ci prova più? Si tratta di un cascame di una posizione debole e postmoderna di fronte alle maiuscole della realtà, della verità e della storia, o, al contrario, incarna una ferma posizione etica? Intanto è necessario introdurre il terzo personaggio del romanzo dopo l’autore e Aldo, ovvero la città di Alessandria.
Da lì “per decenni sono scappato”, dichiara Cotroneo, con la fantasia prima e poi fisicamente, perché “prosastica”, “paratattica”. Piatta morfologicamente, apparentemente senza botole o sottotesti, tutta stesa sotto un cielo “cenere chiaro”, come la maglia dei Grigi dove giocò, senza grandi riconoscimenti locali, Gianni Rivera. E, al contempo, assorbita nel presente, in largo anticipo, si direbbe, rispetto a un sentimento oggi dominante; capace di rimuovere la “storia scomoda” del suo feroce squadrismo come la portata imponente della sua Resistenza (5680 partigiani, di cui 600 caduti), di demolire manufatti significativi quali la ciminiera dello stabilimento Borsalino, recante il logo blu di Prussia; di stravolgere, peggiorandoli senza fallo, i luoghi della propria identità. Qui l’autore, certo non ingaggiato dal cittadino ente di promozione turistica, sebbene lontano dalla furia d’un Bernhard per la bassa Austria o di Gadda per la Brianza, non è meno chirurgico nel suo killeraggio, desolato e velenoso. Distante in ciò dal suo maestro Umberto Eco, che apriva Il costume di casa, scoprendosi abbastanza fiero “di una città senza retorica e senza miti, senza missioni e senza verità.
Dunque la normalità diventa “un buco nero” che risucchia tutta la luce, e l’antica nebbia, dalla fenomenologia polisemica, tende a spegnere presto il fuoco, per fare un facile gioco di parole con il più celebre romanzo dell’autore, di chiunque, ma specie dei giovani. Così un conflitto tra partigiani e repubblichini nella nebbia che “dilatava il fuoco, e i colpi del mitragliatore erano stelle pulsanti dentro un universo sconosciuto […] La nebbia spegneva il fuoco e la morte si allontanava come un’ombra.” Tornando alle vane inquisizioni del lettore: la nebbia, oggi neppure più presente, ha ingoiato l’autore di ritorno, revenant egli stesso, visto che “ad Alessandria il passato è un disagio, un inciampo, quasi un fastidio. Non resiste niente. Le piccole storie consumano sé stesse.” Certo questo libro si colloca anche sotto il segno del rimpianto di non aver risposto alle lettere del professore, di non aver stretto o mantenuto i rapporti, come per un padre non interrogato a fondo (o come per la madre, si dice qui). “Alle volte la timidezza diventa disattenzione, disaffezione, perfino abbandono”; sentenza amara e verissima. Insomma la nebbia, che “ti nasconde, ti difende”, rischia pure di farti scomparire come un alieno omino di fumo, di sommergerti all’improvviso come un’invasiva marea “di goccioline infinitesimali”. E se elimina un’ingannevole nitidezza, può condurre fino all’annichilimento del soggetto.
Così Aldo, il professore incrociato cinquantunenne nell’ottobre 1975, sempre impeccabilmente vestito con un principe di Galles e rasato, che non interroga, né dà voti, ma preferisce, passeggiando in obliquo tra i banchi, lanciare domande chiaramente provocatorie per dei liceali: Chi ha letto Sterne, Joyce, Eliot, Jonesco e Beckett? E non Brecht; e nemmeno Pavese o Fenoglio. Eppure è stato un partigiano ma non ne ha mai parlato con gli alunni e, come il Bobi Bazlen inseguito da Daniele Del Giudice in Atlante occidentale, non ha mai scritto una riga. Rispetto alle figure magistrali, molto corporali ed eloquenti, di Monti e Cocito nel Partigiano Johnny, Aldo tende allora sbiadire: Cotroneo ci dice la sua eccezionalità di intellettuale, docente e partigiano che, fuggito dopo la denuncia di “un amico” sui monti è diventato comandante (“Poldo” come Leopold Bloom) della VIII Divisione GL nei pressi di Ovada, ma il lettore non lo vede. Come spesso, dove prevale il telling sullo showing, il personaggio non ci graffia né ci incide in profondità.
D’altra parte, in questo libro tanto inafferrabile, la scelta etica di Aldo appare ferrea e chiara, seppur piena di stile (in questo simile a quella de I piccoli maestri di Meneghello). Non ha scritto probabilmente “per rispetto, per non stare in prima fila”; o forse perché “stare dalla parte giusta non consolava, morire da eroi non piaceva a nessuno, ed essere gettato in un mondo che chiedeva libertà anche al prezzo delle armi non consolava […] Erano uomini che non parlavano, quelli. È che non volevano più voltarsi.” Non ha parlato di sé partigiano forse perché, come sosteneva Walter Benjamin, era più importante “la via lunga” della grande letteratura che la predicazione ideologica, tanto pericolosa negli anni di piombo, e la esposizione narcisistica tipica dei nostri giorni. Il personaggio vive lo stesso destino, volatile e saldo, della sua parabola non chiarita dall’indagine, tormentata nella coscienza e nella memoria dell’autore, come avviene per un’altra investigazione mancata nella letteratura partigiana. Ovvero quella, tutta interna al racconto, di Milton sull’amore e l’amicizia; eppure per Calvino si tratta del miglior romanzo italiano sulla Resistenza. Così come questo libro che, nonostante l’uscita nel fatidico mese d’aprile, è qualcosa di meno e nel contempo di più che un romanzo sulla Resistenza.

 Tempi tolkieniani - Alberto Volpi
Tempi tolkieniani - Alberto Volpi Quel che resta della scuola - Alberto Volpi
Quel che resta della scuola - Alberto Volpi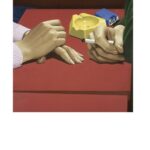 Certe sere Pablo - Alberto Volpi
Certe sere Pablo - Alberto Volpi Le strade della poesia dialettale - Alberto Volpi
Le strade della poesia dialettale - Alberto Volpi Moresco ricreato
Moresco ricreato Versi verdi
Versi verdi Nel cuore del Novecento
Nel cuore del Novecento Versi in vacanza
Versi in vacanza