
a Lorenzo Renzi
“Una cipolla germoglia nel vuoto dentro una scatola o dentro un cassetto, allarga le sue radici nell’aria come il mio cuore i suoi uncini nelle mie costole. La radice boccheggia disperatamente nell’aria, soffoca lentamente nel frigorifero, i suoi inutili germogli verdi continuano a mettere radici nell’aria. Non ho più carne in me ma aria muffita e il cuore inesorabilmente non fa che buttare ghirigori, non fa che fiorire nel frigorifero scassato. Così:
<†††>SPICEREVIDEOREAMSOLITVDINEMNIHIL<†††>NISIIPSAMHO<†††>BILISANIMIINTENTIONEMINPERPETVIS<†††>IBVSQVEDANDISETRE<†††>”
T***Š B****K: (Mezzo legge dai taccuini di Sommariva, come sopra e cfr. infra, mezzo divaga, come qui) “Curiosamente, fin dal suo primo mutilo apparire, non si levarono (quasi) voci contrarie: l’origine (altri preferì parlare, per la delizia della sparuta manciata di chiamiamoli ontologi o dato che sono sparuti ontomani ancora in circolazione, altri preferì parlare di destinazione) non poteva essere che ciceroniana: parevano e forse in effetti erano cioè diciamo sono cogenti gli evidenti echi con certa sbruffoneria dubitativa (quel “(per)spicere videor” che non poteva non richiamare il De amicitia – il meduseo trattatello su quel qualcosa che i Romani chiamavano “amicizia” e dal quale si esce letteralmente terrorizzati dai propri amici, prima della lettura persone (forse) in carne ed ossa e dopo – verrebbe da fare degli strilli pubblicitari per il libretto con illustrazioni vintage di generici amici prima e dopo – e dopo la lettura irreparabilmente statuizzati in congiurati, in weapons, ovvero la loro facies ora per sempre acciaiata, splendore di lame balenante nella pozza degli occhi, ma poi che ci volete fare, è sempre così, nessuno ovvero che poi è lo stesso quasi nessuno ormai più si pone seriamente il problema di quanta cautela sia necessaria per scoperchiare una lingua morta, ovvero, un tantino cinebrividendo, se non hai un corteo di fantasmi pronti a difenderti il nostro cioè il mio abbastanza disinteressato consiglio è di lasciarla stare), né mancò chi volle auscultare in quella “intentionem in…” la, flebilissima quanto si voglia, pulsazione ossessiva e diciamo pure paranoica che aprendo crepe poetiche nel dettato ovvero nella toga (sì perché i più faceti qui infilavano – ogni volta – l’abusato Suet. Claudius 15, 3, stigmatizzando per primi con cenno blasé – ogni volta – l’abuso nonché l’anacronismo, roba da bloccarli in un vicolo e sfondargli la faccia con un bastone di ferro) piega di golosità le labbra dei centellinatori, quale io mi pregio di essere, delle angosce arpinati. Cicerone, dunque: e per la precisione (di nuovo quasi all’unanimità) l’orazione Pro Milone. Né del resto può essere un caso: Pro Milone, un’orazione per un capobanda, un terrorista, insomma diciamolo chiaro e tondo che poi tanto si sa che è lì che andavo cioè vado cioè andiamo sempre a parare: un (quasi cantando e dirigendosi con l’indice) an-ti-Ro-bin-Hood. La perla in bocca al porco. Un’orazione inesistente, silenziosa: silent enim leges inter arma… tacciono le leggi… non è poetico? Tacciono le leggi… sembra l’inizio della descrizione di un tramonto inglese. Chiaro, parlava di sé stesso (niente di più facile da capire, con lui: qualsiasi sia la cosa di cui parla alla fin fine è di sé stesso, tanto che diresti che tutta la storia romana non è che una sua allucinazione o se preferite una serie di sedute di psicanalisi, e qui sta il punto, no? è di questo che stiamo parlando, no?): lui, la legge, tace cioè non riesce a parlare di fronte a avversari armati fino ai denti, e quindi per essere precisi diciamo balbutiunt enim leges… le leggi cioè lui balbettava(no) per il terrore, e lui non è poi riuscito a dire l’orazione, e Milone quando l’ha letta pare gli abbia detto che fosse stata effettivamente quella l’orazione pronunciata sicuramente avrebbe vinto lui, e noi cioè io qui riconosciamo una sfasatura analoga a quella prodotta da NITA™, ma nella storia e non nel gioco, lo capite l’inghippo? Abbiamo l’orazione vincente ma l’imputato è stato condannato. (Si guarda intorno; nessuno ha capito niente) Silent leges. Eam solitudinem. (Dai posti a sedere arriva un paio di canonici imbarazzati colpetti di tosse). Almeno concedetemi che Cicerone che si impappina terrorizzato da Pompeo ricorda moltissimo il Cappellaio Matto quando viene interrogato dalla Regina di Cuori, scommetto che anche lui come il Cappellaio ha fatto un salto tale da perdere i calzari… Pompeo cioè è diciamo una specie di Regina di Cuori psichica di Cicerone… che poi l’uomo assassinato da Milone non era anche lui un travestito?– ma sto divagando. Nella storia e non nel gioco, eppure pensateci cioè ripensateci: la storia romana come allucinazione cioè seduta di terap—- ma qui o divago o corro troppo o tutt’e due, fatto sta che mi sembra di parlare ai sassi. Dunque (sospiro; si pinza il setto nasale; mima sbrigativo un repulisti). Ribaltiamo tutto. Silent leges inter arma, ma anche silent arma inter leges, cioè le armi tacciono dentro la legge, ovvero restano silenziose come animali feroci nella foresta, il silenzio dell’agguato, cioè il lurking… Sentite come silent è il silenzio del serpente? Siiiilent… (sbisciando timidamente con l’indice). Il silenzio delle cose vive, mentre le leggi non sono che un vegetale, roba mezza viva e mezza morta, così è la lingua delle vere leggi, perché se fosse solo viva che razza di leggi sarebbero, e se invece fosse solo morta… No? Ancora niente? Ripartiamo daccapo. Poligenesi onirica. (Fruga o finge di frugare tra le carte di Sommariva). Allora. Ecco qua: Sommariva nel corso della seconda lettura dell’esemplare onirico della Pro Milone ricostruisce il passo così: Sic autem mihi perspicere uideor eam solitudinem nihil aliud nisi artem quandam esse uel ipsam horribilem animi intentionem in perpetuis cursibus cogitationibusque dandis et recipiendis, cioè per chi non mastica o non ama masticare lingue morte, la solitudine è l’arte orribile di tessere in andirivieni archi e fili tra parete e parete del proprio cervello o giù di lì, ovvio che Cicerone non poteva parlare di cervello, al m— ma sto divagando. Sommariva poi anche lui si perde (ma poi se non ti perdi che razza di filologo sei, la vera filologia consiste nello smarrimento, nel sabotaggio…) a chiedersi di chi possa essere la solitudine, se di Milone, di Clodio o perché no della sua anima o della sua sarta, o magari di Cicerone stesso, chiuso tra parete e parete della testa della Regina di Cuori a filare come un ragno, non senza sottolineare, chissà poi perché, le (uso parole sue, cioè del Sommariva) “ossidature baudelairiane, spleenetiche del passo”, e si capisce che doveva tirare fuori Baudelaire, e non vede quello che ha sotto gli occhi, l’indecisione cioè del Cicerone onirico tra ars e horribilis animi intentio, tutta una teoria estetica che ti si spalanca davanti e lui signornò che si mette a cacare il cazzo con le ossidature, ecco che tipo era il Sommariva. (L’avvocato di T***š B****k a quest’ultima uscita si riscuote dal torpore giuridico, appoggia una mano sudaticcia sul collo di B****k e gli bisbiglia qualcosa di indistinto e congestionato). Era o è, sì, va bene, tanto ormai che differenza fa… (il mormorio di protesta dell’uditorio copre le frasi che seguono) e sì che in una prima ricostruzione, poi rifiutata, la sua équipe, cioè di Sommariva, era passata per un honorabilis al posto di horribilis, e a un impalcatorio (e poi rifiutato per problemi stilistico-grammaticali che vi risparmio) Sed tamen ea solitudo nihil aliud esse uidetur nisi ars quaedam siue ipsa horribilis animi intentio in perpetuis cursibus conuersionibusque dandis et recipiendis, nel quale horribilis avrebbe potuto essere anche l’animus oltre all’intentio, e dove si fa più scoperto il legame con De legibus I, 24: più scoperto e insieme più blando, perché ciò che nelle leggi è celeste (tale è il messaggio implicito della versione definitiva con quel cogitationibus) si ripiega poi in parete del cranio quando l’uomo viene lasciato in solitudine, e così nella più squisita versione finale una conuersio come niente si trasforma in una cogitatio… tacciono le leggi, in Inghilterra o in Jugoslavia o dove vi pare tramonta il sole, e le lame, come dicevamo, e le lame siiiilent… (pollice in traiettoria secante sotto la carotide; pandemonio di proteste da parte dell’uditorio di familiari di vittime del videogioco NITA™… …omissis… riprende la lettura dei taccuini superstiti di Sommariva) “Uno degli inganni più terrificanti dell’arte del racconto è la manipolazione del tempo e la mutilazione degli attimi – mutilazione che, a confronto con le nostre giornate, ricoperte di uno strato intricato idiota e lardoso di minuti, ha l’apparenza di un perfezionamento. Tale arte della mutilazione degli attimi raggiunge il proprio vertice nel cinema. Il sospetto che la cosa centrale sia quel che avviene tra un’inquadratura e l’altra, che il montaggio abbia lasciato fuori la parte più importante. Ricordo che le mie prime fantasie erotiche riguardavano la mutilazione di una donna. Avevo visto lo spettacolo televisivo di un mago che chiudeva la sua assistente in una speciale cassa a scomparti, e poi con dei fogli d’acciaio ne tagliava la gambe, le braccia, la testa, che continuavano a muoversi nei loro scomparti come se volessero fuggire o come le code di lucertola appena mozzate, guardando di qua e di là (la testa) o tastando le pareti dello scomparto in cui erano rinchiuse (le braccia e anche le gambe); quando il sipario scendeva sul prestigiatore, la donna era ancora a pezzi, e le varie scatole con la testa, le gambe, le braccia, disseminate in vari punti del palcoscenico. Sognavo spesso, la notte, di avere simili scatole per fare a pezzi una donna lasciandone vive le parti; avrei tenuto solo il torso o, nel caso non fossi riuscito a farla a pezzi o a procurarmi le scatole adatte, avrei trovato il mago e gli avrei chiesto di farmi dono del torso, o gliel’avrei rubato subito dopo che fosse sceso il sipario; avrei tenuto il torso e il resto l’avrei gettato, avrei liberato le gambe in un bosco e avrei appeso le mani su una sporgenza nella roccia come pallidi pipistrelli, o le avrei lanciate in mare. Ero convinto che le braccia sapessero nuotare, da quando avevo letto nei Vangeli che se la nostra mano ci scandalizza dobbiamo gettarla nell’abisso, e quando avevo chiesto a mio padre cosa fosse l’abisso lui mi aveva detto che è il mare talmente profondo che uno continua ad andare verso il fondo ma non arriva mai o quasi mai, e che l’acqua è talmente profonda che non passa più la luce, e io dicevo che l’acqua è trasparente e lui rispondeva che niente è del tutto trasparente sulla terra, e nello stesso tempo niente è del tutto non-trasparente. Io non capivo e allora lui mi fece vedere una foto ai raggi x. Della testa non sapevo che farmene. Il pensiero dei baci mi sembrava idiota o schifoso, e poi la testa mi avrebbe potuto guardare male o protestare mentre toccavo le tette al torso. Raggi x. Con gli occhi giusti, anche la carne non è che acqua trasparente. Man mano che crescevo, aggiungevo nuovi pezzi al mio torso di donna: la gambe prima, poi le braccia e infine anche la testa. Più che aggiungerli li accettai. Non so perché da bambino amassi solo il torso della donna e volessi sacrificare tutto il resto. Ricordo che non mi piacevano nemmeno i capezzoli, e che avrei voluto un torso con dei seni perfettamente lisci, come natiche. Volevo solo i torsi e il resto l’avrei gettato via, in questo simile al tempo, che a molte antiche statue ha riservato un trattamento simile, sparpagliandone le membra. Michelangelo stesso, si dice amasse molto un torso greco o romano, e che a volte stesse lungo tempo abbracciato a quel torso, nel quale a tratti gli pareva di distinguere il pulsare di un cuore, il movimento di un respiro, attribuendo alla pietra i palpiti del proprio cuore che vi era poggiato, e nell’errore immaginava che cuore e respiro fossero entrati nella pietra. Ricordo che mio padre si divertiva a ingannarmi con il vecchio gioco del pollice che si stacca dalla mano. Avrei desiderato moltissimo avere la falange di mio padre, e più volte gliela chiesi in prestito. Volevo esaminare il punto del taglio che immaginavo come un fascio disordinato di sottili vermicelli o tubicini colorati. Un giorno, vidi lo strillo illustrato di un libro dell’orrore; vi era ritratto un uomo – o forse una donna – che con una pesante mannaia si amputava una mano. Il movimento della mannaia era stato talmente violento che la mano era schizzata in avanti, verso l’osservatore, e se avesse continuato la sua corsa gli sarebbe volata in faccia. Ricordo che dal momento in cui vidi quell’immagine fui perseguitato dall’idea di mozzarmi una mano. A volte la tentazione di cedere a quell’impulso perverso era, o mi pareva, irresistibile, tanto che pensavo che avrei potuto persino alzarmi nel sonno, andare in cucina, poggiare la mano sul tagliere… la sola idea, sebbene oggi mi sia del tutto indifferente, allora mi riempiva di orgasmo, e non avrei osato per nessuna ragione al mondo prendere in mano la mannaia, pensando che il solo luccichio livido della sua lama larga come uno specchio mi avrebbe costretto a procedere con l’amputazione. A quei tempi studiavo violino, e un simile incidente avrebbe letteralmente troncato ogni mia speranza di un futuro lavoro nel campo della musica. Probabilmente il mio cuore si era già staccato dal violino, e l’immagine gli aveva dato l’unico appiglio perché anche la mia anima accettasse una buona volta quel distacco. Il linguaggio del cuore è come quello di un malato mentale. Una volta facevano le corde con budella feline. Come dire tutta questa fatica per far fischiare il buco del culo di un gatto. Non che sia simbolico, è semplicemente menomato o straniero, e deve farsi capire con i pochi oggetti che gli vengono lanciati nella cella toracica in cui è intrappolato: come vi comportereste voi al suo posto? Vista dalla prospettiva del cuore, l’amputazione è ciò che apre il primo spiraglio per l’evasione. Il cuore vuole solo accasciarsi su sé stesso, scivolare fuori da un taglio con un morbido plop e lì rinsecchire, essere tagliato a fette e arrotolarsi in ricci su una graticola. La solitudine è l’arte terribile di tendere fili tra parete e parete del proprio cervello. La solitudine è l’arte di tessere archi impressionanti tra le pareti dei propri pensieri. La solitudine è l’arte di costruire tendere archi impressionanti terribili archi fili terribili tra le pareti dei propri attraverso i pensieri attraverso il lungo le pareti del proprio cervello. L’estrema varietà di posizioni non ancora eretiche delle prime chiese europee. L’inizio della diffusione e dell’espansione, l’iniziale stato incontrollato, germinale. Un intero romanzo costituito di singulti narrativi il novanta per cento dei quali verrà considerato eresia… storie dendritiche, stilitiche, isolate in deserti, non raggiungibili da nessuno se non per caso o per allucinazione. Un intero mondo ridotto in tale stato dall’uso dei macchinari dell’architetto. I primi sintomi di tale disgregazione nella cosiddetta filologia onirica.” (Chiude di colpo il taccuino di Sommariva) Ecco, alleluia, l’ho trovato: filologia onirica. L’edizione sommariviana della Pro Milone onirica è iniziata proprio nel momento in cui il passo sulla solitudine è stato come dire mormorato in sogno (l’équipe di Sommariva concordava nel definirlo un brusio dalla qualità urticante, ed è per questo che la nostra équipe ritiene diciamo accettabile, non ancora però plausibile, un rapporto con la possiamo chiamarla così? équipe di tester del videogioco NITA™ attualmente in (gesto delle virgolette e sorrisino, come si può dire? western…) “cura” (pandemonio peggio di prima… …omissis… e nel frattempo per raccattare giusto qualche pezzo anche una NOTA PER IL LETTORE: Il Sommariva di cui in futuro sempre qui, o altrove, fa lo stesso, si annuncerà una più approfondita recensione è un editore del respinto e del rimosso, appassionato e incoerente difensore della Gerusalemme riconquistata da un lato e del Fermo e Lucia dall’altro, pio raccoglitore dei mesti avanzi di editing selvaggi, agguerrito filologo delle varianti rifiutate, e chi più ne ha di questo passo più ne metta; a una giovinezza irta di delizie amorose, quasi tutte ça va sans dire fantasticherie, si devono le due “Buffonesco-hitleriane” <sic…>: edizioni “ultracritiche” <…e ri-sic> dell’Eneide e dei romanzi incompiuti di Kafka, progettate sotto forma di attentato ultrafilologico avente come obiettivo il rogo dei più antichi manoscritti dell’Eneide e degli originali kafkiani, la cenere come obbedienza per così dire perinde ac cadaver al troppo sotto- (o sopra-, comunque di nuovo fa lo stesso) -valutato demone dell’ultima volontà; arenatosi al pari di questi diciamolo cioè ditelo pure deliri di gioventù, l’ultimo progetto di Sommariva prima del ricovero in seguito all’edizione criticonirica del “Diario” (edizione attualmente sotto sequestro e di cui a proprio rischio legale i creatori della trasmissione radiofonica I figli del Capitan Visiera stanno dando o hanno dato o daranno pubblica lettura): progetto di una immane Storia delle attenuanti dall’antichità ai giorni nostri, ovvero un regesto ragionato di tutte le attenuanti nei maggiori sistemi giuridici eurasiatici a partire dall’antichità; ma di questa Storia delle attenuanti si dirà più e meglio altrove. Venendo alla filologia onirica, T***š B****k non sembrando intenzionato a prendere come dire il bandolo per le corna: tale forma aggiornata di oniromanzia si manifesta in modo esplicito la prima volta per l’appunto nel passo pseudo-ciceroniano di cui sopra, che a quanto pare viene sognato e annotato sui rispettivi cahiers sia da Sommariva che da Giorgio Valmarana, nella forma lacera riportata in maiuscolo all’inizio e in seguito pubblicato su compiacenti riviste “specialistiche”; la portata di tale primo episodio secondo chi scrive (sì ma chi è che in effetti scrive?) è attenuata dalla brevità del lacerto nonché dalla presenza del nome di Valmarana, consumato e forse patologico millantatore; ciò non toglie che allo pseudo-Cicerone ha fatto poi seguito la già citata stesura del “Diario”, di cui maggiori dettagli in seguito; placandosi nel frattempo il pandemonio, chi scrive (chiunque egli o ella sia) si congeda provando a chiarire che questa nota vuole o avrebbe voluto essere il cuore, per quanto possa apparire superficialmente estranea al corpo, dell’opera (qualunque cosa, non per insistere, ma qualunque cosa possa ormai essere un’opera). E poi: in un “ordine” fuori da qualsiasi ordine, fuori cioè dalla vita, ovvero in una lingua morta, il cuore e il sistema di vene e capillari radicato nella nostra carne non potrebbe più facilmente apparire come un corpo vegetale alieno, un pulsante parassita della carne? Prova ne sia la nostra più completa incapacità di sentire le vene e il cuore: sono organismi a noi estranei. Ma forse tutto il nostro corpo intero non è che l’accozzaglia di organismi estranei mescolatisi insieme in una sorta di groviglio che nei primordi dovette essere guidato da falotici impulsi, se non erotici, quanto meno gravitazionali, come dire. Un fiore tropicale installato nello stagno semovente della nostra carne, un angelo ramificato e divoratore da cui siamo posseduti e il cui gemello, del quale siamo altrettanto inconsapevoli, è il sistema nervoso. La stessa oscura gemellanza che unisce le due metropoli avversarie di Waltzwaltz e di Schwarzschwarz, le labili metropoli in cui sempre più vaste zone sono finalmente libere dall’architettura. La stessa impenetrabile estraneità che riguarda tutto ciò che ci compone in strati talmente profondi da non essere più nemmeno nostri. Né si creda che qui si vogliano adombrare fantascientifiche origini aliene, remoti meteoriti piovuti da recessi astrali nei quali prima della nascita del sistema solare era fermentata ad opera di chissà chi la vita in forma di ramificazioni pulsanti che non attendevano altro che il fango adatto in cui installarsi… La fantascienza da stazione dei treni, i libretti gualciti e quasi mai effettivamente letti se non nel dormiveglia traballante che precede l’incontro con l’amata, le attuali lamine sacre in cui si disperde il pensiero religioso contemporaneo ovvero vale a dire stringi stringi le favolette sub rosa delle quali celare ciò che poi generazioni di teologi si occuperebbero di dipanare e poi altrettante generazioni di nobili guerrieri e mercanti di portare a realtà… Ma forse anche qui stiamo divagando, per quanto possa essere possibile divagare laddove non c’è nessuna strada ovvero dove ovunque se si guarda bene è stato tracciato un sentiero, per quanto delle dimensioni di una sinapsi, di una strutturazione venosa microcapillare… Le metropoli avversarie e speculari dei nostri sistemi nervoso e circolatorio pronte in qualsiasi momento a contrarre il loro reticolo, ragnando in irrimediabile slancio ectopico fuori dal fango della nostra carne; ma di questo più in là; ora, chiuso il pandemonio e riaprendo le carte di Sommariva) Due neon difettosi tintinnavano alternativamente ad ogni periodica incandescenza, producendo un intervallo di semitono acuto, come bicchieri lontani o grilli fantascientifici. A volte le due note si sovrapponevano, ma non a intervalli regolari. Mi cullavano. Da quanto tempo era che non stavo un po’ solo con me stesso. Non è come abbandonare un orto, che quando si torna si trova una piccola giungla. Quando si abbandona sé stessi per un po’ e poi si ritorna, è come entrare in una camera vuota, perfettamente linda, come se nessuno vi fosse mai stato prima. Se si aspetta troppo si torna e si trova un interno con piastrelle bianche ai muri e uncini ai soffitti. Restano solo le pareti mezzo diroccate, come dire i bisogni primari: mangiare, defecare, dormire, respirare, bere, urinare e soprattutto controllare le pulci ai propri simili e farsi controllare le proprie, sono queste le nostre pareti, ed è come se avessero portato via tutto il resto, e il pensiero di dover ancora una volta arredare questa casa mi riempie di noia, e ogni volta sarà una noia maggiore, tanto che alla fine mi accontenterò di quei quattro vecchi mobili che gli incursori avranno infine risparmiato, perché inutili. Scrivo, e subito l’idea che sto occupando la mente con qualcosa di estraneo al compito che mi è stato affidato (l’enorme compito che mi è stato affidato e che sono ancora ben lontano dal concludere; forse non lo concluderò mai; forse è questa la reale essenza del mio compito) mi getta nel più completo e disorientante sconforto, sconfortato disorientamento, e mi pare di scrivere come sul fondo di un abisso marino, ogni centimetro del mio corpo schiacciato dalla pressione di centinaia di migliaia di metri cubi d’acqua. L’angoscia mi fa sembrare di essere conficcato in un blocco di ghiaccio, di dover scrivere incastrato dentro un blocco di ghiaccio. Solo un tremulo angolino di carta bianca, come una farfalla mezzo spiaccicata, sbatacchia impazzito sotto il vento polare; solo due dita della mano destra, morbidi bruchi rosa, sbucano dal corpo dell’iceberg e, quasi del tutto insensibili per il gelo (so bene che presto si staccheranno dalla mano e rotoleranno in acqua come due fiches sul tappeto verde) con le ultime forze, afferrano la penna e cercano di avvicinarla all’angolino di carta sfarfallante. Il corteo di geni e folletti che accompagna sempre anche il più austero e inespugnabile monoteismo, pulviscolo fiabesco e urticante in cui si sbriciola o si urtica ogni fede. Una solitudine talmente prolungata che infine gli uomini ci appaiono come una continuazione di nostri pensieri o incubi, e con altrettanta noncuranza vengono archiviati. Ben presto noi stessi, tastandoci o guardandoci allo specchio, abbiamo la sensazione di star guardando nient’altro che un pupazzo di stracci. Una lingua morta che è morte… …storie dendritiche, stilitiche, isolate in deserti, non raggiungibili da nessuno se non per caso o per allucinazione; pulviscolo urticante… …una cipolla germogliata nel vuoto.”
***
“Antiche natiche, hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi!”
[continua l’11 dicembre]
[L’autore desidera ringraziare la latinista Clara Lotti, cui si deve l’evocazione dello pseudo-Cicerone di questa puntata]


 Presiden arsitek/ 4 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 4 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 7 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 7 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 3 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 3 - Angelo Angera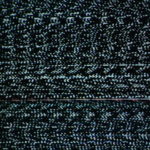 Presiden arsitek/ 21 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 21 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 36
Presiden arsitek/ 36 La bambola regina
La bambola regina Presiden arsitek/ 6
Presiden arsitek/ 6 Presiden arsitek/ 33
Presiden arsitek/ 33





















