
Nel romanzo Stanza 411 (Einaudi 2006) la voce narrante esordisce dicendo: questo scritto ti dispiacerà, provocherà in te irritazione. Credi sia questo il compito della letteratura, disturbare il lettore?
È una delle possibilità, ce ne sono tante e diverse, dipende dall’autore, dal lettore. Sicuramente sondare territori inconsueti, cercare di guardare oltre le porte chiuse, i muri, reali o metaforici che siano, mi sembra una di quelle più interessanti. Offrire speranza non è la stessa cosa che scrivere con un intento consolatorio.
Un tuo tema ricorrente è l’infanzia, segnata da paura, dolore, violenza, mai serena o felice. Come mai?
La grande scrittrice americana Flannery O’Connor scriveva che “chiunque sia sopravvissuto alla propria infanzia, possiede abbastanza informazioni sulla vita per il resto dei propri giorni”. Sono abbastanza d’accordo con lei. L’infanzia è una delle zone dell’esistenza umana più ricche, interessanti e vivide e tra l’altro raccontare attraverso lo sguardo infantile permette a un narratore di liberarsi di tanto cascame e di tanti pregiudizi.
Altro tema presente nei tuoi libri è il corpo, spesso ferito. Cosa rappresenta per te e nella tua scrittura?
Tutto, attraverso il corpo si vive e dunque si scrive e si fa azione politica.
Come racconti nel tuo ultimo libro, Parla, mia paura, oltre che della psiche, attraverso la psicanalisi, ti sei presa cura del tuo corpo con un intervento di chirurgia estetica al seno. Credi che l’identità di una persona dipenda anche dal corpo?
Come potrebbe non essere così? Non ho mai conosciuto un’entità intelligente priva di un corpo, persino Dio ha dovuto incarnarsi in Cristo e nel suo corpo ferito, mortale, per portare agli uomini il suo messaggio.
Cosa ti ha spinto a scrivere un libro così scopertamente autobiografico?
L’idea che la mia piccola esperienza personale con gli attacchi di panico e la depressione avrebbe potuto essere di conforto e aiuto per chi stesse vivendo un periodo di difficoltà simili.
Nel corso della tua attività la paura è stata un ostacolo o in qualche modo ti ha aiutata?
Entrambe le cose.
Scrivere ti ha aiutata a combattere le tue paure o a tenerle sotto controllo?
Scrivere – così come leggere, anzi il leggere ancora di più – mi ha sempre aiutata a comprendere meglio me, gli altri, il mondo che mi circonda, a trovare parole precise, ma anche ‘belle’ per spiegarmi e spiegare le cose.
Nel romanzo Come prima delle madri (Einaudi 2003) si legge: “Scrivo, ma dentro la testa le frasi suonano molto più belle. Quando le metto sulla carta sono morte, non hanno lo stesso fiato di prima.” Quanto è difficile dare forma all’immaginario?
È una sfida continua, ogni volta che cominci un testo nuovo riparti da zero, non sei mai su una corsia preferenziale e senza ostacoli e non puoi e non devi affidarti a ciò che già sai. Almeno, per me, è così.
Come scrivi? Parti da appunti preparatori, ti fai una scaletta, parti dai personaggi?
Dipende, ogni testo ha una genesi diversa e una sua storia, faccio tutto e il contrario di tutto. La scaletta arriva quando il materiale che ho accumulato diventa un magma dal quale non riesco più a sollevarmi, ma non amo sapere troppo, mi piace che la scrittura mi sorprenda. Se sapessi nel dettaglio ogni singolo snodo del romanzo che sto per scrivere non lo scriverei.
Com’è nata l’idea, realizzata col romanzo La prima verità (Einaudi 2016), con cui hai vinto il Premio Campiello, di raccontare il manicomio dell’isola di Leros?
Da molto tempo avevo in mente l’immagine di una ragazza che si addentrava nelle onde di un mare in burrasca. Era ancora di spalle, all’inizio, e si avvicinava all’acqua come fanno tutti, poi all’improvvisò l’immagine nella mia mente cambiò e vidi che la ragazza si girava verso di me, procedeva all’indietro e si lasciava inghiottire dal mare, fino a sparire. Sentivo il bisogno di raccontare di come, in certi momenti della vita, ci si possa allontanare dagli altri e da se stessi fino a non sapere più chi si è né se si vuole ancora essere qualcuno o qualcosa. Questo tema aveva a che fare con me e con tante delle persone che avevo avuto e che avevo vicine. Disagio psicologico, disagio psichiatrico, depressione, malattia mentale, diversità: con tutte le gradazioni e le sfumature del caso. Nel 2009 in un sito di psichiatria mi imbattei in una testimonianza anonima che raccontava un periodo di volontariato trascorso nell’istituto psichiatrico dell’isola di Leros, Grecia, all’inizio degli anni Novanta: un’esperienza straziante, durissima, che quella voce raccontava con una sincerità e un dolore disarmanti, aveva visto con i suoi occhi cosa significa annientare altri esseri umani, per incuria, incapacità, disinteresse. Vidi allora le immagini scattate a Leros da Alex Majoli negli anni ‘90 quando la deistituzionalizzazione era già cominciata e poi quelle scattate prima di lui da Antonella Pizzamiglio, la giovane fotografa che con le sue immagini rubate contribuì a cambiare la storia di quell’istituto lager alla fine degli anni ’80 in contemporanea ad un servizio della BBC inglese che aveva fatto diventare il manicomio di Leros uno scandalo internazionale. Leros è un’isola dalla natura incontaminata, l’isola di Artemide, dei Cavalieri di San Giovanni di Rodi, che porta però su di sé il marchio di tutti quelli che l’hanno “usata” (gli italiani come avamposto verso l’Asia e “base navale e militare” durante la seconda guerra mondiale, i greci come isola lager per dissidenti politici malati e malati di mente; oggi è una delle isole del Dodecaneso che maggiormente devono fare i conti con il continuo arrivo di profughi da Siria e Iraq principalmente ed è stata trasformata in un hot spot. Credo che ci siano luoghi che attirano per misteriosi motivi un certo genere di accadimenti, come fossero i luoghi a generare le storie delle persone e non viceversa; quando ho scoperto cose stesse accadendo a Leros l’anno scorso e che i tanti rifugiati che di lì passavano venivano ospitati nelle stesse strutture in cui ai tempi venivano ospitati i ‘matti’ e i dissidenti al regime dei colonnelli non mi sono stupita più di tanto.
Come mai l’hai costruito con una voce narrante che alterna finzione e autobiografia?
L’io narrante che apre e chiude il romanzo in realtà è arrivato quando avevo quasi finito di scrivere le altre parti, non volevo un io narrante ma si è imposto e da quella imposizione ho compreso quale fosse il motivo per cui, dal momento in cui ero venuta a conoscenza della storia dell’isola di Leros e del suo manicomio non avevo più potuto smettere di pensarci.
Nel romanzo ci sono diversi protagonisti: Angela, Teresa, Basil, Stefanos, Nikolaos. Da quale personaggio sei partita per costruirlo?
Teresa è arrivata per prima.
Il titolo del libro proviene da un verso del poeta Ghiannis Ritsos, deportato nell’isola durante il regime dei colonnelli. Il personaggio di Stefanos si ispira a lui?
Sì. Ho usato con un po’ di timore materiali veri della sua biografia, ma traslandoli nel tempo e modificandoli, spero sia evidente che il mio voleva essere un omaggio e non un furto, e infatti le poesie del poeta Stefanos, che è il personaggio del romanzo a lui ispirato, le ho scritte io e non possono competere con i versi meravigliosi del vero Ritsos.
Possiamo considerare il libro come un omaggio alla poesia, visto che la narrazione è intervallata da diverse poesie?
È un omaggio a tutti quelli che confidano nel potere della parola di creare e mutare il mondo, nonostante siano silenziati e oppressi da poteri che li vogliono zittire.
Era la prima volta che scrivevi poesie?
Scrivo poesie da sempre, ma non sono abbastanza brava per dirmi poeta. Come lettrice, amo forse la poesia sopra ogni altro genere letterario.
Nell’isola di Leros oltre ai malati di mente venivano reclusi gli oppositori al regime dei colonnelli. Oltre al dato storico, c’è una ragione per cui li hai messi insieme, incrociando le loro vite?
Il dato storico è fondamentale e non è un caso che nello stesso luogo di confino e reclusione siano stati esiliati tutti gli scomodi, quelli considerati inutili o ancora dannosi, pericolosi, come se si potesse fare una selezione degli umani e decidere che valga la pena e chi no.

 «Nessun delitto è più interessante di un racconto riuscito» - Giovanni Accardo
«Nessun delitto è più interessante di un racconto riuscito» - Giovanni Accardo Traumi e vittime nella letteratura contemporanea - Giovanni Accardo
Traumi e vittime nella letteratura contemporanea - Giovanni Accardo Il meccanismo incompiuto della letteratura. Intervista a Domenico Starnone - Giovanni Accardo
Il meccanismo incompiuto della letteratura. Intervista a Domenico Starnone - Giovanni Accardo La letteratura è un dialogo infinito - Giovanni Accardo
La letteratura è un dialogo infinito - Giovanni Accardo «Uno scrittore è sempre un asociale». Intervista a Massimo Rizzante
«Uno scrittore è sempre un asociale». Intervista a Massimo Rizzante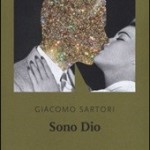 Se Dio si spoglia della sua onnipotenza
Se Dio si spoglia della sua onnipotenza La letteratura e la vita. Conversazione con Eraldo Affinati
La letteratura e la vita. Conversazione con Eraldo Affinati Intervista a Romolo Bugaro
Intervista a Romolo Bugaro





















