
Milos Crnjanski pubblica la sua prima raccolta poetica, “Itaca”, nel 1919, appena tornato dagli sconvolgimenti della guerra. E quando nel 1959 ne cura una seconda edizione, in cui ad ogni poesia segue un commento autobiografico, aggiunge alcuni testi, tra cui “Sumatra”, scritta nel 1920. Sono, questi versi, e il loro commento, il manifesto della poesia modernista serba e il preludio a “Lamento per Belgrado”, edito in Italia alla casa editrice Il Ponte del sale (Rovigo), nella bella e accurata collana “Il Labirinto del mondo”, tradotto e curato da Massimo Rizzante. “Sumatraismo”, con quel suo riferimento all’isola dell’arcipelago indonesiano, è un termine che trattiene un richiamo esotico, o comunque di forte alterità, e stupisce ritrovarlo come definizione della poetica di un autore serbo. Occorre allora fare un passo indietro, e capire dove e come genera la scrittura di Crnjanski. Quest’autore, poco noto in Italia in virtù di una colpevole penuria di traduzioni (a parte la pubblicazione in due volumi di “Migrazioni” per la casa editrice Adelphi) testimonia, attraverso la sua tormentata biografia di esiliato, il destino comune di migliaia di slavi respinti, oppressi, espulsi, attratti da una patria ora grembo, ora matrigna. Popolazioni, e perciò anime, letteralmente divise in due, sospese, come sottolinea Massimo Rizzante nella sua prefazione, tra la rivendicazione idealizzata della propria terra e un concreto desiderio di essere accolti al banchetto del mondo. Ma ecco il testo di “Sumatra”:
Ora che siamo privi di preoccupazioni, sentimentali e leggeri, pensiamo:
come sono silenziose, sotto la neve,
le cime degli Urali.
Se siamo tristi per il pallore di un viso che abbiamo perduto,
lo sappiamo: da qualche parte, al suo posto,
scorre un ruscello imporporato!
Un amore, all’alba, in un paese straniero,
avvolge la nostra anima e la stringe,
nella pace infinita di mari azzurri,
dove il corallo abissale rosseggia
come le ciliegie della mia terra natale.
La notte ci svegliamo, e sorridiamo
alla Luna e al suo arco argentato,
accarezzando teneramente con la mano
le colline lontane e i monti innevati.
Ciò che sprigiona da questi versi è una luce cristallina, la forza di una visione coraggiosa ed inclusiva, suggerita attraverso lievi tocchi di colore e vere e proprie “capriole”, nello spazio e nel tempo. Il dolore della guerra, l’esilio patito per decenni e la diffidenza (se non l’ostracismo) al suo ritorno in patria consentono a Crnjanski di sviluppare una riflessione sul destino dell’uomo che non elude la memoria, anzi, si prende carico delle origini della civiltà europea, interrogandone persino le opere d’arte, le pietre che le compongono, la materia fisica che testimonia questo accidentato e millenario percorso. Se i risultati poetici brillano per levità, e l’apertura dei sensi percepisce i legami più sottili tra lo stato emotivo del poeta e le forme assunte dalla natura (nuvole, mari, cime innevate), altrettanto rilevante in “Sumatra” è la sensazione di pace che comunica la fusione incantatrice di ricordo, presente e immaginazione. In questi versi si percepisce una maturità vissuta fino in fondo, così straordinaria da apparire come una nuova infanzia senza tempo, uno sguardo vergine ed ironico sulle cose, l’unico che permetta di abbracciarle tutte lasciandole alla loro integrità, di contemplarle con stupore e distacco. Come è possibile che una biografia così tormentata, come quella del poeta slavo, abbia ispirato uno sguardo così profondamente umano e al contempo tranquillo? Mi soccorrono le parole che Massimo Rizzante ha pronunciato durante una presentazione dei primi due libri della serie “I costumi degli italiani” di Gianni Celati (parole che valgono quindi per più di un autore), riferendole a Celati stesso: un essere vivente che scrive, è diverso da uno scrittore che scrive. Questo a dire che una sorta di comunicazione estatica e democratica con tutto ciò che c’è, ha una lunga tradizione, che Celati stesso fa risalire a Sant’Agostino, e poi a Holderlin, ad esempio. In Crnjanski si percepisce precisamente questo, come tutto ruoti in un legame unico, come tutto sia animale, cioè animato, e ogni creatura sia presente l’una all’altra in una comunione fluida e pulsante, che, si badi bene, non significa amnesia o perdono, e che non è moralmente connotata. Come spiegare poi che questa sensazione, ma sarebbe più corretto definirla visione,
io l’abbia reperita identica in altri testi, lontani geograficamente ma non solo, quali quelli di FederigoTozzi o di Robert Walser? Una commozione fisica (dal suo etimo cum-motus, qui nel senso precipuo di “muoversi insieme”), che si comunica al corpo e lo scuote, la quale davvero credo contraddistingua gli “esseri viventi che scrivono”, e i loro lettori, e che vorrei definire con le parole di Celati: il prodigio di una consonanza generale. Ciò che è straordinario (o forse è solo necessario) è il fatto che, in “Sumatra” e nel “Lamento per Belgrado”, questa consonanza venga cantata da un poeta il cui destino è stato l’erranza e il mancato riconoscimento delle proprie radici, ai margini sia del dibattito letterario jugoslavo che degli ambienti culturali inglesi durante il soggiorno londinese. E proprio nel canto dedicato alla sua città e composto nel 1956, dove Crnjanski poté tornare, dopo venti anni di esilio, solo nel 1965, si realizza pienamente la sua aspirazione a tessere legami invisibili con un tutto che si fa oltre la storia, per dirla con le parole di Massimo Rizzante, per entrare in contatto con il ritmo originariamente non storico e non umano dell’universo. La struttura stessa del poema rimanda alla frattura in cui si è consumata la vita del poeta espatriato: da un lato sei componimenti che, attraverso una voce elegiaca ed ironica, trattengono il saldo legame con la cultura europea, con le avanguardie e le città visitate, scegliendo frequenti stranierismi, mentre le rime, meno cogenti e regolari, assecondano un ritmo più franto e a tratti singhiozzato, specie nei rintocchi di voci, quasi degli echi, dei distici finali; dall’altro le restanti sei strofe, intrise di nostalgico tormento e lirismo altissimo, in cui la città natale viene personificata attraverso dei vocativi anaforici percussivi di grande pathos drammatico, e trasfigurata in un femminino materno sublime e lontano, che profonde luce e consolazione, e della terra ha la fertilità e il soffio vitale. Un respiro che pervade tutto ciò che ella sfiora, e che crea, nelle strofe pari, una sorta di girotondo di elementi naturali contemplati nel loro subitaneo splendore in un intensità facilmente definibile come sacrale, in opposizione alle immagini cupe di morte e perdita, picchiettate di nero e grigio, e le frequenti negazioni che punteggiano le strofe dispari. Il dialogo tra queste due polarità nettamente caratterizzate, due stili distanti nel tempo (le recenti avanguardie e l’antico liturgico-rituale) articola una visione che si fa metafisica, si apre ad una vertigine in cui il destino di tutto, e di tutti, è contemplato, e cantato. La saggezza di Crnjanski, che l’autore della bellissima postfazione al libro, Bozidar Stanisic, ben descrive come spirito della complessità, mutuando l’espressione da Milan Kundera, è una saggezza che dà conforto, nel momento stesso in cui suggerisce come tutto sia misteriosamente ma ineluttabilmente in relazione, e lo fa attraverso un’arte finissima, che accumula come polveri i suoni e le voci di ogni spazio e tempo, affratellate nel passaggio, nel tempo che passa. Una simile vertigine me ne fa rammentare un’altra, indelebile, effetto della visione del film di Werner Herzog, “L’enigma di Kaspar Hauser”. Qui, Kaspar, infante e improvvisamente vecchio al tempo stesso, sorta di foglio bianco a contatto repentino con gli effetti della cosiddetta civiltà, oppone alla maieutica dei suoi precettori e ai dogmi imposti, l’imprevedibile rabdomanzia del suo sentire, sovvertendo le distinzioni della logica e mettendo in discussione tutti i partiti presi, il dentro e il fuori, il vivo e l’inerte, mantenendo una sensibilità di grado altissimo, diremmo bruciante, per tutto ciò con cui entra in contatto, e per la sofferenza di ogni essere. I suoi rapimenti estatici, e le sue visioni di sogno, lo rivelano creatura a suo modo in grado di riscoprire le connessioni tra luoghi e tempi diversi e lontani, di chiamare a sé ogni energia del cosmo, oltre l’umano e le sue convenzioni. In Kaspar, lo sostiene egli stesso, la pelle se ne va, e la sua nudità gli permette di librarsi sulle grettezze dei funzionari di paese, di fantasticare circa una carovana nel deserto del Sahara (il medesimo evocato da Crnjaski nel suo “Lamento per Belgrado”), immaginando una storia lì ambientata, della quale, miracolosamente, conosce solo l’inizio, come si trattasse di una rivelazione, indipendente dalla sua volontà. Kaspar è letteralmente abitato da tutto ciò che è altro da sé, e quando sogna il Caucaso, egli è là, come è possibile, per il poeta serbo, nella fusione di memoria e immaginazione, accarezzare le cime degli Urali, in “Sumatra”. È utile rammentare una dichiarazione del regista Herzog:
Sono sempre stato interessato alla differenza tra “fatto” e “verità”. E ho sempre sentito che esiste qualcosa come una verità più profonda. Esiste nel cinema, e la chiamerei “verità estatica”. È più o meno come in poesia. Quando leggi una grande poesia, senti immediatamente, nel tuo cuore, nelle tue budella, che c’è una profonda, inerente verità, una verità estatica…è misteriosa ed elusiva, e può essere colta solo per mezzo di invenzione e immaginazione e stilizzazione.
Ecco come poesia e cinema, per vie diverse, possono intuire spazi altri, aprire a visioni inedite e sorprendenti in grado di ricondurci al nostro destino comune, in un percorso dove, con le parole di Crnjanski, nessuno va dove vuole. In noi coesistono moltitudini di individui, di idee, di morti e di albe, di lingue e di paesaggi sconosciuti, passaggi di ombre in cui la vita svela la sua natura reale, cioè il sogno. Con questa consapevolezza, e la pacificazione che ci lascia, restano negli occhi le visioni di Kaspar, le sue storie che sono solo il preludio di altre storie e immaginazioni, e le parole vivide con cui Crnjanski prende congedo, infine, dalla sua Belgrado e dalla sua origine, in una delle mille migrazioni e trasformazioni di tutto ciò che vive: Tu, intanto, brilli, ancora, attraverso il mio sogno oscuro…

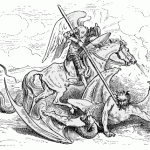 Hermann Broch e il romanzo polistorico - Stefano Zangrando
Hermann Broch e il romanzo polistorico - Stefano Zangrando Uno sguardo portoghese.
Uno sguardo portoghese. Ivo Andrić o un giorno del 1954 - Massimo Rizzante
Ivo Andrić o un giorno del 1954 - Massimo Rizzante Massimo Rizzante risponde a una sua studentessa su Milan Kundera - Massimo Rizzante
Massimo Rizzante risponde a una sua studentessa su Milan Kundera - Massimo Rizzante Poema pastorale
Poema pastorale Canzoni come niente
Canzoni come niente Danzando tra caso e volontà. Un ricordo di Eric Rohmer
Danzando tra caso e volontà. Un ricordo di Eric Rohmer Il peso lieve dei sogni
Il peso lieve dei sogni





















