
Abbiamo avuto la sorte disgraziata di muovere i nostri primi passi in una radura colonizzata da rottami, sognando le praterie dove altri avevano cavalcato, entusiasti, ribelli. Non avevamo più, accanto, dei monumenti con cui scontrarsi o incontrarsi per un pezzo della strada: il partito, il sindacato, la cultura, l’Unione Sovietica, tutto sbiadiva, arretrava, se lo interpellavi. Eppure un furore, l’unico degno di essere per me scolpito dentro il libro della giovinezza, lo avemmo anche noi: il giorno dopo i funerali di Berlinguer, si era alla fine oramai della scuola, mancava per entrambi un mucchietto di mesi per diventare maggiorenni, con Marcello ci andammo a iscrivere al partito. In quel periodo alcune sezioni erano state attaccate da fascisti, una, a piazza Vescovio, addirittura presa d’assedio; iscriverci, carichi di lacrime, i militanti che ti carezzavano con i loro sorrisi, compiacere quello che chiamavamo ancora il padre di Ester, ci fece sentire, inspiegabile ma accadde, d’un tratto diversi da come eravamo, mutate le proporzioni fra noi e il resto del mondo. Nelle settimane successive almeno io così mi percepivo: uno spartano pronto a morire contro i barbari. L’estate si era programmato, per la prima volta, un viaggetto da soli, con il treno, a Rimini; decisi, invece, di rimanere a Roma, il più del tempo a bollire dentro la sezione, a leggere, ad ascoltare i racconti di chi deteneva il tesoro dell’esperienza, ne avevo una sete. A Rimini sarei andato, anni dopo, per seppellire la mia tessera; tornato, in realtà, per la seconda volta, dopo un’estate, avevo sì e no dieci anni, trascorsa in colonia. Un ricordo in particolare mi visitò, quando il congresso inchiodava il coperchio della bara sul partito. In quell’estate, da bambino, a Rimini, ci portarono a visitare l’Italia in miniatura e io immaginai che una specie di Charlot gigante (l’attore era morto l’anno prima e, al solo sentire una musica melanconica che accompagnava la sua comparsa sullo schermo del televisore, mi contorcevo di singhiozzi) camminasse fra la torre di Pisa e il Colosseo, e schiantasse tutto, allegro e sornione; la stessa marionetta ciclopica, non mi vergogno a confessarlo, sognai che entrasse dentro il palazzo della Fiera, soffiasse sopra i fogli dei membri della segreteria nazionale, li disperdesse, giulivo fischiasse tanto da insordire i delegati, qualcuno lo scapaccionasse come si deve. Questa puerile fantasia condonava, per brevi istanti, la mia angustia, felicemente perso l’orientamento; intero restituiva il sentimento di piccolezza, cui gli eventi ci avevano destinato.
Tra i ragazzi, in quegli anni lì, la parola apartitico, talune volte barattata come candido sinonimo di apolitico, echeggiava. Un nostro compagno di allora, lo chiamavamo il Lugubre per il suo temperamento, evocava spesso, per celia o per vezzo, la caccia al fascista (“l’unico fascista buono è quello morto”; se mi dessero l’occasione, ripeteva, di uccidere impunemente un fascio, lo farei senza rimorso); eppure un fascista era assai meno velenoso per le nostre coscienze di uno yuppie. Questo sarebbe durato, evoluto, di prepotenza entrato dentro le nostre vite adulte, distillato maliziosamente nelle urne a venire. Quando si cominciò l’università, vedemmo, dopo anni, tornare in piazza i ragazzi dei licei, spesso dei quindicenni; correvano alle manifestazioni come allo stadio, a una gita scolastica, a Ostia in una mattina senza scuola. Uno di loro, con piglio allegro, al giornalista televisivo che lo intervistò, nel bel mezzo di un corteo, proclamò: “se Leopardi avesse fatto un po’ di palestra e scopato, non ci avrebbe rotto le palle a noi”. Educati e festosi, quei ragazzini, e pieni di quel rancore, ai tempi zittito, che avrebbe fatto buona compagnia a molti di noi, dopo. Ai collettivi studenteschi o di fabbrica, ai lacrimogeni e i comitati di quartiere, succedeva la cameretta, recintata da un poster di Luis Miguel e un’audiocassetta degli U2, da ascoltare, avanti e indietro, dentro il walkman; ogni tanto concedersi un’evasione furente in un’arena, per partecipare al rito dionisiaco di un notturno sabba musicale, ovvero buttarsi in una di quelle zuffe gladiatorie fra devoti a un pallone. L’eroina proletaria, che tanti ancora macellava, davanti all’hot dog cedeva le armi: merci entrambe da consumare, corrodevano chi le assumeva.
Lo si ripete oggi, a buon diritto, ma allora non lo si poteva immaginare: quel carnevale dadaista del ‘77 non chiudeva ciò che era iniziato nel ‘68, ma apriva al mosaico scintillante delle coloratissime pubblicità, le telenovele, gli indiavolati cartoni animati; l’indiano metropolitano non era l’ultima incarnazione del Che Guevara di dieci anni prima, ma la manifestazione di una lunga teoria di maschere successive, che avrebbe tenuto insieme, senza soluzione di continuità, il tossico, il paninaro, il culturista, il disk-jockey. Le rivoluzioni, si sa, offrono l’occasione a tanti mediocri di risplendere di una luce riflessa, ritagliarsi un ruolo, e talvolta, per alcuni, una buona carriera, consumata la mareggiata; a noi rimaneva soltanto la possibilità, in un angolo di questa palude, di cucirci i vestiti con gli stracci avanzati a ben altri trionfi.
Quell’era il periodo, in cui i partiti irreversibilmente sfregiavano la loro reputazione, e senza darsene granché pena. Bruno ce la spiegava così: quando l’economia è in affanno, la gente si ritira nella tana per salvare quello che ha, non si interessa di ciò che è pubblico, a differenza di quanto accade nelle epoche prospere, in rapida crescita, quando tutti vogliono dire la loro, contribuire al benessere collettivo perché non scemi. Il puzzo di una politica corrotta e malsana repelle il cittadino, lo allontana dalla partecipazione alla cosa pubblica; ai partiti ciò non dispiace affatto, lo mettono, anzi, nel conto di quei vantaggi che garantiscono l’esercizio riservato del potere. Quest’esercizio assumeva un nuovo passo di marcia, proprio allora, un passo strafottente, avaro di rimorsi; non l’avrebbe più abbandonato.
Tre ore, anche più, si rimaneva a discutere a casa di Bruno; molte volte fino a notte, l’alba nel periodo delle elezioni; Iole la mattina brontolandoci con una caraffa di caffè e un cumulo di biscotti. Ancora oggi rimane il ricordo più geloso dei miei vent’anni al loro inizio.
* Questo brano è estratto dal romanzo di Danilo Laccetti Nella neve perenne (prima parte, cap. 8).

 Pavese/ 2 - Danilo Laccetti
Pavese/ 2 - Danilo Laccetti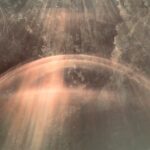 Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera Nella neve perenne/ 1 - Danilo Laccetti
Nella neve perenne/ 1 - Danilo Laccetti Presiden arsitek/ 53 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 53 - Angelo Angera Nella neve perenne/ 3
Nella neve perenne/ 3 Pavese/ 1
Pavese/ 1 Pavese/ 8
Pavese/ 8 Calame persta
Calame persta





















