
Sono forse gli spazi vuoti, ciò che resterà come monumento di questa nostra epoca diffratta in miriadi di fantasmi: i cortili dei bambini, ossia oramai dei loro fantasmi.
In quello stesso cortile in cui Sarahs e Miloš avevano cominciato a balbettare l’uno il nome dell’altra era arrivato, anni prima o miliardi di anni dopo, Carlos Adra. Era sceso da una vecchia automobile scassata, indossando immediatamente una mascherina chirurgica bianca come a proteggersi dalla nebbia notturna. Era sceso: grassoccio, la scriminatura in mezzo alla testa troppo grande, grandi gli occhi ma quasi a mandorla, come anestetizzati da una dolcezza femminile e mammifera, l’occhio di mucca delle dee preistoriche, infinitamente nero e ebete anche durante il più efferato sacrificio. Il cortile era naturalmente vuoto: gli altri bambini sarebbero cominciati ad arrivare solo ore dopo. La macchina scassata, di un colore indefinibile nella nebbia della notte morente, piena di quello che appariva un groviglio labirintico di braghe e camicioni da clown, aveva lasciato andare un colpo di clacson sfiatato ed era ricarracolata nella tenebra scheletrica dell’alba lasciando dietro di sé una puzzolente nube nera come in un dozzinale gioco di prestigio.
Rictus, aveva pensato il piccolo Adra. Aveva sentito la parola qualche giorno prima durante un programma radiofonico ma nessuna delle persone del luna park gli aveva saputo dire cosa significasse, e il bambino aveva creduto di aver così scoperto l’unica parola al mondo senza un significato sfuggita di bocca nel mezzo di una trasmissione radio. Era bello, una parola senza significato, rictus, una parola che poteva essere tutto, poteva essere il nome di un clown perduto nella foresta o morto di fame, morto di botte, morto di risate, il nome di un fiore velenoso o capace di leggere nel pensiero, il nome che hanno i sapori quando li si ricorda senza sentirli davvero, e il nome dei ricordi che portano con sé, il nome degli amici che non conosci ancora o che ormai conosci così bene che sono diventati un mistero completo. Una parola che vuol dire qualsiasi cosa, questo per lui sarebbe per sempre stato l’amore. Gli sarebbero poi rimasti in gola quei suoni, come un bisbiglio, r-k-t-ssssssss…: anche da adulto: r-k-t-ssssssss… li bisbigliava a volte tra sé, alla fine di una frase.
Sono forse questi grumi di suoni privi di senso, ciò che resterà… o forse il mondo sta disimparando a parlare?
Il fiore rampicante restava in attesa di un cranio sopra il quale cadere e affondare le proprie radici, e nutrirsi dei pensieri, fiorrictus mangiapensieri… Ancora mezzo addormentato, il bambino dormivegliava orrori seduto sul muretto ancora mezzo smaterializzato dalla tenebra.
Non gli piacquero i tigli e le loro foglie sudicie di miele. Non salì i gradini che portavano al cortile più grande. Rimase accanto al tronco ritorto e disperato del bosso, ai piedi del rialzo, a lato dei gradini che portavano al cortile più grande, fissando nella memoria quel che negli anni che seguirono sarebbe diventato il suo regno di bambino, e da cui non si sarebbe mai liberato.
Il fiato gli si imbatuffolava brevemente fuori dalla mascherina prima di sparire. Mancano fotografie del suo volto intero da bambino, o almeno mancano nelle bacheche e negli archivi del Pio Istituto di san Satiro. Non si sarebbe mai tolto la mascherina, e nessuno dei bambini negli anni che Adra rimase con noi provò mai a togliergliela: nemmeno Hanso, il suo futuro schiavo. In tutte le fotografie in cui Adra compare, non si vedono che le due ali simmetriche di capelli e la forma esagonale della mascherina.
Il bambino fissava i muretti che contornavano il cortile basso, le gradinate verso le aule da una parte e verso i tigli dietro di lui, le grate degli archivi sotterranei, tracciando un primo portolano degli incubi con cui ci avrebbe irretito nei mesi a venire e, ammettiamolo pure, per il resto della nostra vita. Intorno a lui il cigolio degli uccelli e il vento freddo che scendeva dal fiume annunciavano il sole, ma il primo macchinario ad accendersi fu quello della Cartiera Regia di Waltzwaltz, con una nota cupa e continua come di borgna marina.
Tirò fuori di tasca un mazzo di carte lacere, tutte spaiate. Le aveva raccolte da terra nel corso delle sue infantili peregrinazioni nei rioni intorno al luna park. Erano carte da poker, cavalieri, fanti, re e regine dei più vari semi, tarocchi, santini, tessere della biblioteca o della mensa e biglietti da visita e santini finiti anche loro tutti insieme nel mazzo, e come santini infetti ancora carte da gioco in cui centauri, guerrieri, maghi, piante divoratrici di anima, acque fatate e angeli in esilio erano accompagnati da storie, cifre e preghiere. Il bambino ne prese una a caso. Era un centauro, o più precisamente un uomo nudo che a partire dalla zona tra le prime vertebre e le natiche aveva dietro di sé un corpo di cavallo, per cui le due gambe umane anteriori facevano il paio con delle zampe di cavallo posteriori.
La prima volta che in classe avevamo sentito il suo nome avevamo riso, Carlossssss, aveva sibilato uno di noi, Carlossssss…
Prova di una fascinazione dell’Adra cineasta per mostri completamente gratuiti è il mockumentary Samurai 8, una sorta di omaggio stralunato a Shichinin no samurai di Kurosawa. Il film comincia con una presunta sequenza tagliata del film di Kurosawa in cui il capitano Kambei, anni dopo i fatti raccontati nel film, osserva col suo solito sorriso di placido carnefice una fotografia tenuta segreta che ritrae i sette in un bosco, ai tempi della loro prima impresa. Chi ha scattato quella foto? I sette guerrieri non sono soli: esaminandola da vicino, un giovane samurai discepolo del capitano individua una forma rannicchiata contro un albero, una specie di oblunga creatura marina ruvida e bitorzoluta come un gigantesco cetriolo di mare (non fosse per le piume… Forse un cucciolo di megattera? con uno scarto tipico dei primi film di Adra, su queste ipotesi si innesta un insieme di improbabili osservazioni sul piumaggio delle giovani megattere, sulla sua utilità mimetica e sulle sue un tempo ricercatissime sfumature e varietà). Il capitano, oggi ormai generale dell’esercito imperiale, sorride al giovane samurai. “Grazie”, gli dice, “non avevo notato quella creatura. Teniamo però questa informazione segreta: potrà sempre esserci utile in un giorno di battaglia”. Il suo sorriso sornione vuole forse alludere al fatto che il generale sapeva da tempo della presenza della megattera fantasma nel gruppo dei sette? Che magari lui stesso aveva evocato lo spettro, offrendo la propria anima in cambio di una vittoria priva di gloria, oppure imprigionandola in una bambolina voodoo tenuta nascosta nella sua finta borsa da medico condotto? Dato che l’intera scena nonché il personaggio della Megattera Fantasma sono stati eliminati da Kurosawa ben prima che si giungesse alla versione finale, non lo sapremo mai.
Dopo questa premessa, Adra e la sua troupe partono alla ricerca del personale coinvolto nella creazione della Megattera Fantasma incontrando tutto un gruppo di visionari, fuoriusciti ed emarginati del mondo accademico, tra cui un biologo e oceanografo che gli sceneggiatori avevano contattato per conferire un qualche realismo al mostro. Il timore della casa di produzione di Shichinin no Samurai, che poi avrebbe fatto piazza pulita della creatura acquattatasi nella vecchia fotografia, era che la Megattera Fantasma potesse risultare più fantascientifica che fantasmatica (l’uscita di Gojira sarebbe caduta solo pochi mesi dopo quella del film). Per evitare questo rimescolamento di forme, giudicato immorale dai produttori, Kurosawa aveva realizzato un numero limitatissimo di inquadrature della creatura, sempre in zone di penombra, dove il mostro fosse a malapena visibile, le sue piume non più di qualche volatile rimasuglio impigliato in una spiga di riso appena falciata e subito sommersa dall’avanzare dei contadini nella melma. Adra dimostra come in alcune delle sequenze del prodotto finale si possa indirettamente intuire la presenza della creatura e, in un finale disarticolato quanti altri mai, si impantana infine del tutto in una infruttuosa ricerca della persona (ossia del personaggio) che avrebbe scattato la fotografia da cui è partita l’intera indagine. Il film si conclude con la visita a un laboratorio di linguistica interspecie nel quale un’equipe di studiosi sta cercando di assemblare il primo dizionario della lingua dei cetacei e dei suoi dialetti sotto la guida di un oceanografo (Favori, già caduto in discredito per i suoi studi sul barsàla) e di un letterato (Sommariva, che naturalmente pagò questo suo unico contatto con Adra con ogni sorta di angherie e sberleffi da parte dei suoi colleghi).
Tutte le carte che lui trovava le aveva lasciate in terra sua mamma, apposta per lui, perciò se noi ne trovavamo non dovevamo raccoglierle, o dovevamo portarle a lui. E se invece me le tengo, aveva detto il bambino che lo aveva chiamato Carlossssss, e Adra aveva scelto una carta dal suo mazzo e ci si era tagliato l’incavo tra il pollice e l’indice, e il bambino, che naturalmente era Hanso, era scoppiato a piangere. “ZAC!” aveva detto il piccolo Adra.
I genitori di Adra com’è noto compaiono, non poco trasfigurati, nelle pagine di In Cuniculum dedicate all’immaginario paesino americano di Pearl, pagine che del resto sono risultate perfettamente inutili per gli inquirenti, investigatori, giornalisti, letterati e infine semplici sfaccendati che nel corso del tempo hanno cercato di fare una qualche luce sul caso di Adra. Dalle carte custodite negli archivi del Pio Istituto san Satiro, poi disperse a seguito della chiusura dell’Istituto stesso, risulta che la madre del piccolo Carlos, una donna di origini africane con alle spalle una carriera non trascurabile nell’atletica leggera, aveva perduto la potestà sul bambino a seguito di una serie di non meglio precisati episodi psicotici. Con una procedura che è tipica dello stile burocratico delle procure di Schwarzschwarz, il bambino era stato affidato agli zingari del luna park sulla base della dichiarazione verbale di un lanciatore di coltelli, mai confermata dalla donna, di essere il padre del bambino.
Il giorno dopo la lite, Hanso gli si era già appiccicato. Parlottavano insieme, e Carlos gli mostrava le sue carte da gioco tenendogli un braccio intorno al collo. Hanso fissava ora lui ora le figure delle carte da gioco, e ancora non sapevamo se quella devozione fosse reale o un teatro per vendicarsi delle lacrime che Carlos gli aveva fatto versare.
Quell’estate, il fratellino di Hanso sarebbe stato trovato morto annegato sul bagnasciuga di Jucafilo, sul mar Jonio, la faccia e il busto mezzo sepolti sotto la sabbia fradicia come se qualcuno gli fosse salito in piedi sulla schiena fino a ucciderlo. Il bambino era scomparso così, a pochi metri da altri bagnanti che non si erano accorti di nulla, nella sonnolenza del dopopranzo, i genitori di Hanso accecati dal riflesso del sole sulla risacca. Del resto per un bambino la morte per annegamento è questione di pochi secondi. A trovarlo era stato un cane, nasando e saltando giocone contro quello che sulle prime poteva anche sembrare un sasso o un grosso pesce, non fosse stato per i pantaloncini colorati. Pochi mesi dopo i genitori di Hanso erano stati trovati morti per avvelenamento da gas di scarico nel garage della loro casa, e l’orfano si era unito definitivamente alla carovana del luna park.
Carlos ci raccontava dell’Amazzonia, Hanso seduto ai piedi del ramo di bosso su cui il suo nuovo amico si appollaiava sempre. I grandi occhi allungati e dolci che lasciavano indovinare un sorriso sotto la mascherina, la voce sempre impastata come da un eccesso di salivazione, il forte accento portoghese che dava a tutte le sue frasi un tono un po’ perplesso e insieme saccente, di vecchietta che racconta la giovinezza perduta, o forse era solo per via di quei cravattini sudici e quelle giacchette da damerino rubate a uno spaventapasseri che gli zingari del luna park usavano per i loro clown e che lui al contrario amava indossare, tali da farlo sembrare una specie di spodestato dittatore in miniatura.
Ci raccontava di liane che nella foresta in cui era nato scendevano a rapire i bambini che si fossero avventurati sotto di loro, ed ogni fiore che fosse fiorito da quella pianta era l’anima di un bambino. Hanso lo guardava rapito, i denti scoperti e scintillanti di un sorriso vagamente topesco, e rideva, come ridevamo tutti anche noi, delle scene più spaventose, come quando Carlos ci aveva raccontato che sua sorella per poco non era stata rapita da una di quelle liane, e per liberarsi aveva dovuto mozzarsi con una roncola la mano ormai già mezzo fusa nello stomaco ubiquo del vegetale. Ai tempi dell’incidente sua sorella non era più una bambina, ma dato che era sempre stata molto smilza la liana si era confusa, così aveva detto Carlos con quel suo modo di allungare le vocali finali delle parole, ogni volta guardandoci con fare interrogativo, come se non fosse sicuro di avere usato la parola giusta. E adesso dov’era la sua sorella monca? Un po’ della linfa della liana carnivora le era entrata nel sangue, ci aveva risposto il bambino, e la ragazzina senza una mano era diventata come una specie di strega. Della foresta.
Quello della sorella di Adra è tutt’oggi un problema investigativo irrisolto. L’assenza di documenti che ne attestino l’esistenza è tutt’altro che dirimente, se si tiene conto che a giudicare dagli anni di differenza tra i due, che a seconda delle fonti oscillano tra i 10 e i 15, la ragazza sarebbe nata nel pieno del ventennale conflitto austroamazzonico, epoca diplomaticamente affatto caotica e oggi reticentissima a qualsiasi tipo di studio. C’è stato anche chi ha proposto, anche sulla base dei racconti di noi ex compagni di classe di Adra, che la sorella e la madre di cui ci parlava fossero la stessa persona, così come fossero la stessa cosa la pazzia dell’una e la mutilazione e metamorfosi in strega dell’altra: tipica teoria-a-coup-de-théâtre che a ben vedere non fa che spostare il problema dell’identità sulla figura, già abbastanza malcerta di suo, della madre.
Quando Carlos si era tagliato il dito con la carta da gioco e Hanso era scoppiato a piangere avevo pensato che non si sarebbero mai più parlati, quindi ora mi pareva una specie di ingiustizia vederli così uniti, così l’uno per l’altro, lo smilzo e minuto ragazzino austriaco la cui faccia affilata faceva già indovinare quale sarebbe stato il suo aspetto da vecchio, le dita appiccicose di colla e di zucchero intrecciate a tenersi unite le ginocchia, e sopra di lui il piccolo zingaro portoghese con le sue insensate camicie lacere e i suoi papillon, i capelli sempre perfettamente divisi in un modo che anni più tardi avrei riconosciuto in alcune fotografie di Houdini, un bimbo grassoccio e molto alto per la sua età – quando non era accoccolato sul ramo di bosso, la sua testa dondolava placida sopra le nostre – anche se nessuno di noi, nemmeno Hanso, l’aveva mai visto mangiare né se è per questo l’aveva mai visto in volto, e alcuni cominciavano anche a chiedersi cosa ci fosse in effetti sotto la mascherina… forse al posto della bocca c’era un tremendo squarcio lasciato da una frustata della liana carnivora, o forse al posto della bocca aveva una di quelle protesi come le vittime degli attentati che proprio in quegli anni stavano cominciando a diventare un contorno abituale della vita della Repubblica.
Oggi che so che molti sono i modi in cui possiamo versare lacrime, capisco che i due quel giorno avevano pianto insieme, e per quello e non altro erano rimasti amici. Ma Adra non seppe mai piangere altrimenti che attraverso il sangue.
La sorella di Carlos era diventata una strega, e per ricompensarla le liane le avevano restituito la mano in forma di fantasma, così ci cantilenava Carlos semiinvisibile tra le foglie del bosso, rannicchiato nell’angolo più in ombra dove c’era appena lo spazio per Hanso per stargli vicino, e noi non sapevamo smettere di ascoltare quelle sue storie senza storia e piene solamente di un cieco orrore.
La mano fantasma della strega è in grado di frugarti le viscere e di strapparti il cuore mentre dormi, diceva Carlos, ma per farlo ti deve ingannare, deve ingannare l’anima, recitava il bambino con l’aria di non capire niente di quello che diceva, e di ripetere a pappagallo storie che aveva sentito chissà da chi nel luna park in cui viveva o negli inimmaginabili posti in cui era vissuto prima di arrivare lì.
La strega con la mano fantasma inganna la tua anima con il canto delle “suore”, e l’anima credendo di farsi santa segue immediatamente quel canto. Senza capire niente pendevamo dalle sue labbra, ed era solo perché sentivamo attraverso di lui la voce di adulti sconosciuti che gli avevano fatto imparare a memoria quelle storie e quelle parole, mentre a noi nessuno ormai insegnava più niente, e non c’erano parole che potessimo dire senza capirle del tutto, poiché tutto era stato chiarito per noi; ma non c’è felicità più grande per un bambino del recitare e riascoltare parole incomprensibili che qualcuno più grande e un po’ più morto di lui gli ha fatto imparare per amore.
L’anima semplicetta segue il canto delle “suore” sperando di farsi santa, ci diceva Carlos, i rami del bosso di quando in quando traversati da un fruscio di lucertola o di merlo. Ma chi erano, chi sono le “suore”? La notte quando stai per chiudere gli occhi potrà capitarti di sentire delle donne cantare lontano, e con gli occhi ormai chiusi potrai vedere le loro bocche tremare di false lodi a Dio, poiché in realtà quelle bocche che cantano sono pronte a sbranarti, e sempre più tu te ne rendi conto, ma quella che senti è una lenta e santa melodia lontana, e così appena l’anima curiosissima tira fuori la sua luminosa testolina dal tuo corpo addormentato chiedendo “Chi mi chiama, chi, chi, chi, chimichiama?” subito le dita fantasma della strega ti scivolano nelle viscere e ti strappano il cuore, e la mattina ti troveranno morto nel tuo letto, la faccia sepolta dal sangue, la tua anima perduta, ormai diventata per sempre una “suora” anche lei.
I primi attentati finivano tutti con la morte dell’attentatore, e in assenza di rivendicazioni all’inizio era stato difficile risalire a una qualche organizzazione, nonché ai suoi scopi, che del resto rimangono tutt’ora alquanto oscuri. Gli attentatori venivano reclutati tra anziani soli, malati terminali che nessuna struttura era riuscita ad accogliere, vecchi reclusi che avevano speso l’intera esistenza a combattere dentro antichi videogiochi, per i quali la prospettiva di farsi saltare per aria nel luogo che fosse loro stato indicato era un modo come un altro per far sapere al mondo che dopotutto anche loro erano lì.
«L’età della ribellione venendo continuamente procrastinata nella speranza che la fiacchezza della carne abbia la meglio sullo spirito, si arriva a produrre una generazione di ribelli con un piede nella fossa che letteralmente non hanno nulla da perdere», aveva sentenziato da una cassetta per la frutta che fungeva da pulpito un sacerdote scomunicato di cui non ricordo il nome.
Il primo attentato era avvenuto durante una visita del Ministro per il Benessere Psicofisico in una delle più importanti cliniche private di Jakarta. Mentre il Ministro stringeva le mani e sorrideva facendosi strada tra le ragnatele invisibili del gamelan, uno dei presunti pazienti (risultò poi che era davvero facilissimo infiltrare un estraneo in una struttura dove tutti venivano regolarmente trattati come poco più che numeri) gli si era avvicinato tenendo in mano un libro scritto dal Ministro benché il Ministro stesso (ma questo lo sapeva solo lui) non l’avesse mai nemmeno letto, e quando il Ministro gli si era avvicinato per autografare la copia il vecchio gli aveva piantato un coltello da tavola nella gola e poi si era lasciato cadere in avanti tenendo un paio di forbici puntate contro il cuore, morendo sul colpo.
Nei giorni immediatamente successivi vennero eliminati, con altrettanti attentati suicidi, un intero squadrone della Polizia della Repubblica che presenziava in forze fuori da uno stadio di calcio (attentato dinamitardo), il Ministero per la Riforma dell’Intelligenza Umana che con il suo entourage aveva partecipato a un incontro pubblico per l’apertura della prima Università Immateriale di Schwarzschwarz (ancora attentato dinamitardo), quattro capi d’azienda e due direttori di banca (omicidio-suicidio secondo modalità assortite). La reazione delle istituzioni era stata, come da protocollo, terrorizzata e scomposta. Le perquisizioni, gli arresti e i continui rastrellamenti di persone sole e anziane (a tale nebulosissimo e, secondo risultò, oltremodo diffuso profilo appartenevano gli attentatori) non avevano fatto altro che esacerbare gli animi di una fascia della società che da che mondo era mondo era sempre stata emarginata e all’improvviso, forte l’esempio dei terroristi, scopriva di non avere «letteralmente più nulla da perdere» (benché tutto sommato piuttosto grigia, la frase era diventata uno slogan tra i vecchietti furibondi per le continue perquisizioni e gli arresti scriteriati) a mettersi contro uno Stato che li aveva vampirizzati fin nelle più intime fibre e che ora gli puntava dritto in faccia una cinematografica lampada da terzo grado.
Come disse il direttore di uno dei più importanti giornali della Nazione, fregandosi zitto zitto una battuta di Burroughs (ma, per quel che mi importa, concediamogli pure il beneficio della poligenesi) «Il terrorista dormiente più pericoloso è quello che non sapeva nemmeno di esserlo». Altri fronti, dal profilo più ambiguo e dalle posizioni più sfumate, preferivano parlare di maieutica del guerrigliero con tutto il codazzo di reazioni e distinguo che ciascuno può immaginare.
«Lo Stato non crollerà per il terrorismo, lo Stato crolla perché non c’è nessuno che davvero ne voglia la corona, perché la corona si nutre di sangue, è come una grossa zecca che uno si pianta in testa, ma dato che nessuno la vuole, nessuno la trattiene, la corona salta da una testa all’altra a proprio capriccio», dice uno dei personaggi del film Una notte di Adra.
Ciò di cui oggi siamo ragionevolmente certi è che quelli non erano che i primi e relativamente timidi passi di quelli che più avanti si sarebbero rivelati con il nome di Nerini, ma di altri attentati non si sapeva che pensare. Ordigni esplosivi installati non si sa come nelle casse toraciche di pazienti d’ospedale avevano sterminato intere famiglie e sepolto interi sistemi sanitari sotto un cumulo di cause legali. I frequentatori di una piscina rionale erano morti congelati durante l’aquagym a causa di un attentato con azoto liquido. Oggi il terrorismo è talmente diffuso che non si riesce più a capire se si tratti di una specie di collettiva sindrome del piromane di Alessandria o se vi siano davvero poi dei terroristi come una volta, che fan quel che fanno per un obiettivo, non soltanto perché tutti li indichino col dito quando li vedono passare. Non sono il solo a ritenere che questo caos sia stato fin dall’inizio uno degli obiettivi occulti dei Nerini.
Ai tempi in cui Carlos Adra aveva fatto il suo (intermittente, come si vedrà) ingresso nel Pio Istituto di S. Satiro, comunque sia, si brancolava nel buio più completo, il che in faccende come questa è segno presso che certo che l’organizzazione terroristica non ha alcun addentellato né malavitoso né politico. E in questo brancolare la macchina che lasciava Carlos davanti ai cancelli dell’Istituto non avrebbe potuto risultare che oltremodo sospetta, non tanto ai pii docenti e inservienti dell’Istituto quanto ad altri genitori dei bambini iscritti: per questo Carlos veniva scaricato davanti ai cancelli con le sue scarpe bucate di vernice marrone e le sue toppe sui gomiti quando non c’era nessuno che avesse potuto vedere l’auto degli zingari, prima dell’alba (che era in ogni caso anche il momento in cui gli acrobati e gli elefanti del luna park aprivano gli occhi). Per spezzare definitivamente il cuore a un passante gli sarebbe mancata solo una lacera custodia di violino, ma a quell’ora da gufi per di lì non passava mai nessuno.
***
Non resterà altro di noi, attraverso gli anni e forse anche i secoli, che i cortili dei bambini accanto a montagne di indecifrabile immondizia.
Oggi i tigli ci sono ancora, e così i gradini che separano il cortile basso, dove stava sempre il giovane Adra, dal cortile alto; ma sono spariti il bosso, e il corrimano di ferro verniciato di verde che lo separava dallo spazio più aperto. Quando si entrava lì, cioè dove Adra si installava per raccontare le sue storie, era come entrare in una casa. Se si sa dove guardare, ancora oggi si può vedere una leggerissima striscia di colore nel punto in cui Adra tracciava quei simboli e disegni che per lui bambino erano tanto importanti, come ad esempio la roncola con cui sua sorella si era mozzata la mano per liberarsi dalla liana carni-/animi-vora.
Per le polizie scientifiche dei tre principali paesi in cui Adra ha perpetrato la propria opera necrocinematografica, questo cortile è una tappa obbligata del pellegrinaggio alla ricerca dei più minimi impensati campioni; periodico pellegrinaggio, anzi, perché ad ogni nuovo traguardo raggiunto nelle tecniche e tecnologie di investigazione e caccia all’uomo è d’obbligo una nuova ricognizione in questo cortile così come in altri luoghi chiave della biografia nota di Adra. Ma il bosso e il corrimano sono stati sradicati dai pii giardinieri per la sicurezza e anzi l’incolumità di sempre più sperduti e immateriali bambini, innocenti catturati e fatti morti da sirene ben più efficienti e fredde di quanto non fossero le “suore” della sorella monca di Adra: e nessuno di loro, almeno che io sappia, ha potuto almeno trasformarsi in fiore.
R-k-t-ssssss…
Le tende del luna park in cui viveva Carlos erano piantate nei rioni tropicali di Schwarzschwarz, poco lontano da una sorta di laguna di fango che in quei giorni era invasa da una colonia di farfalle giganti (la famigerata specie Pammegale), una delle piaghe delle regioni amazzoniche dell’Impero.
Chi non le avesse mai viste, tali farfalle oltre ad essere com’è noto gigantesche presentano un minuscolo paio di ali supplementari: Lefebvre, che non poté mai studiare un esemplare in vivo, le descrisse come piccole pinne («petites nageoires») che decorano («ornent») il paio di ali inferiori laddove esse ali si allacciano al punto mediano del corpo dell’insetto, il che crea uno iato consistente tra ali posteriori e anteriori che nelle altre specie sono viceversa parzialmente sovrapposte; è opinione popolare che le pinnule siano necessarie per poter governare un corpo che negli esemplari più grandi raggiunge le dimensioni di quello di un bassotto tedesco, tuttavia esemplari che ne vengano mutilati mostrano una intatta capacità di volo: a quanto pare Lefebvre con quell’ornent ci aveva visto giusto: o quasi, se uno strumento di morte può (e di fatto lo può) essere considerato un ornamento.
Nutrendosi le farfalle giganti di Schwarzschwarz anche di ragni, piccoli camaleonti nonché di altre farfalle, le due alette servono alle bestiacce per farsi passare per farfalle comuni: il grosso corpo sepolto tra il largo fogliame, le sole alucce a sporgere come un’appetitosa fiammella colorata e croccante, le farfalle giganti attraggono così le loro vittime che poi immobilizzano frustandole con la spiritromba, lunga in media una ventina di centimetri ma che non di rado arriva fino ai trenta.
La spiritromba delle farfalle giganti è ricoperta di microscopici uncini velenosi, urticanti e in caso di intolleranza potenzialmente letali per l’essere umano, e paralizzanti per numerose specie di animali di taglia minuscola. Come è per la Calyptra, anche gli uncini della Pammegale sono erettili, il che di fatto permetterebbe all’animale di perforare anche la pelle dell’uomo, incidente questo tuttavia mai registrato, non rientrando né l’uomo né il suo sangue tra gli alimenti dell’insetto.
Oltre che nel fogliame, le farfalle giganti amano appiattirsi tra i tronchi di legname, dove è capitato che creassero colonie di migliaia di individui. La vita media si aggira intorno ai due anni, il che rende la Pammegale di gran lunga le farfalle più longeve. Tuttavia superato l’anno di età il corpo dell’insetto, che non cessa mai di crescere, finisce per andare incontro ad una sorta di grave scompenso strutturale. Non è raro che gli esemplari invecchiando si spezzino in due durante il volo, o che perse le ali conducano gli ultimi anni di vita tra gli insetti terricoli.
Qualcosa del genere era il testo che Carlos aveva letto davanti alla classe, probabilmente dopo che la pia istitutrice cui eravamo affidati aveva visto tutti i segni rossi che gli rigavano le braccia e il collo sparendo dentro la camiciola a maniche corte che Carlos indossava quel giorno, pia istitutrice i cui occhi si erano imperlati di nostalgia alla vista del quaderno blu su cui Carlos aveva ricopiato a mano da chissà quale libro la sua ricerca sulle farfalle giganti.
E un giorno che Carlos non era stato scaricato davanti al cancello quella stessa istitutrice ci aveva spiegato che gli zingari non vogliono avere una casa tutta per loro, che dopo un po’ che stanno in un luogo vogliono andarsene ed è impossibile tenerli fermi, e ci aveva raccontato di un’amica che aveva sposato uno zingaro e che dopo un po’ ne era stata abbandonata perché l’amore per il viaggio negli zingari è più forte di quello per la famiglia e per il proprio stesso sangue, e il fervore e la ricchezza di dettagli con cui la pia istitutrice raccontava la sua storia mi fa pensare oggi che non ci fosse nessuna amica, e che fosse lei stessa la donna abbandonata o forse, peggio, solamente innamorata di uno degli zingari del luna park, il cervello reso radioattivo dall’infinità di pie considerazioni di cui si ornava il capo, aveva inventato tutto, l’amica, il matrimonio, l’abbandono, perché in mezzo a tutti quegli strati di menzogne il suo cuore potesse ingannarsi e finire per trovare una qualche verità. Comunque il tutto per noi bambini era lo stesso strano da pensare, quando si trattava di quel ragazzino tracagnotto che pareva aver messo radici insieme al suo bosso nell’angolo del cortile basso, accanto ai gradini, e che ora con Hanso ai suoi piedi sembrava un piccolo re nella sua corte.
Ma era vero, Carlos non rimaneva mai con noi per più di qualche settimana: appena il luna park partiva, anche lui ci salutava, però questo non provava nulla perché non era lui a decidere.
***
L’unico altro bambino che come stazza potesse stare alla pari di Carlos era Dio, un bambino autistico di cui nessuno ricordava più il nome e che tutti ormai chissà più perché chiamavano così, Dio. Tutti fatta naturalmente eccezione per i pii docenti e il pio direttore dell’Istituto, che riuscivano sempre con ingegnosi giri di parole a evitare di chiamarlo direttamente o in ogni caso di riferirsi a lui chiamandolo per nome, dato che anche loro avevano dimenticato il suo nome vero e nessuno di loro aveva voglia di scendere negli archivi a ritrovarlo. E ora che ci penso questo loro modo di fare non era poi molto dissimile da quello che molti mistici hanno verso Dio, che mai andrebbe mai chiamato per nome ossia il cui nome è segreto, sepolto negli archivi di chissà quale sovrumano Istituto: per cui, non nominandolo, anche loro, e forse proprio loro più di tutti, chiamavano Dio il bambino.
Dio passava quasi tutto il tempo nel cortile più alto, quello dove Carlos non era mai salito. Non parlava quasi mai con nessuno, ma a dispetto del suo distacco dagli altri bambini e della sua indifferenza per ogni cosa che non fosse la ramificazione e la metamorfosi cromatica dei tigli nel cortile alto, di quando in quando dio lasciava calare dal suo annichilente metro e settanta di statura delle frasi che nella loro incomprensibilità o insipienza venivano tesaurizzate da noi bambini come gemme di inestimabile profondità.
A uno che gli dava dello stupido, ad esempio, aveva risposto “Che cos’è la stupidità?” lasciandolo di sasso e da lì in poi profondamente mutato come persona, tanto forti possono essere certe impressioni in giovane età.
Aveva ridotto in lacrime delle bambine che passandogli accanto si chiedevano l’un l’altra perché il cuore quando lo si colora si usa quasi sempre il pennarello rosso, bofonchiando “Perché butta sangue”.
A ricordarle oggi queste parole di Dio non mi dicono assolutamente nulla, ma da bambini ne restavamo restati tutti impietriti. Forse più delle parole erano i suoi occhi azzurro slavatissimo che scivolavano sopra ogni anima senza alcuna passione e ci rivelavano il nostro vuoto, ancora così facile da percepire per chi ha ancora morbido e tenue quell’esoscheletro psichico che chiamiamo passato.
Lo scontro, benché mai annunciato, quando scoppiò apparve a tutti inevitabile. Un giorno Dio era piombato sotto la corte del bosso, dove non veniva mai, aveva preso Carlos per il bavero di una delle sue giacchine di cotone da figlio di architetti in rovina e l’aveva sbattuto per terra. Tutti noialtri, Hanso incluso, eravamo rimasti a guardare, guidati dall’istinto preistorico di comporre un cerchio intorno a chi combatte in duello.
Dopo averlo scaraventato a terra, Dio aveva calpestato una delle mani di Carlos, poi strappato uno stecco dal bosso gli si era avvicinato con l’intento, a quanto pareva, di cavargli gli occhi. Carlos era strisciato indietro contro il muretto che separava il giardino superiore da quello inferiore. Cercando di tirarsi in piedi aveva staccato dal muro una grossa crosta di intonaco, e ancora in ginocchio, dal basso verso l’alto l’aveva lanciata con tutte le forze in pieno volto a Dio. All’impatto la crosta si era immediatamente sbriciolata e noi tutti, rapiti in un folle orgasmo epico, avevamo pensato che quello era nulla se si voleva fermare Dio, e che Carlos era destinato quel giorno a perdere gli occhi.
In cielo, alle spalle di Dio, tremolava la pallida falce di una luna diurna.
Ma la polvere d’intonaco era entrata negli occhi di Dio, e il colpo, nonché porre fine allo scontro, provocò un distacco della retina per il quale Dio dovette andare bendato da un occhio per quasi tutto il resto dell’anno. Ogni colpa venne addossata a Carlos, che venne sospeso dalle lezioni per due delle altre quattro settimane che avrebbe dovuto passare nell’Istituto: una decisione che oggi, a fronte di tutte le morti di cui Adra è stato direttamente o indirettamente responsabile, appare di nuovo ingiusta, ma perché troppo clemente.
Fu dopo il mancato accecamento di Carlos e la guarigione dalla ferita all’occhio, che a Dio venne la passione per il disegno.
***
L’ultimo anno in cui Carlos fu da noi era ormai cresciuto tanto che quasi non ci stava più, tra i rami del bosso. Nelle settimane in cui il luna park rimase da noi ci aveva parlato di nuovo un’ultima volta di sua sorella, la strega senza una mano. “Vive sottoterra,” ci aveva detto con la sua nenia, “Vive nei boschi e sugli alberi”. Hanso, ormai pronto per partire anche lui con il una park, era rimasto piccolo, e ora lui e il suo re uno accanto all’altro parevano quelle figure bizantine le cui diverse dimensioni riflettono il diverso rango spirituale o politico, e così ormai li ricordo, un mosaico d’oro in cui un re e il suo funzionario mi guardano di sotto una stilizzata cornice di bosso.
Carlos un giorno aveva tirato fuori uno strano pezzo di ferro, come una banda di metallo scuro ripiegata su di sé, quella che poteva sembrare una specie di grossa fibbia o di ganghero. Il pezzo di ferro era arrugginito e come incrostato di sale e Carlos ci aveva detto che era molto antico, e che veniva dalle miniere di ferro sulle isole da cui aveva avuto origine, migliaia di anni fa, la sua famiglia. Poi si era sfilato la cintura dai pantaloni e ci aveva fatto vedere come farla passare attraverso il pezzo di ferro in modo da assicurarselo al fianco, e subito tutti ne avremmo voluto uno anche per noi, anche senza sapere a cosa sarebbe potuto servire, solo per farci passare attraverso la cintura e tenerselo al fianco.
“Serve per attaccare la roncola,” ci aveva detto Carlos, e aveva preso un pezzetto di mattone dalla polvere e era passato di nuovo sopra i contorni della prima roncola che aveva disegnato sulla lastra di cemento che faceva da pase per il muretto che separava i due cortili, la roncola con cui sua sorella si era dovuta mozzare la mano. “Mia sorella la tiene sempre agganciata alla sua cintura quando va nei boschi, per difendersi dai lupi o per tagliare i rami o le braccia dei nemici,” ci aveva detto Carlos, “quando è appesa al gancio la roncola ti arriva fin qua,” aveva detto portandosi una mano al ginocchio.
Dio, ormai perennemente immerso nei propri disegni, aveva alzato gli occhi solo una volta, dai gradini che dividevano i due cortili dove di solito si sedeva con i fogli e le matite, ed era stato solo per il rumore che avevamo fatto quando Carlos ci aveva detto che sua sorella monca girava per i boschi e sottoterra indossando la cintura con appesa la roncola, ma per il resto era completamente nuda.
Carlos sorrideva in silenzio mentre gridavamo e ridevamo, un sorriso che si allargava fino a far capolino ai lati della mascherina e che pareva sul punto di spaccargli la testa in due, quasi sua sorella fosse scesa, scivolando come un magro serpente bianco lungo il tronco del tiglio e lungo il gradino che portava al bosso, e gli avesse vibrato un colpo di roncola attraverso la larghezza della bocca.
Non resteranno che queste streghe nude e alte come alberi, con le loro spade e le loro mutilazioni.
Carlos sorrideva vedendoci impazzire per la donna mutilata.
Una donna che corre nuda in un bosco, ai fianchi appunto una cintura di pelle con agganciata una roncola, è anche la prima immagine del suo primo film, che Adra avrebbe girato una decina di anni più tardi di quell’ultima volta sotto il bosso, film incompiuto e cui Adra non diede nessun titolo ma che è noto tra i critici come Il buon giorno, dal proverbio «Il buon giorno si vede dal mattino» pronunciato da uno dei personaggi. L’iniziale sequenza della donna nuda con la roncola non ha nulla a che fare con il resto del film; da come la storia procede lo spettatore è autorizzato a credere si tratti di un sogno della protagonista, ma le ipotesi a riguardo proliferano tutt’ora.
La donna con la roncola si arrampica su un albero e con un colpo secco della lama decapita uno scoiattolo. È, a quanto è dato sapere, la prima morte filmata da Adra. La cinepresa non riesce a cogliere gli ultimi istanti di vita dell’animaletto, il rigirarsi spaesato degli occhi ormai separati dal corpo, il tremore di una zampina, l’accovacciarsi innaturale e un po’ esilarante del corpo decapitato. Sarà questo uno degli atroci rovelli di Adra nel corso della sua “carriera”: catturare l’irripetibile passaggio alla morte, l’ineffabile «scolorar del sembiante», secondo una delle sue citazioni favorite, l’irreparabile grigiore che scende sull’incarnato di chi muore, lo spegnersi della vibrazione dell’occhio.
La donna con la roncola ha un corpo androgino e molto magro. la muscolarità nervosa di un adolescente jugoslavo. Gli occhi sono sereni, celesti benché scuri, e così il sorriso sempre nascente, mai aperto, e la linea quasi a pastello del corpo sul punto di svanire nel cielo o nel bosco dietro di lei. Questo quando vediamo il volto di lei, magro e lungo, calmissimo, ma la telecamera si sofferma poi con freddezza architettonica su ogni altra parte del corpo nudo della donna, che in questo gelo spietato finisce per apparire ancora più fragile e poetico. La linea nera della roncola, come una virgola beduina di guerra, scintilla al sole quando la donna infine impugna di nuovo l’arma e si inoltra tra gli alberi fino a sparire alla vista. A questo punto un’altra donna apre gli occhi, o meglio uno degli occhi, dato che l’altro è bendato. Si guarda intorno: è in un letto d’ospedale. Accanto a lei uno sconosciuto le tiene la mano. Le dice di essere suo marito, le mostra fotografie di loro due insieme. La donna non lo riconosce.
L’ultimo anno in cui fu all’Istituto, Carlos si divise tra il bosso e le grate che proteggevano i piani sotterranei, quelli degli archivi, e un paio di volte fu sorpreso mentre insieme ad Hanso cercava di sollevare una di quelle grate. La mattina quando arrivavamo ci capitava di vederlo in piedi sulle grate, a cercare di sbirciare attraverso le finestre annerite dei sotterranei dell’Istituto. Diceva che in sogno gli era stato rivelato che i sotterranei dell’istituto contenevano delle statuine nere con occhi di cristallo che luccicano al buio e non si chiudono mai, una statuina per ciascuno di noi che ci fissa sempre attraverso le pareti e le radici dei tigli e i cancelli, non importa quanto lontani possiamo andare, ma quasi nessuno ormai lo ascoltava più.
Carlos e Hanso ora non stavano quasi più sotto il bosso e giocavano insieme nel cortile più basso, una specie di lotta acrobatica che Carlos aveva imparato dai clown del luna park. Carlos, già quasi alto come un adulto, si caricava sulle spalle il piccolo Hanso ridendo quel suo sorriso di traverso la mascherina, e un giorno mentre erano così avvinghiati aveva sollevato Hanso sopra di sé e prendendolo per le caviglie gli aveva fatto fare una specie di mezza capriola alla fine della quale il bambino aveva violentemente sbattuto la nuca contro il terreno. Carlos sorrideva tuttavia, tenendo la mano di Hanso seduto per terra, quando era arrivata l’ambulanza. Anche Hanso sorrideva, ma alcuni giorni dopo mentre camminavano insieme verso le grate sopra le finestre degli archivi aveva fatto una strana giravolta e aggrappatosi al muro subito prima delle grate aveva vomitato. Quando poi le carrozze del luna park ripartirono, tutti avevamo finalmente potuto vedere che gli zingari avevano preso Hanso con loro.
Oggi che la città è stata abbandonata mi sarebbe facilissimo sollevare le grate e scendere nei sotterranei, dove forse troverei un terzo cortile, e le bambole voodoo con cui il personale del Pio Istituto di San Satiro aveva cercato di infettarci. Le esplosioni degli ultimi attacchi hanno fatto crollare parte del muro portante dell’ala più recente dell’Istituto, ma sulla lastra di cemento armato che separa il cortile dei tigli da quello del bosso si può vedere ancora il contorno tenue di una roncola.
Quando per l’ultima volta gli avevamo chiesto se era vero che lui e i suoi non volevano una casa per loro e non volevano restare fermi in nessun posto mai, Carlos senza rispondere ci aveva fissato con i suoi grandi occhi a forma di pesciolini d’oro, e si capiva che dietro la mascherina stava sorridendo, ma non di felicità.

[continua il 22 luglio]

 Presiden arsitek/ 17 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 17 - Angelo Angera Abracadabra Maradona - Angelo Angera
Abracadabra Maradona - Angelo Angera Presiden arsitek/ 32 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 32 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 11 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 11 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 35
Presiden arsitek/ 35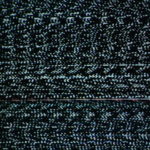 Presiden arsitek/ 21
Presiden arsitek/ 21 Presiden arsitek/ 26
Presiden arsitek/ 26 Presiden arsitek/ 48
Presiden arsitek/ 48





















