
Chi è dunque Gianni Sherwood? Poiché in nessun modo quello può essere considerato il suo vero nome, è necessaria una seconda, vera identità per costui.
E se fosse uno qualsiasi dei personaggi qui apparsi? Se fosse Miloš, se fosse Decor, se fosse il presidente architetto in persona, o magari suo figlio? Non lo sappiamo: letteralmente non lo sappiamo. Non sappiamo nulla. Come in una forma di vita qualunque, ciò che dà forma è il non sapere stesso, ininterrottamente non sapere, poiché ogni forma di vita ha in quanto vita un lato che le resta invisibile, cosa credi, hai un bell’asserragliarti in una foresta di occhi meccanici, hai un bel denudarti strato dopo strato, via la giacca, via i pantaloni, via le mutande e via la pelle e i muscoli e la carne, e sistemare tutto in bell’ordine, sì, ciao, ma l’ordine non è che la maschera mortuaria della forma di vita, e quindi siamo di nuovo daccapo, come in questo specifico caso (ma la vita è esattamente questo specifico irriducibile caso, sempre): chi è Gianni Sherwood?
E c’è poi da considerare quella diciamo morte e resurrezione che è l’amnesia (considerazioni dell’architetto sull’opportunità di dotare le macchine di un congegno di elettroshock per indurre una breve perdita di memoria nei viaggiatori, opportuna per ovviare ai disturbi della personalità derivanti dal viaggio; M dopo i viaggi trova taccuini laceri in cui trova estratti di tali considerazioni e viene colto dal dubbio atroce di aver subito un elettroshock, nient’altro che un elettroshock, altrimenti perché ricordare gli avvenimenti futuri in modo così confuso? poi gli viene in mente della morte del padre) – e ci soccorre qui ancora una volta il carnevalesco (ma amato fino a strapparsi la faccia dal cranio, come amava dire artigliandosi un orecchio quasi appunto a strapparsi di dosso la maschera della faccia) Dante di Sommariva. Tutti ricordano le lacrime che Sommariva non riusciva mai a trattenere parlando dell’inizio e della fine della Commedia, io non so ben ridir, ma già… non sapeva pronunciare quelle due parole, ma già, senza sciogliersi in pianto, nasce e torna nell’incosciente, diceva Sommariva, e Gianni Sherwood non è poi differente: germogliato come malanno nervoso in chissà più chi, e destinato a risprofondarvi casomai intervenga una completa guarigione.
Eccolo per esempio seduto su una panchina mezzo sepolta dalla neve. Gianni Sherwood.
Due sequenze di orme partono dal punto in cui è seduto: cos’è dunque avvenuto? E cosa scrive sui suoi taccuini tutto il giorno? Non l’hanno ancora ricoverato, ma presto lo faranno, e la prima cosa che gli porteranno via saranno i taccuini. Gianni Sherwood guarderà i suoi taccuini sparire nelle tasche bianche dell’inserviente di turno all’Istituto, gli occhi azzurro-bianchi come quelli di un cieco privi di ogni passione per quei fogli di carta.
Nessuno, beninteso, si occuperà minimamente di quei taccuini, ma per decreto del Ministero Austroamazzonico della Sanità Mentale e della Cultura (MASaMenCul) è severamente vietata ogni forma di scrittura ai ricoverati presso gli Istituti Culturali di Sanità Mentale (IsCulSaMen); decreto emanato a seguito del diffondersi della cd “Infezione NITA™”, infezione che com’è noto si manifesta in forma di una grafomania patologica avente per oggetto «qualunque cosa, letteralmente qualunque cosa, ma mai la realtà», così uno dei comunicati diramati dal MASaMenCul subito a vario titolo dileggiato da-lle e ne-lle e tra-lle Psyche® dell’intero Empyrean™ locale: «ma mai la realtà», giusto! Come se al MASaMenCul avessero non dico il bandolo, ma almeno una festuca dell’arazzo indemoniato che chiamiamo la realtà! Come se non parlare della realtà fosse un reato! Giusto! Il reato di lesa realtà! E cos’è poi la realtà, attaccavano i più pensosi della famiglia, sprofondando dipoi in narcibirintiche meditazioni che il più delle volte finivano per sfociare nel gran mare del politico e del dematerializzato, e a quel punto chi più ne ha, una casistica e un’acribiofilia da tomisti sovreccitati e, ora che le Psyche® sono state riconosciute e denunciate quale criptocrimine contro l’umanità possiamo anche dirlo anche se in ogni caso lo dicevano anche allora – inascoltati almeno quanto noi ora – , sovreccitati e insomma tossicodipendenti, tontomisti cui durante una rissa da taverna avessero con un cazzottone sulla nuca irrevocabilmente scompaginato il sequitur: ma anche costoro, caracollando tra le vetraglie colorate della loro metafisica bacata, stringi stringi e a dispetto dei loro sforzi pure notevoli di issarsi alla mensa di non so che filosofale tête-à-tête, si univano al berciamento generale, come tutti gli altri gallinastri appollaiati sui trespoli dell’Empyrean™ che erano fin dalla nascita stati educati a considerare la loro casa. Giusto! Quale realtà e realtà! Quale casa e casa! E quale Gianni Sherwood, rimbecchiamo daccapo noi sparnazzando le nostre alucce smerdate di petrolio, e di petrolio iridescenti, sfiatando come oboi spezzati dal nostro becco di cormorano: quale Gianni Sherwood? La metafisica è tutta qui: il rovello dell’esistere: l’albero della conoscenza: fin la salvezza: Gianni Sherwood accoccolato su quella panchina innevata, le chiappe ormai bell’e fradice di neve come si fosse più volte pisciato addosso. Chi è? Dalla vetrina della libreria Tomasi una ragazzina che pare una marionetta di fiammiferi sbircia la panchina nascondendosi un po’ per gioco un po’ per paura dietro le copertine dei best-sellers come di tra le fratte di una boscaglia di spade. Chi è? Chi è? Chi è? Si chiede la ragazzina, e quasi senza accorgersene alza la mano sopra la testa perché la marionetta di fiammiferi vorrebbe prendere la mano di suo papà e farsi dire chi è ma non mica per saperlo davvero, chi è, no, sarebbe solo per tenere quella mano così grande che lei con la sua riesce a malapena a stringere tre dita, e sarebbe solo per sentire le chissà quali stramberie che suo papà tirerebbe fuori per risponderle, la sua voce così bassa e scura che a malapena sembravano parole quelle che gli uscivano di bocca, anzi, nemmeno uscivano dalla bocca, quando il papà le parlava così, la sua mano accoccolata dentro la sua, era più come se risucchiasse in bocca la carne azzurra del cielo e la facesse scendere nello stomaco insanguinandola e incordandosela nei nervi fino a farne vibrare le ossa della mano e gli ossicini della bambina, e le parole vibravano tra l’uomo e la bambina finalmente liberate dal fardello del significato, non più necessario perché troppo superficiale rispetto al puro mistero del suono azzurro del padre e della vibrazione delle ossa di fiammiferi della bambina. Chi è? Chi è? Chi è?
La ragazzina allunga la mano sopra la testa ma ormai la ragazzina si è allungata così tanto che se davvero ci fosse un papà accanto a lei tale da dover alzare la mano sopra la propria frangetta per prendere la sua, dovrebbe essere un gigante da starsene piegato in due dentro la libreria Tomasi, nella sua mano i libri non più grandi di una scatola di fiammiferi. Nessun papà diventa mai un gigante ed è questa l’unica ingiustizia della vita, e senza più nessuno a inghiottirlo, l’azzurro cola come una tonnellata di tonnellate di cemento soffocando la ragazzina. Chi è? Chi è? Chi è?
La neve ha cominciato a marcire ma tutto è ancora bianco e ci sono ancora le due tracce di passi, una che arriva alla figura accoccolata, l’altra che se ne allontana. Sotto la panchina, marcendo la neve ha rivelato il corpo di un pappagallo morto congelato nella bufera, fradicio come fosse appena uscito da un ventre mammifero.
Da dietro una seconda finestra, al secondo piano del Pio Istituto di s. Satiro per l’Educazione del Fanciullo, don Giorgio Giorgio sta osservando anche lui la figura sulla panchina, e le due file di orme nere che come formiche partono dalla figura e vanno una da una parte e una dall’altra.
Per farlo addormentare, la madre di Gianni Sherwood raccontava spesso al figlio delle fiabe inventate che avevano per protagoniste delle formichine che per un motivo o per l’altro si ritrovavano ogni volta perdute al proprio formicaio, che immancabilmente ritrovavano dopo mille peripezie attraverso luoghi che la prospettiva minuta dell’insetto rendeva alieni al bambino, e il clou della fiaba era il momento in cui il bambino con uno strillo scioglieva quegli indovinelli topografici.
– Non era una foresta di alberi neri senza rami, era la testa di qualcuno, e gli alberi erano i capelli!
– Non era una lastra di ghiaccio caldo che stava cadendo dentro il Sole, era il finestrino di un’automobile!
– Non era una palude senza uscita in mezzo a un ghiacciaio, era un’orma nella neve!
A furia di indovinare e indovinare, la camera del bambino che un giorno sarebbe diventato Gianni Sherwood finiva per pullulare di uno sbriciolato formicaio di fiabe, e ogni angolo della camera si faceva alla fantasia sovreccitata dal sonno – la fantasia che il sonno faceva sbucare dal cranio del bambino come un cobra che sale dal cesto di un fachiro indiano – del bambino un ammasso galattico a sei facce irto di misteriosi templi le cui colonne erano distanti ore di cammino e le cui volte erano talmente alte da essere invisibili, deserti bianchi dove gruppi di formiche esploratrici finivano per perdere la ragione nella disperata ricerca di un qualsiasi punto di riferimento, deserti capovolti sopra un cielo inverso di continenti variopinti e in continuo movimento, deserti bianchi sui quali le zampine delle formiche non lasciavano alcuna impronta che potesse aiutarle a ricostruire il loro cammino e al cui centro si erano conficcati soli ardenti che chissà più quale apocalisse aveva fatto precipitare nel bianco. Ma le formiche non lasciavano orme perché erano sole, era sempre nella solitudine e nell’abbandono che nascevano le fiabe che la madre di Gianni Sherwood raccontava ogni notte al bambino che sarebbe diventato Gianni Sherwood, e abbandonate erano le formiche che pullulavano poi nella camera del bambino lasciando dietro di sé tracce iridescenti che solo il bambino riusciva a vedere nella tenebra come linee di grottesche che tracciavano i confini della tenebra prismatica in cui si convertiva la sua camera di notte, ma le formiche abbandonate non potevano vedere quelle tracce, perché per la formica la traccia è la formica che ha dietro di sé, e dietro di sé e dietro di sé ancora, fino a che non c’è nessun dietro di sé che non sia l’architettura da incubo del formicaio e il terrore invisibile della formica regina, ecco perché vanno in fila attaccate l’una all’altra, per non perdersi, ciascuna formica è la briciolina di pane dell’altra, e se nessuna si allontanerà dalla propria fila tutte quante riusciranno prima o poi a tornare a casa.
Nell’ombra notturna della cameretta del bambino da cui già strisciavano fuori gli artigli fetenti e appiccicosi di Gianni Sherwood un volto di lamia, di antidiluviano rettileo scimpanzé. Spaventapasseri con gli occhi azzurri e ectoplasma rosa che piove dalla nuca come una chioma. Zampa di capra, ombra di zebra versicolore fantasma. Volti di lupi e mostri sulla nuca, volti come nuche. Orecchi come occhi. Seminatori morti di fame come eleganti sonnambuli nel cielo che mette a notte. Il telaio come ingranaggio di legno (zoccoli inclusi) che fa la tela. Sporgono oltre tenaglie di cervo volante. Volti come grovigli digitali. Crani che paiono trapanati. Fiori estivi come cervelli di vitello o di gatto, e viceversa. Nido bulbo oculare. Pedinati da alberi nel crepuscolo. Cielo segmentato in rettangoli. Pelle del volto orbita intorno all’occhio come pelliccia di volpe, licantropia benigna, e il cielo catturato nella pelliccia e nella rotazione, e con lui la luce morente in scintille stellari: e come petali di camomilla. Il momento del giorno in cui i colori si congedano, e irradiano raggi violetti quasi impossibili all’occhio umano, all’occhio vivente: li vede l’occhio del nido, dell’orecchio, del cranio trapanato. Labbra foglie insanguinate di pungitopo. Covoni torsi mutili di leoni. In dono sensibilità e quasi irritabilità per le nuance cadaveriche e fosforescenti delle persone, le fluorescenze dei luoghi e delle cose, le muscolarità celesti: il dio del cielo. Linee prospettiche come tagli nella carne dello spazio. Il bambino adesso dormiva.
Don Giorgio Giorgio non può vedere la ragazzina che insieme a lui sta guardando Gianni Sherwood, né la ragazzina lui, ma la ragazzina ogni volta che entra nella libreria dove è stata assunta ricorda la scuola e i suoi due cortili separati da una breve rampa di sette o otto scalini, il cortile più alto e più grande con i tigli e le minuscole spirali di samare che scendevano in autunno e il nido di vespe che una volta aveva trovato dentro il buco di un tronco, un tremore di sangue che lacrimava dalla corteccia dei tigli, e il cortile inferiore, più piccolo ma aperto da un lato sulla strada e dall’altro all’atrio dell’Istituto, con l’albero di bosso dove stava sempre accoccolato il bambino che un giorno aveva portato via con sé il piccolo Luijgi Decor sulla carovana del Luna Park.
Don Giorgio Giorgio guarda la figura piegata e le sue labbra spariscono tra i denti come se si stesse preparando a suonare un oboe, e anche gli occhi si ripiegano in dentro senza che il sacerdote possa più vedere. “Et non videbitis…” attacca, con automatismo omiliaco, poi come se lo scatto fosse il risultato di un movimento meccanico indipendente dalla coscienza allo stesso modo del battito del cuore tira un pugno contro lo stipite della finestra bestemmiando Dio e la Madonna, il porco e la puttana, così li chiama, e in quel furore con doppio ardore e odio li riadora ancora li ardora e li riardora perché porco, perché puttana, li riadora di riardore, in piedi alla finestra e insieme prosternato come un pappagallo morto ai piedi di Gianni Sherwood sulla panchina, tu Porco e tu Puttana condannati in eterno a un’infinita gloria.
Le due file di orme si allontanano da Gianni Sherwood seduto sulla panchina prendendo due direzioni opposte, e la neve marcia impedisce ormai di capire quale fosse la direzione, se in un verso o nell’altro, quale delle due file fosse quella che viene e quale quella che se ne va, né saperlo spiegherebbe in alcun modo perché Gianni Sherwood sia lì, né tantomeno chi sia, forse però, pensa la ragazzina, quelle orme significano proprio che non è possibile che Gianni Sherwood sia lì, altrimenti ci sarebbe una terza fila di orme, quelle lasciate da Gianni Sherwood per raggiungere la panchina, o forse, pensa don Giorgio Giorgio, una delle due file di orme è quella del Porco e l’altra è quella della Puttana, e tutti e due sono stati pisciati sulla neve da Gianni Sherwood e poi l’hanno abbandonato andando uno verso Jakarta e l’altra verso Venezia, oppure viceversa dalle due città il Porco e la Puttana sono arrivati, e zoppicando nella neve marcia si sono infine incontrati dove era seduto Gianni Sherwood e sono scivolati dentro di lui risalendo lungo il suo volto ed entrandogli nelle orbite come due lacrime inverse, è sempre in forma di lacrima inversa che il Porco e la Puttana si impossessano della razza degli uomini, o forse una di quella fila di orme è mia, pensano don Giorgio Giorgio e la bambina, l’una con la mano ancora alzata come per salutare qualcuno e l’altro ormai in lacrime, ancora ubriaco come quasi ogni giorno da dopo la morte di Sommariva, ubriaco e insonne implorando le due file di lacrime che scendono una da una guancia e una dall’altra di risalire fino ai suoi occhi e scioglierli nelle orbite perché finalmente la luce possa essere accolta, pura e indecifrata, e irriflessa. Una delle due file di orme è la mia, pensano in unisono don Giorgio Giorgio e la bambina, e non va quindi a Venezia / a Jakarta, ma se la potessi districare nel groviglio di orme marcite in cui le due file si smarriscono una volta abbandonata la panchina su cui è seduto Gianni Sherwood, se potessi orma da orma distinguere in quel massacro di neve fradicia, vedrei che la linea che parte dalla panchina arriva fin qui dove sono io, e come nelle inutili soluzioni di Sherlock Holmes (poiché utile sarebbe impedire la morte, non ricostruirne il cammino) sarei forse ancora in tempo per notare le infinitesimali tracce bagnate che ho lasciato dietro di me per arrivare fino a qui dove sono ora alla finestra alla vetrina, così in unisono quasi perfetto don Giorgio Giorgio e la ragazzina. Ma mi ci vorrebbe la pipa e la lente d’ingrandimento, pensa la ragazzina ovvero il papà della ragazzina che come un piccolissimo salmone ha risalito la corrente di lacrime ormai asciutte per accoccolarsi nelle pupille della ragazzina, ti ci vuole la pipa e il berretto da investigatore, ma questo non fermerebbe la morte, servirebbe solo a ricostruirne i passi, pensa don Giorgio Giorgio, il biforcato unisono dei due ora perduto, ciascuno ora su due fili diversi di pensiero, uno che va da una parte e uno dall’altra come nella famosa fuga a due di J. S. Bach che la madre di Gianni Sherwood, questo dopotutto lo sappiamo, suonava su un vecchio Schulze-Pollmann verticale con l’avorio ormai ingiallito dalle sigarette che la donna fumava una dopo l’altra quando suonava, arrivando a accendere la successiva con il mozzicone ancora ardente di quella appena finita, il posacenere che il figlio le aveva decorato con francobolli e ceralacca, sistemato sopra il pianoforte, perennemente semisepolto sotto una piramide di mozziconi spenti che sfarinavano nuvolette di cenere quando la donna suonava con più forza la fuga a due di J. S. Bach per costringere le sue dita ingiallite a ricordare per sempre i movimenti necessari per eseguire la fuga, e Gianni Sherwood che come la madre non aveva il benché minimo orecchio musicale non riusciva né sarebbe mai riuscito a dipanare il semplicissimo e demoniaco contrappunto della fuga a due, e per lui e forse anche per la madre che pure dopo un po’ era riuscita ad eseguire la fuga a due senza errori era rimasto un tormentoso mistero il modo in cui le due voci della fuga, apparentemente identiche quando sua madre le suonava separatamente, si rivelassero poi così differenti una volta unite una nell’altra, né, mistero nel mistero, come ciascuna voce anche quando veniva suonata da sola sembrava talvolta quasi biforcarsi in due nuove voci che pur diversissime erano in realtà la stessa identica voce.
Il vecchio Schulze Pollmann verticale un angolo del quale era ormai irrimediabilmente ingrigito dal perpetuo sfarinare di mozziconi delle sigarette con cui sua madre sembrava voler scandire le proprie esercitazioni aveva un grande ovale sul lato di fronte al pianista, e dentro l’ovale il legno più chiaro era anche più lucido. La madre di Gianni Sherwood quando suonava talvolta guardava nel riflesso e a volte vedeva il figlio che ascoltava con aria ebete le voci della fuga, talaltra ne incrociava lo sguardo, tutti e due gli sguardi diretti nel riflesso del pianoforte, e allora la madre e il figlio si sorridevano. Ma una volta la madre di Gianni Sherwood aveva guardato come tutte le altre volte nel riflesso dell’ovale di legno e aveva visto suo figlio, ma non aveva né l’espressione ebete con cui gli stonati di ogni tempo ascoltano la musica suonata da un altro stonato né il sorriso furbo del bambino che aspetta che la mamma lo veda. La donna aveva visto il figlio girare la testa lentamente di qua e di là, incrociando sì il suo sguardo durante la rotazione ma senza minimamente registrare la sua esistenza. Si era fermata per cercare di osservare meglio il riflesso del volto, mezzo sbiadito nell’opacità del legno, la testa del figlio che ruotando sembrava quasi sformarsi e spappolarsi lungo le piccole imperfezioni della superficie dell’ovale, e allora anche lei aveva cominciato lentamente a girare la testa e si era voltata verso il figlio e lo aveva guardato negli occhi, e da quel giorno aveva smesso di suonare il pianoforte e di studiare la fuga a due, e dopo una settimana il pianoforte era stato venduto, e dopo un mese la donna era scesa in cantina, si era versata addosso una tanica di benzina e si era data fuoco. Nel pieno dell’infezione NITA™, la morte della madre di Gianni Sherwood si era persa tra le migliaia di altri suicidi che si stavano manifestando in quei giorni.
Le orme che dalla libreria in cui lavora la marionetta di fiammiferi arrivano sino al punto in cui Gianni Sherwood è seduto perfettamente immobile potrebbero dunque essere state tracciate dalla ragazzina stessa: è dunque, ossia era la ragazzina Gianni Sherwood? e come un granchio in muta sarebbe uscita dal corpo ormai rinsecchito e svuotato di Gianni Sherwood abbandonandone il guscio sulla panchina e insieme dimenticando ogni momento della sua vita da Gianni Sherwood. La marionetta di fiammiferi è perciò la morte di Gianni Sherwood, ossia la sua scorticazione? O forse le orme sono una traccia che la ragazzina dovrà percorrere una volta uscita dalla libreria, come un percorso di fox-trot con cui raggiungere l’ombra rinsecchita di Gianni Sherwood, accostarvisi e lasciarsene risucchiare, rendendole la vita e facendo ritornare il malato nell’Istituto per la Salute Mentale e Grammaticale del Cittadino (ISMenGraC). E così dall’altra parte di questo piccolo cosmo (ma dentro uno spazio infinito quale importanza può mai avere la grandezza?) don Giorgio Giorgio – che a furia di tenersi le labbra fra i denti ha finito per tagliarsele e ora con halloweenistico effetto di vecchio vampiro da quattro soldi sta perdendo da un lato della bocca un rivo sottile di sangue chiarissimo, quasi latteo – si chiede a propria volta se quelle orme non siano in effetti le sue, dato che anche lui come Gianni Sherwood ora spesso si siede a quella panchina, e dunque, meno allucinatoriamente, meno visionariamente poiché nessuno è meno visionario di chi ha fede, dunque magari ecco qua: anche se non lo ricorda, don Giorgio Giorgio potrebbe benissimo aver attraversato lo strato di neve che sotto i quattro occhi suoi e della ragazzina, e gli altri quattro del pappagallo morto e di Gianni Sherwood (sull’esser ancor vivi dei quali cominciano, lungo le orme nere che si allargano e sformano nella neve putrida, a serpere dubbi), don Giorgio Giorgio potrebbe benissimo essersi fermato un po’ a sedere sulla panchina come gli è già capitato innumerevoli volte di fare in passato, e più una cosa la fai e rifai meno riesci a ricordare il momento esatto in cui l’hai fatta l’ultima volta. Potrebbe benissimo essersi seduto sulla panchina, e poi rialzato per raggiungere l’Istituto dal cui secondo piano sta ora osservando la figura di Gianni Sherwood appollaiata ormai da ore sulla panchina senza mutare posizione, ma è quello che fanno i pazzi. Don Giorgio Giorgio potrebbe benissimo essere arrivato alla panchina prima che Gianni Sherwood vi si sedesse, essersi fermato qualche minuto o qualche ora, non è poi importante, per poi ripartire verso il cancello che dà sul cortile basso del Pio Istituto di s. Satiro (PIsS). Ma come è arrivato lì Gianni Sherwood, come se n’è andato da lì don Giorgio Giorgio? Potrei essermene andato, pensa di sé don don Giorgio Giorgio, poi una seconda nevicata ha coperto le mie orme, e solo allora è arrivato Gianni Sherwood. Ma così siamo daccapo, perché com’è possibile che Gianni Sherwood sia arrivato lasciando sulla neve due file di orme divergenti? Perché ciò potesse accadere Gianni Sherwood dovrebbe essere il risultato della fusione di due persone, venute una da una parte e una dalla parte opposta e datesi convegno sulla panchina per fondersi insieme in Gianni Sherwood, strana bestia a due schiene e quattro occhi.
Una specie di cicatrice sulla palpebra superiore scendeva a coprire parte dell’occhio sinistro della ragazzina dandole un aspetto di bambola difettata che la curva quasi sovietica tra la nuca e il biancore delle guance e la frangetta rendeva ancora più dolce e insieme glaciale, e si indovinava una seconda cicatrice che dalla base del collo scendeva verso il basso. I racconti della ragazzina su quelle due cicatrici si erano costruiti nel corso del tempo, e coprivano un po’ tutta la gamma di storia dal quasi fiabesco all’iperrealistico fulmine o persino – se l’interlocutore le appariva ingenuo o molesto – meteorite caduto accanto lei che si era salvata per miracolo; lancio di acido perpetrato da un fidanzatino criminale – storia che a propria volta poteva ramificarsi in una foresta di varianti che di nuovo a chi avesse saputo la verità su quelle cicatrici –– verità di cui noi al momento siamo all’oscuro –– avrebbe potuto riconoscere un grafico del luogo psichico che il destinatario del racconto occupava per lei: l’acido poteva essere destinato a lei, che aveva allora evitato in tempo la quantità maggiore; ad una sua amica, che lei avrebbe allora – più o meno proprio malgrado – riparato da parte del getto; ad una passante sconosciuta, cui il suo volto avrebbe offerto parziale schermo – ed ecco ramificazioni di ramificazioni intorno a questa passante, che da quel momento poteva essere diventata sua carissima amica, o nella quale altre volte poteva riconoscere una mai più incontrata compagna d’asilo / lontana cugina che tutti credevano fosse scomparsa e invece era finita tra le grinfie del mostriciattolo che l’aveva appena sfregiata / una sorella di cui ignorava l’esistenza e che i suoi genitori avevano, prima che lei nascesse abbandonato presso… –––– le ramificazioni qui potevano capillarizzarsi e frattalizzarsi quasi all’infinito… una cosa da mille e una notte –––– a chi erano destinati quei romanzi delle cicatrici? –––; o viceversa ad un suo fidanzatino, di lei, della ragazzina: e allora eccola confessare la propria folle – ma per quanto ne sappiamo del tutto inventata – gelosia per questo – con ogni verosimiglianza altrettanto inventato… eppure cosa volete, quando lei raccontava, ecco quel fidanzatino immaginario si faceva ricordo e infine carne, e le lacrime che immancabilmente versava durante quella versione erano incontestabilmente reali, e così l’amore e la disperata colpa che sentiva verso di lui, ma dove eravamo, ah già – fidanzatino: ed inesperta nel gesto nonché resa ancor più maldestra dalla rabbia e dal malissimo diretto amore aveva finito, nel lanciare l’acido verso il poveretto, per schizzare anche se stessa – ma ora, sospirava quasi pacificata, vedeva in quello sbaglio una sorta di giustizia –– se giustizia si può trovare in un innocente che per causa sua aveva perso un occhio e la possibilità da quel momento in poi di gareggiare nei tornei di ping-pong / scherma / bocce e chi più frattalicamente ne ha nei quali il fidanzatino di questa versione prometteva di raggiungere livelli eccellenti quando non eccelsi (questa seconda versione la ragazzina la faceva più tardi, in solitudine, mordendo in lacrime il cuscino lasciandosi quietamente devastare da una colpa immaginaria, poiché lei stessa, come è per ogni narratore purosangue, era la prima destinataria di tutti quei racconti, e così nel racconto tutti gli altri destinatari si fondevano in lei, entrando nel suo guscio anche lui accartocciato e immobile su una invisibile ulteriore panchina sepolta da una neve scesa da un cielo non mai creato da nessun Dio, né mai esistito per sé); incidente stradale (epigrafico, normalmente privo di ulteriori ramificazioni); contorti incidenti occorsi durante imprevisti deragliamenti operazioni banalissime ma che effettuate con un minimo errore avevano spalancato sotto di sé i neri crepacci del pericolo (cambio di una lampadina; controllo del livello dell’olio dell’automobile; altalena; fritto misto; rosario; lettura di un quotidiano in biblioteca; in fila per ricevere il corpus Christi – ossia non erano rare le volte in cui la ragazzina andava a bella posta a ficcarsi nel vicolo cieco di situazioni implacabilmente innocue, con lo stesso senso di sfida di un arrampicatore che si cimentasse con una lastra verticale o uno strapiombo: come rimediare siffatte cicatrici sulla cignobarchetta di un Tunnel dell’Amore? o assistendo a una conferenza sui riti di accoppiamento degli uccelli africani? o in un negozio di fiori? ed era come ficcare le dita tra le spesse labbra di cavallo della realtà per cercarne il biancore letale dei denti, insieme godendo un tantino masochisticamente del rischio di non poter imbastire per il destinatario di turno una storiella sufficientemente convincente).
Da ragazzino don Giorgio Giorgio aveva rimuginato per un po’ la possibilità di scrivere un racconto nel quale il protagonista ripercorre di continuo tutta la propria vita senza mai a riuscire a capire il perché in quel momento, nel momento cioè in cui il protagonista racconta la propria vita, si trovi proprio lì poniamo in quella certa città, o a svolgere quel certo lavoro, o circondato da quella certa famiglia… chissà che Gianni Sherwood là seduto su quella panchina non si ritrovi in una condizione simile – poiché è legge universale che qualsiasi sia il racconto, che venga scritto oppure no, ma nel momento in cui emette anche solo tra le pareti di un singolo cranio la propria traccia umida e fosforescente, quel racconto diventa esca irresistibile per la realtà: che immancabilmente, da quella carpa rimbambitona che è, lo inghiotte gnaffete, e lo fa proprio, per solito con sommamente malo destro, come un pessimo registra maltratterebbe un ottimo canovaccio –– item, le storie della ragazzina con le sue cicatrici erano come altrettanti sortilegi che lei liberasse nella foresta e nei vicoli di Jakarta e Venezia e ogni altra città di questo e qualsiasi altro pianeta – che fosse rimasto lì paralizzato, Gianni Sherwood, davanti a quelle due file divergenti di orme che contrario motu si dirigevano l’una verso una libreria l’altra verso i cancelli di un Istituto Grammaticale o quel che è, anche lui, Gianni Sherwood, irretito nelle infinite ramificazioni di quelle tracce di cui la neve marcia impediva di riconoscere la direzione, e anche lui, sempre Gianni Sherwood, nell’impossibilità – per lui tanto più frustrante e tragica – di far combaciare alcun lembo del destino che ricordava come proprio con alcuno di quei passi sulla neve, né tantomeno con il fatto di essere (lui, lui, sì, lui, ma cazzo ma lo vedi o no? Gianni Sherwood) seduto proprio lì, su quella panchina, in quella periferia di quella città. E forse all’inizio era un passante come tutti gli altri (sta fantasticando ora la ragazzina, e presto anche lei comincerà a rosicchiare quello stesso rabeletico scheletro di storia del don Giorgio Giorgio di tanti anni fa), ed è stato proprio quel dubbio a paralizzarlo su quella panchina a metà di quel filo di orme, e a fargli lentamente rifiutare come palesemente impossibile il destino che di sé ricordava e che considerava proprio, ed è allora proprio per via di quelle due file di orme divergenti che lo sconosciuto e ormai anche a sé sconosciuto passante è infine diventato Gianni Sherwood, tanto che in certo modo (adesso però è don Giorgio Giorgio, che con automatismo omiletico sermoneggia) si potrebbe dire che Gianni Sherwood non è tanto una persona quanto la traccia di due file di orme che divergono sulla neve marcia, e che qualunque malcapitato che si fosse trovato al posto della persona che ora è lì e che come ciascuno sa risponde al nome di Gianni Sherwood, sarebbe per il solo fatto di trovarsi lì anche lui (o lei, freme qui la ragazzina sfiorandosi la cicatrice sul collo come ad ancorarsi con più certezza a sé – ma a furia di inventare racconti sulle cicatrici non rischia anche lei di ritrovarsi un giorno a fissarle come per la prima volta e a non poter capire in nessun modo perché siano lì?), diventato, di fronte a quelle orme che si biforcano, anche lui, anche io, anche tu, Gianni Sherwood.
Nessuno poi seppe mai bene dire che ne fu del bambino che poi sarebbe diventato Gianni Sherwood dopo il suicidio della madre. La donna frequentava pochissime persone e negli ultimi tempi nemmeno quelle, e con nessuna aveva un legame che andasse oltre le superficie: e in più come s’è già detto si era nel pieno dell’emergenza suicidi spontanei de-i/-lle tester/vittime del videogioco NITA™, e alla morte si faceva un po’ meno caso.
Ma noi qualcosina stavolta sappiamo, sappiamo che il bambino pazzo di terrore si era messo a correre giù per il vicolo Bristol dove abitava con la madre, quasi spezzandosi il collo scendendo a precipizio lungo il selciato quasi verticale del vicolo, e correndo aveva incrociato la propria corsa disperata con l’insignificante corsa di un
tac tac tac tac tac…
ogni tac tac un minuscolo tintinno ti luce lungo il vicolo Bristol che dal villaggio di Newton scende fino alle prime abitazioni che sporgono caotoclastiche dalla matrice verdogna delle liane e dei fiori e dei pappagalli della periferia di Jakarta e poi ancora più oltre quando il cielo è talmente terso che, per esempio, le carte da gioco che tieni in mano – le celebri carte da gioco dell’antico impero cinese di Newton, un tempo valide anche come banconote e oggi trastullo dei piccini – prendano vita, e che i cavalieri e i fanti e i re e le regine siano sul punto di lasciarsi scivolare giù dal biancore niveo della carta e sbrìf, filare via nella polvere del vicolo Bristol come muniti refoli di vento – il campioncino di profumo rotola sul selciato
tac tac tac tac tac…
skriss poi sotto la punta della scarpa di uno zoppo che arranca ridendo contro il sole e le inutili mura con cui ormai quattro secoli fa Jakarta aveva cercato di arrestare l’espansione di Schwarzschwarz…
tac tac tac tac tac…
skriss sotto i piedi del bambino che scappava dalla morte lasciando di sé una fila di invisibili ombre profumate, e dal profumo del cancello in fiore lo inseguiva un abbaiare di cani, impotente e feroce.
***
– Scrive sempre, lo sai?, dice il padrone della libreria alla ragazzina, arrivato alle sue spalle silenzioso come un vecchio leopardo. Fa sempre così e la ragazzina non si spaventa nemmeno più, è come sentire ogni tanto la voce del Grillo Parlante.
– Chi, scrive.
– Come chi, quello lì.
– Ma chi.
– Quello lì sulla panchina, non lo stavi guardando?
– No.
– Scrive sempre, lo vedo.
– Cosa scrive.
– Ha tutto un mucchio di cartacce che si porta dietro, scritte un po’ a penna, un po’ a matita, un po’––
– Ma cosa scrive.
– Allora lo vedi che lo stavi guardando.
– Sì ma––
– Non lo so, non sono mai riuscito a prendergli uno di quei fogli.
– Ci vado io.
– No lascialo stare, non so se––
– Vado.
– Lascia stare…
– Ecco.
– Ma cosa ti ha detto.
– Niente, gli ho chiesto se potevo prendere un foglio e––
– Ma non ti sei pulita le scarpe? Sono piene di neve marcia, guarda, stai inzaccherando–– cosa c’è.
– Che parola è inzaccherare? Non la usano mai.
– Che parola vuoi che sia, è una parola. Vai a pulirti le scarpe.
– È bella però.
– Sì, è bella.
– Ecco.
– Grazie. Ma insomma cosa scrive.
– Ma, niente, mi sembra. Scemenze da matto.
– Fammi vedere.
«Gli accordi finali delle sinfonie classiche come lo stronzo finale che ploffete. Zazàaang… Zà-Zàaaaaaaang… e ploffete, yogurt ai mirtilli.
Ascelle a Shangai più / Un’armata di liutai / Che ti perseguita da qui a Berlino.
Muove uova uovaman / Sotto il filo degli elfi.
Nessun gatto si occuperà di me.
Chiedi a mia sorella quante volte litighiamo io e i miei, chiedi a mia sorella come ero, certe cose che ho fatto con te, ora non gioco più tutto il giorno, faccio musica e fumo, sei l’unica delle mie ex che–– no ma ti giuro chiedi a mia sorella.
È vita questa? Ti svegli e un araldo medievale arabo annuncia pubblicamente il contenuto dei tuoi sogni. No dico ti pare vita questa?
Un araldo di carne macinata sbarra la frutta con le orecchie tra i capelli.
Santa Lucia ti vede con le nacchere, che usa come rudimentali sonar per captare la presenza di corpi davanti a lei.
Il rumore dell’ombra che striscia sul muro, sintomo inconfondibile di infezione in corso, cammini e dietro di te senti qualcosa strisciare, ed è la tua ombra, ormai infettata, che ha cominciato a farsi carne dalla tua carne.
Una sala di sale disegnata da serpi.
Maschere esplosive in sacrestia».
– Perché piangi?
– Non lo so, è pieno di fogli così, mi fa triste pensare che ha scritto tutti quei fogli così, pieni di cose come, come di cretinate. Mi fa––
– Ma magari per lui non sono cretinate.
– Ma dai, cosa c’entra, è lo stesso, sono cretinate lo stesso. Sono cretinate. È bruttissimo. È––
– Dai, non piangere. Stai tranquilla. Vuoi andare a casa?
– No.
– Vuoi riportargli il foglio?
– Sì. Sì.
«“Andare a caccia è uno dei miei sogni più grandi, un po’ come trovare il “principe azzurro”,” disse la Cavaliera facendo coi ditini appiccicaticci di sangue di lepre il gesto delle virgolette e con l’occhio l’occhiolino al principe; “Il problema,” rispose questi facendo cucù da dietro il proprio mantello, “è che se mi innamoro di una persona irreale e non riesco a trovarla nel mondo reale poi cado in depressione e cerco di suicidarmi per raggiungere quella bella “ragazza immaginaria””. Si dice che i due siano ancora fermi così, l’uno di fronte all’altro, in eterno paralizzati nel gesto delle virgolette, al centro del regno».

[continua l’11 dicembre]

 Presiden arsitek/ 6 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 6 - Angelo Angera L’arte di travisare Agamben - Angelo Angera
L’arte di travisare Agamben - Angelo Angera Presiden arsitek/ 46 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 46 - Angelo Angera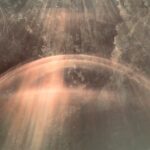 Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera
Presiden arsitek/ 42 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 32
Presiden arsitek/ 32 Presiden Arsitek/ 18
Presiden Arsitek/ 18 Presiden arsitek/ 40
Presiden arsitek/ 40 Ci mancano i meloni di mamma
Ci mancano i meloni di mamma





















